
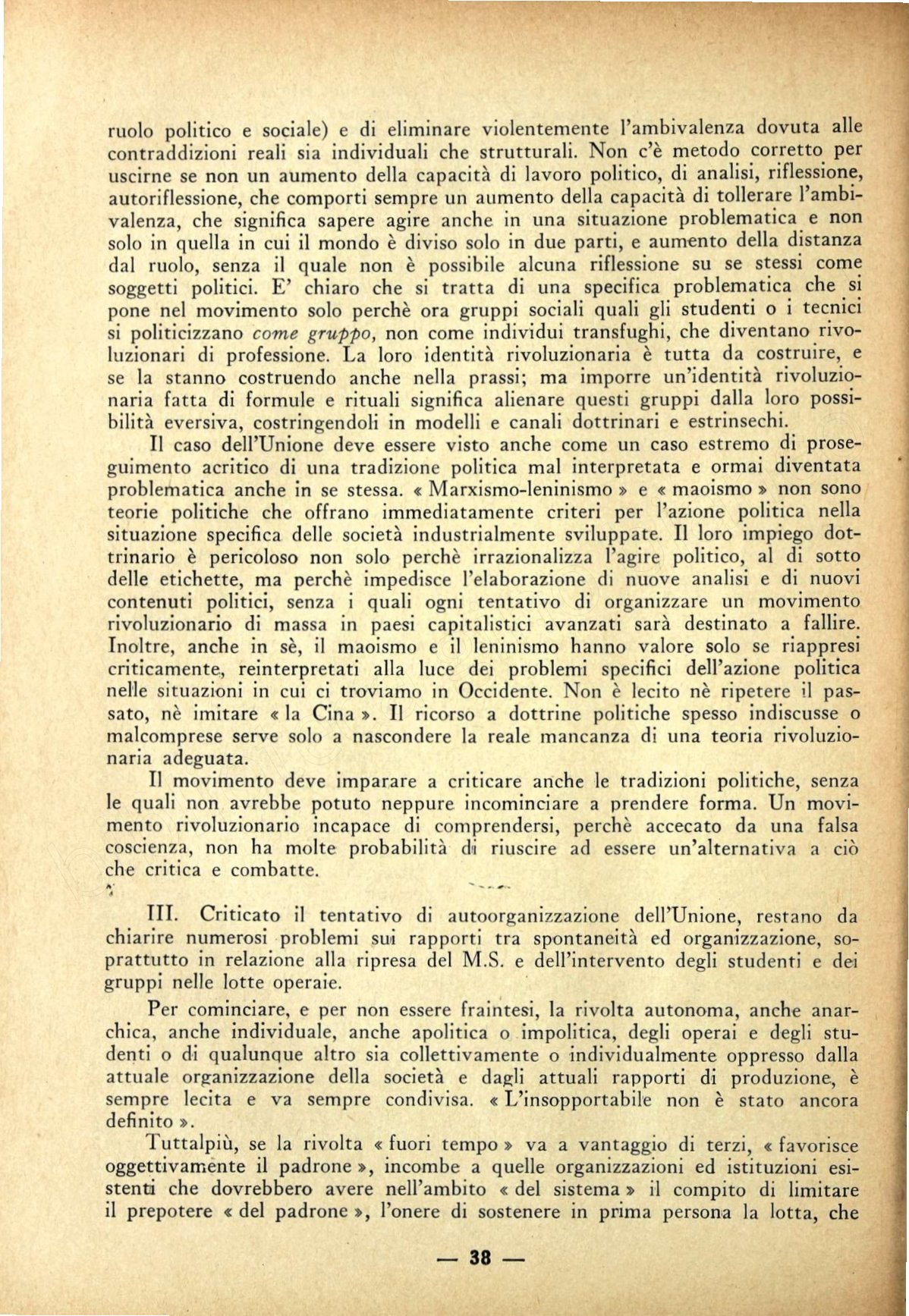
ruolo politico e sociale) e di eliminare violentemente l'ambivalenza dovuta alle
contraddizioni reali sia individuali che strutturali. Non c'è metodo corretto per
uscirne se non un aumento della capacità di lavoro politico, di analisi, riflessione,
autoriflessione, che comporti sempre un aumento della capacità di tollerare l'ambi-
valenza, che significa sapere agire anche in una situazione problematica e non
solo in quella in cui i l mondo è diviso solo in due parti, e aumento della distanza
dal ruolo, senza i l quale non è possibile alcuna riflessione su se stessi come
soggetti politici. E ' chiaro che si tratta di una specifica problematica che si
pone nel movimento solo perchè ora gruppi sociali quali gli studenti o i tecnici
si politicizzano
come
gruppo, non come individui transfughi, che diventano rivo-
luzionari di professione. La loro identità rivoluzionaria è tutta da costruire, e
se la stanno costruendo anche nella prassi; ma imporre un'identità rivoluzio-
naria fatta di formule e rituali significa alienare questi gruppi dalla loro possi-
bilità eversiva, costringendoli in modelli e canali dottrinari e estrinsechi.
Il caso dell'Unione deve essere visto anche come un caso estremo di prose-
guimento acritico di una tradizione politica mal interpretata e ormai diventata
problematica anche in se stessa. « Marxismo-leninismo » e « maoismo » non sono
teorie politiche che offrano immediatamente criteri per l'azione politica nella
situazione specifica delle società industrialmente sviluppate. I l loro impiego dot-
trinario è pericoloso non solo perchè irrazionalizza l'agire politico, al di sotto
delle etichette, ma perchè impedisce l'elaborazione di nuove analisi e di nuovi
contenuti politici, senza i quali ogni tentativo di organizzare un movimento
rivoluzionario di massa in paesi capitalistici avanzati sarà destinato a fallire.
Inoltre, anche in sè, i l maoismo e i l leninismo hanno valore solo se riappresi
criticamente, reinterpretati alla luce dei problemi specifici dell'azione politica
nelle situazioni in cui ci troviamo in Occidente. Non è lecito nè ripetere i l pas-
sato, ne imitare « la Cina ». I l ricorso a dottrine politiche spesso indiscusse o
malcomprese serve solo a nascondere la reale mancanza di una teoria rivoluzio-
naria adeguata.
Il movimento deve imparare a criticare anche le tradizioni politiche, senza
le quali non avrebbe potuto neppure incominciare a prendere forma. Un movi-
mento rivoluzionario incapace di comprendersi, perchè accecato da una falsa
coscienza, non ha molte probabilità d riuscire ad essere un'alternativa a ciò
che critica e combatte.
A
-
III. Cri t icato i l tentativo di autoorganizzazione dell'Unione, restano da
chiarire numerosi problemi sui rapporti t ra spontaneità ed organizzazione, so-
prattutto in relazione alla ripresa del M.S. e dell'intervento degli studenti e dei
gruppi nelle lotte operaie.
Per cominciare, e per non essere fraintesi, la rivolta autonoma, anche anar-
chica, anche individuale, anche apolitica o impolitica, degli operai e degli stu-
denti o di qualunque altro sia collettivamente o individualmente oppresso dalla
attuale organizzazione della società e dagli attuali rapporti d i produzione, è
sempre lecita e va sempre condivisa. « L'insopportabile non è stato ancora
definito ».
Tuttalpiù, se la rivolta « fuori tempo » va a vantaggio di terzi, « favorisce
oggettivamente i l padrone », incombe a quelle organizzazioni ed istituzioni esi-
stenti che dovrebbero avere nell'ambito « del sistema » i l compito di limitare
il prepotere « del padrone », l'onere di sostenere in prima persona la lotta, che
— 38
















