
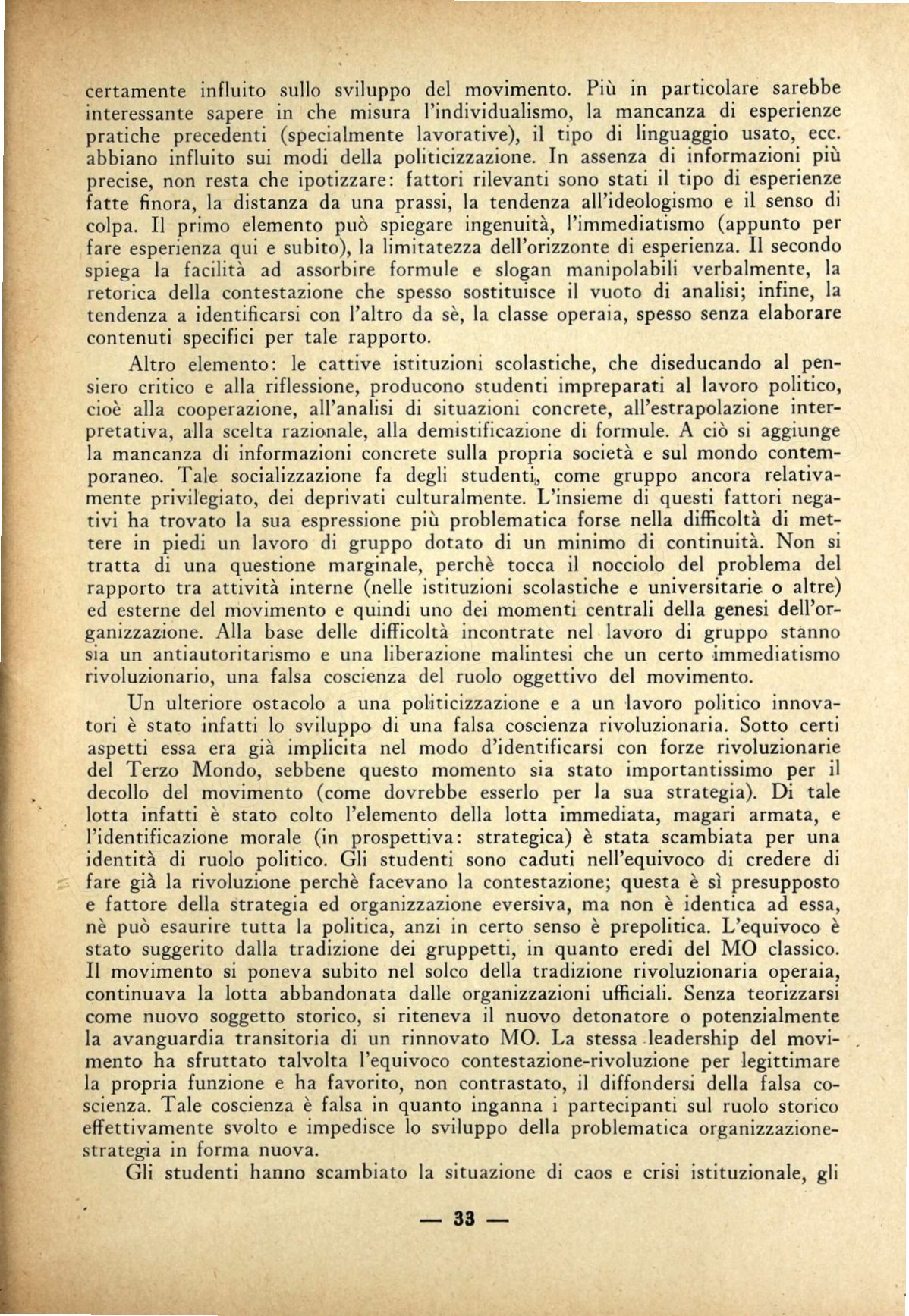
certamente influito sullo sviluppo del movimento. Più i n particolare sarebbe
interessante sapere in che misura l'individualismo, la mancanza di esperienze
pratiche precedenti (specialmente lavorative), i l tipo di linguaggio usato, ecc.
abbiano influito sui modi della politicizzazione. I n assenza di informazioni più
precise, non resta che ipotizzare: fattori rilevanti sono stati i l tipo di esperienze
fatte finora, la distanza da una prassi, la tendenza all'ideologismo e i l senso di
colpa. I l primo elemento può spiegare ingenuità, l'immediatismo (appunto per
fare esperienza qui e subito), la limitatezza dell'orizzonte di esperienza. I l secondo
spiega la facilità ad assorbire formule e slogan manipolabili verbalmente, la
retorica della contestazione che spesso sostituisce i l vuoto di analisi; infine, la
tendenza a identificarsi con l'altro da sè, la classe operaia, spesso senza elaborare
contenuti specifici per tale rapporto.
Altro elemento: l e cattive istituzioni scolastiche, che diseducando al pen-
siero critico e alla riflessione, producono studenti impreparati al lavoro politico,
cioè alla cooperazione, all'analisi di situazioni concrete, all'estrapolazione inter-
pretativa, alla scelta razionale, alla demistificazione di formule. A ciò si aggiunge
lamancanza di informazioni concrete sulla propria società e sul mondo contem-
poraneo. Tale socializzazione fa degli studenti come gruppo ancora relativa-
mente privilegiato, dei deprivati culturalmente. L'insieme di questi fattori nega-
tivi ha trovato la sua espressione più problematica forse nella difficoltà di met-
tere in piedi un lavoro di gruppo dotato di un minimo di continuità. Non si
tratta di una questione marginale, perchè tocca i l nocciolo del problema del
rapporto tra attività interne (nelle istituzioni scolastiche e universitarie o altre)
edesterne del movimento e quindi uno dei momenti centrali della genesi dell'or-
ganizzazione. Al la base delle difficoltà incontrate nel lavoro di gruppo stanno
sia un antiautoritarismo e una liberazione malintesi che un certo immediatismo
rivoluzionario, una falsa coscienza del ruolo oggettivo del movimento.
Un ulteriore ostacolo a una politicizzazione e a un lavoro politico innova-
tori è stato infatti lo sviluppo di una falsa coscienza rivoluzionaria. Sotto certi
aspetti essa era già implicita nel modo d'identificarsi con forze rivoluzionarie
del Terzo Mondo, sebbene questo momento sia stato importantissimo per i l
decollo del movimento (come dovrebbe esserlo per la sua strategia). D i tale
lotta infatti è stato colto l'elemento della lotta immediata, magari armata, e
l'identificazione morale (in prospettiva: strategica) è stata scambiata per una
identità di ruolo politico. Gl i studenti sono caduti nell'equivoco di credere di
fare già la rivoluzione perchè facevano la contestazione; questa è sì presupposto
e fattore della strategia ed organizzazione eversiva, ma non è identica ad essa,
nè può esaurire tutta la politica, anzi in certo senso è prepolitica. L'equivoco è
stato suggerito dalla tradizione dei gruppetti, in quanto eredi del MO classico.
Il movimento si poneva subito nel solco della tradizione rivoluzionaria operaia,
continuava la lotta abbandonata dalle organizzazioni ufficiali. Senza teorizzarsi
come nuovo soggetto storico, si riteneva i l nuovo detonatore o potenzialmente
la avanguardia transitoria di un rinnovato MO. La stessa .leadership del movi-
mento ha sfruttato talvolta l'equivoco contestazione-rivoluzione per legittimare
la propria funzione e ha favorito, non contrastato, i l diffondersi della falsa co-
scienza. Tale coscienza è falsa in quanto inganna i partecipanti sul ruolo storico
effettivamente svolto e impedisce lo sviluppo della problematica organizzazione-
strategia in forma nuova.
Gli studenti hanno scambiato la situazione di caos e crisi istituzionale, gli
33
















