
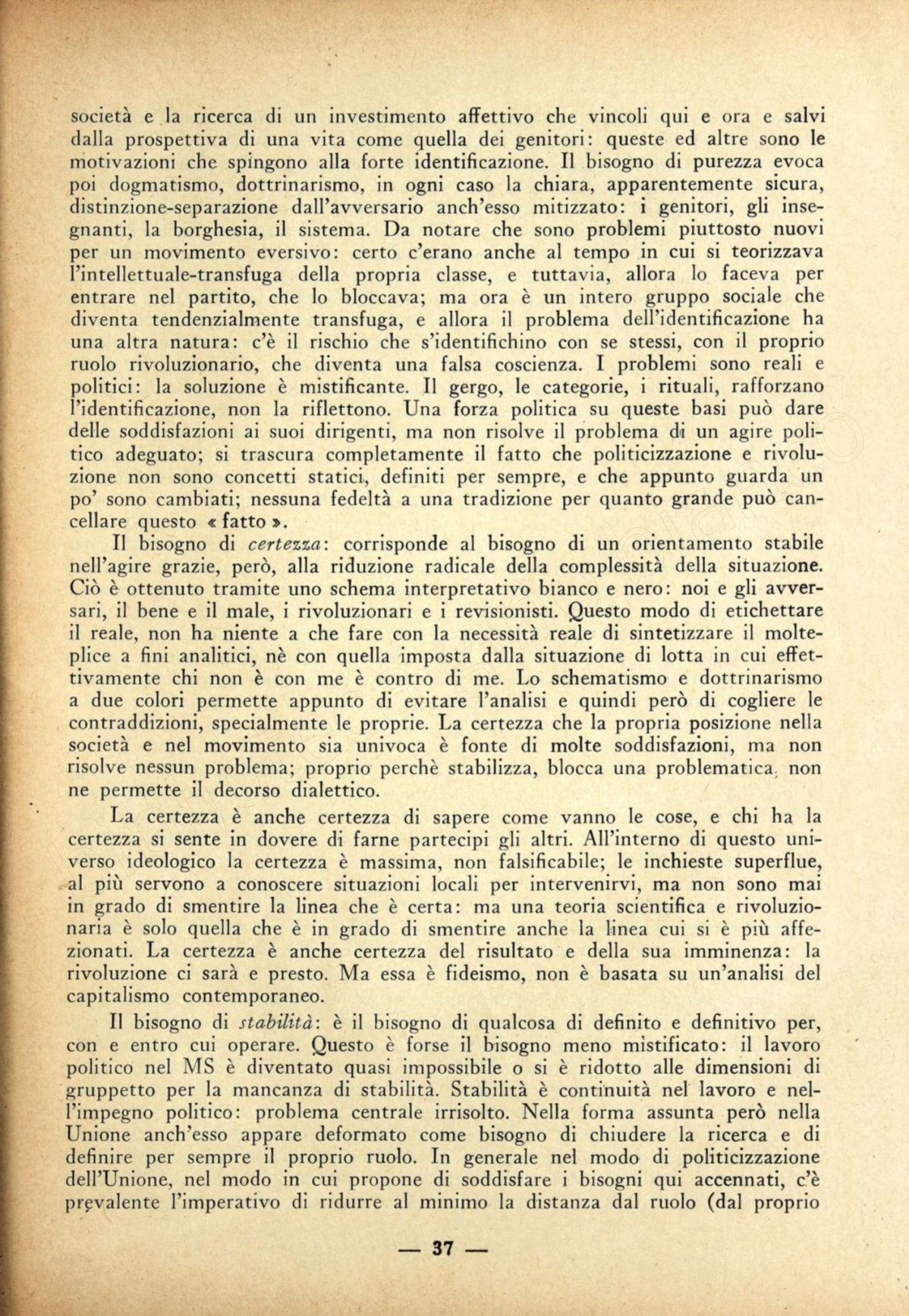
società e la ricerca di un investimento affettivo che vincoli qui e ora e salvi
dalla prospettiva di una vita come quella dei genitori: queste ed altre sono le
motivazioni che spingono alla forte identificazione. I l bisogno di purezza evoca
poi dogmatismo, dottrinarismo, in ogni caso la chiara, apparentemente sicura,
distinzione-separazione dall'avversario anch'esso mitizzato: i genitori, gl i inse-
gnanti, la borghesia, i l sistema. Da notare che sono problemi piuttosto nuovi
per un movimento eversivo: certo c'erano anche al tempo in cui si teorizzava
l'intellettuale-transfuga della propria classe, e tuttavia, allora l o faceva per
entrare nel partito, che lo bloccava; ma ora è un intero gruppo sociale che
diventa tendenzialmente transfuga, e allora i l problema dell'identificazione ha
una altra natura: c'è i l rischio che s'identifichino con se stessi, con i l proprio
ruolo rivoluzionario, che diventa una falsa coscienza. I problemi sono reali e
politici: l a soluzione è mistificante. I l gergo, le categorie, i rituali, rafforzano
l'identificazione, non la riflettono. Una forza politica su queste basi può dare
delle soddisfazioni ai suoi dirigenti, ma non risolve i l problema di un agire poli-
tico adeguato; si trascura completamente i l fatto che politicizzazione e rivolu-
zione non sono concetti statici, definiti per sempre, e che appunto guarda un
po' sono cambiati; nessuna fedeltà a una tradizione per quanto grande può can-
cellare questo « fatto ».
Il bisogno di
certezza:
corrisponde al bisogno di un orientamento stabile
nell'agire grazie, però, alla riduzione radicale della complessità della situazione.
Ciò è ottenuto tramite uno schema interpretativo bianco e nero: noi e gli avver-
sari, i l bene e i l male, i rivoluzionari e i revisionisti. Questo modo di etichettare
il reale, non ha niente a che fare con la necessità reale di sintetizzare i l molte-
plice a fini analitici, nè con quella imposta dalla situazione di lotta in cui effet-
tivamente chi non è con me è contro di me. Lo schematismo e dottrinarismo
adue colori permette appunto di evitare l'analisi e quindi però di cogliere le
contraddizioni, specialmente le proprie. La certezza che la propria posizione nella
società e nel movimento sia univoca è fonte di molte soddisfazioni, ma non
risolve nessun problema; proprio perchè stabilizza, blocca una problematica, non
ne permette i l decorso dialettico.
La certezza è anche certezza di sapere come vanno le cose, e chi ha la
certezza si sente in dovere di farne partecipi gli altri. All'interno di questo uni-
verso ideologico la certezza è massima, non falsificabile, le inchieste superflue,
al più servono a conoscere situazioni locali per intervenirvi, ma non sono mai
in grado di smentire la linea che è certa: ma una teoria scientifica e rivoluzio-
naria è solo quella che è in grado di smentire anche la linea cui si è più affe-
zionati. La certezza è anche certezza del risultato e della sua imminenza: l a
rivoluzione ci sarà e presto. Ma essa è fideismo, non è basata su un'analisi del
capitalismo contemporaneo.
Il bisogno di
stabilità:
è i l bisogno di qualcosa di definito e definitivo per,
con e entro cui operare. Questo è forse i l bisogno meno mistificato: i l lavoro
politico nel MS è diventato quasi impossibile o si è ridotto alle dimensioni di
gruppetto per la mancanza di stabilità. Stabilità è continuità nel lavoro e nel-
l'impegno politico: problema centrale irrisolto. Nella forma assunta però nella
Unione anch'esso appare deformato come bisogno di chiudere la ricerca e di
definire per sempre i l proprio ruolo. I n generale nel modo di politicizzazione
dell'Unione, nel modo inc i t i propone di soddisfare i bisogni qui accennati, c'è
prevalente l'imperativo di ridurre al minimo la distanza dal ruolo (dal proprio
37
















