
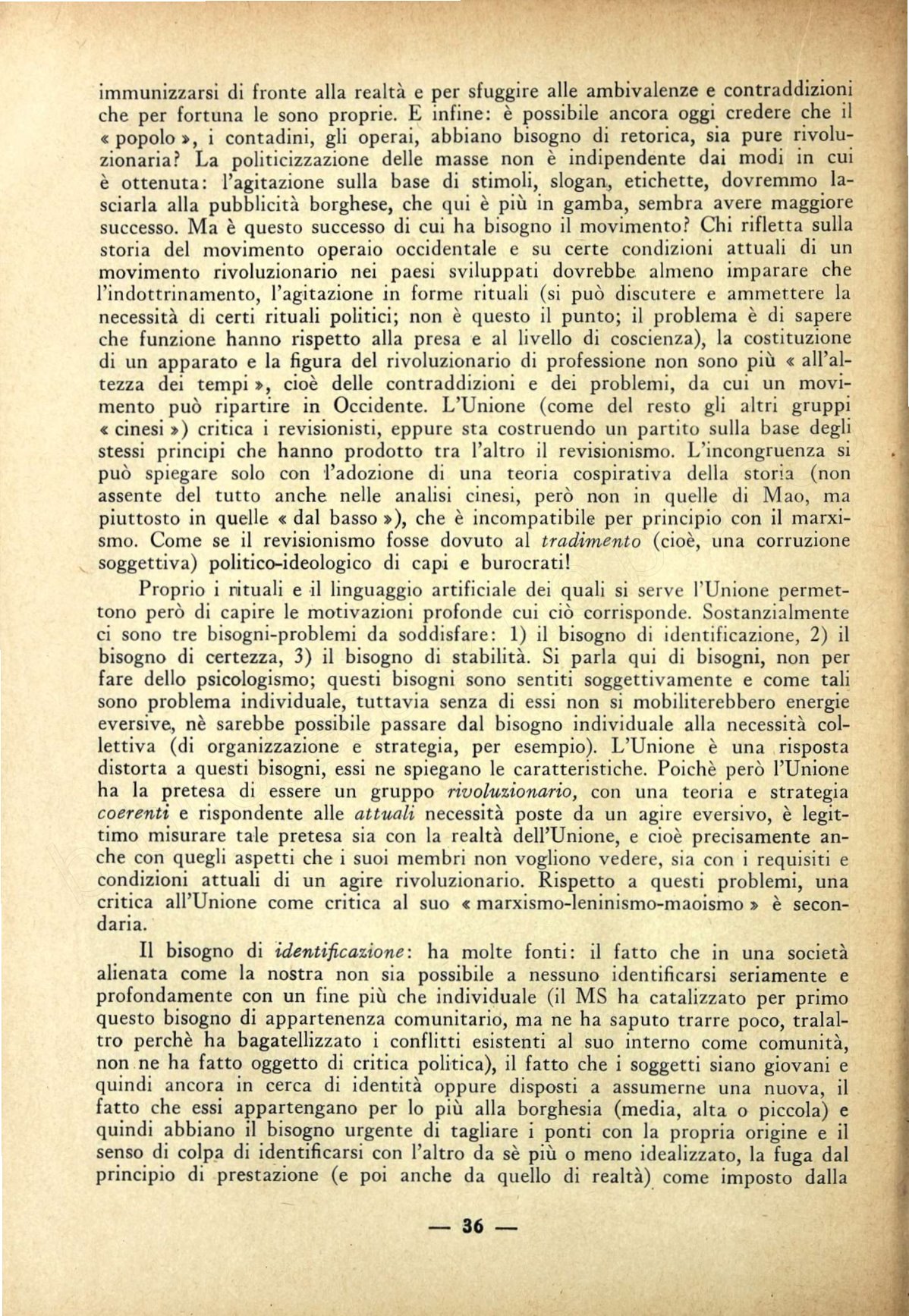
immunizzarsi di fronte alla realtà e per sfuggire alle ambivalenze e contraddizioni
che per fortuna le sono proprie. E infine: è possibile ancora oggi credere che i l
«popolo »' i contadini, gli operai, abbiano bisogno di retorica, sia pure rivolu-
zionaria? La politicizzazione delle masse non è indipendente dai modi i n cui
èottenuta: l'agitazione sulla base di stimoli, slogan, etichette, dovremmo la-
sciarla alla pubblicità borghese, che qui è più in gamba, sembra avere maggiore
successo. Ma è questo successo di cui ha bisogno il movimento? Chi rifletta sulla
storia del movimento operaio occidentale e su certe condizioni attuali d i un
movimento rivoluzionario nei paesi sviluppati dovrebbe almeno imparare che
l'indottrinamento, l'agitazione in forme rituali (si può discutere e ammettere la
necessità di certi rituali politici; non è questo i l punto; i l problema è di sapere
che funzione hanno rispetto alla presa e al livello di coscienza), la costituzione
di un apparato e la figura del rivoluzionario di professione non sono più « all'al-
tezza dei tempi», cioè delle contraddizioni e dei problemi, da cui un movi-
mento può ripartire i n Occidente. L'Unione (come del resto gl i al tr i gruppi
«cinesi ») critica i revisionisti, eppure sta costruendo un partito sulla base degli
stessi principi che hanno prodotto tra l'altro i l revisionismo. L'incongruenza si
può spiegare solo con l'adozione d i una teoria cospirativa della storia (non
assente del tut to anche nelle analisi cinesi, però non i n quelle d i M ao, ma
piuttosto in quelle « dal basso »), che è incompatibile per principio con i l marxi-
smo. Come se i l revisionismo fosse dovuto al
tradimento
(cioè, una corruzione
soggettiva) politico-ideologico di capi e burocrati!
Proprio i rituali e il linguaggio artificiale dei quali si serve l'Unione permet-
tono però di capire le motivazioni profonde cui ciò corrisponde. Sostanzialmente
ci sono tre bisogni-problemi da soddisfare: 1) i l bisogno di identificazione, 2) i l
bisogno di certezza, 3) i l bisogno di stabilità. Si parla qui di bisogni, non per
fare dello psicologismo; questi bisogni sono sentiti soggettivamente e come tali
sonoproblema individuale, tuttavia senza di essi non si mobiliterebbero energie
eversive, nè sarebbe possibile passare dal bisogno individuale alla necessità col-
lettiva (di organizzazione e strategia, per esempio). L'Unione è una risposta
distorta a questi bisogni, essi ne spiegano le caratteristiche. Poichè però l'Unione
ha la pretesa di essere un gruppo
rivoluzionario,
con una teoria e strategia
coerenti
e rispondente alle
attuali
necessità poste da un agire eversivo, è legit-
timo misurare tale pretesa sia con la realtà dell'Unione, e cioè precisamente an-
checon quegli aspetti che i suoi membri non vogliono vedere, sia con i requisiti e
condizioni attuali di un agire rivoluzionario. Rispetto a questi problemi, una
critica all'Unione come critica al suo « marxismo-leninismo-maoismo» è secon-
daria.
Il bisogno di
identificazione:
ha molte fonti: i l fatto che in una società
alienata come la nostra non sia possibile a nessuno identificarsi seriamente e
profondamente con un fine più che individuale (i l MS ha catalizzato per primo
questo bisogno di appartenenza comunitario, ma ne ha saputo trarre poco, tralal-
tro perchè ha bagatellizzato i conflitti esistenti al suo interno come comunità,
non ne ha fatto oggetto di critica politica), i l fatto che i soggetti siano giovani e
quindi ancora in cerca di identità oppure disposti a assumerne una nuova, i l
fatto che essi appartengano per lo più alla borghesia (media, alta o piccola) e
quindi abbiano i l bisogno urgente di tagliare i ponti con la propria origine e i l
senso di colpa di identificarsi con l'altro da sè più o meno idealizzato, la fuga dal
principio di prestazione (e poi anche da quello di realtà) come imposto dalla
36
















