
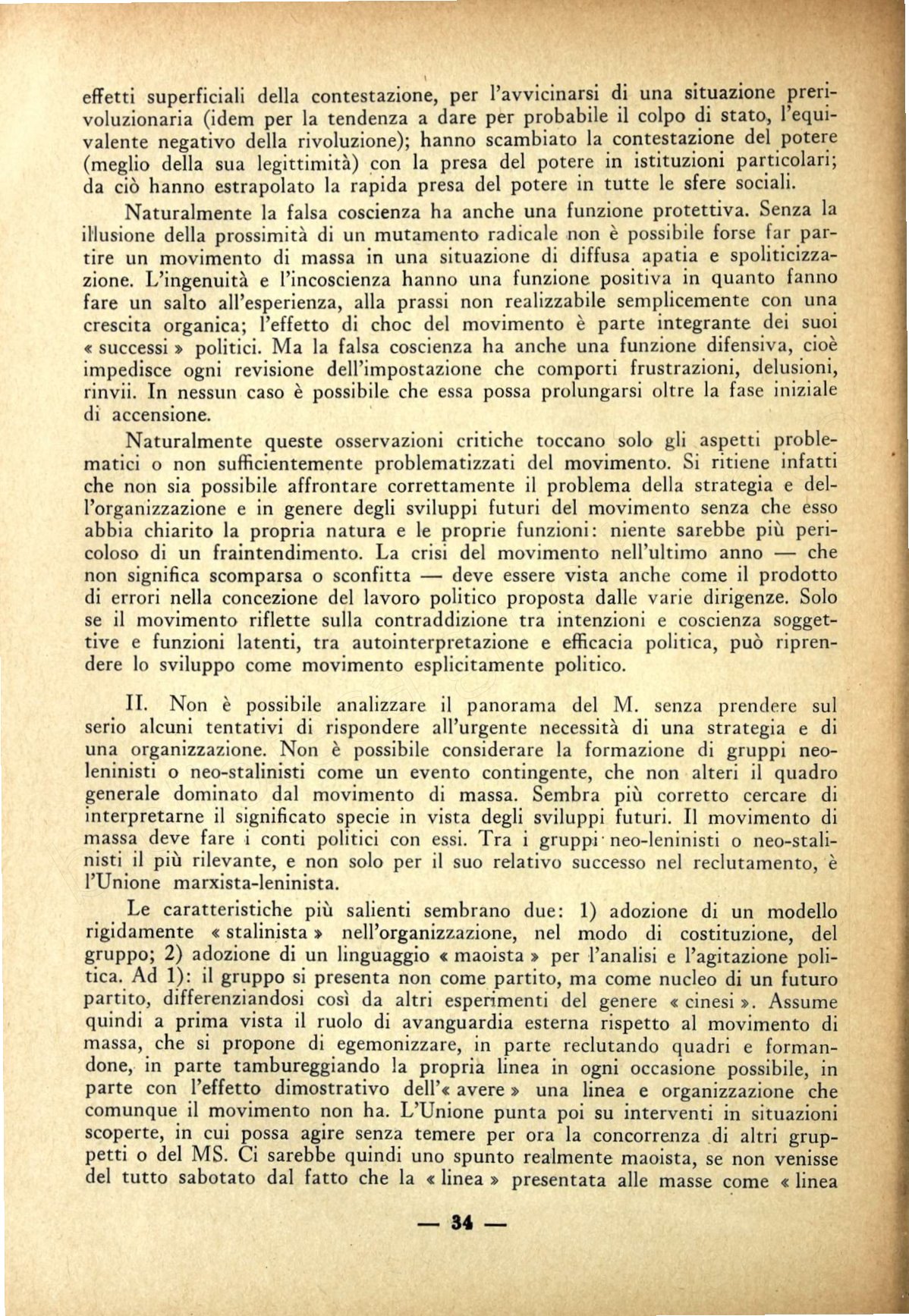
effetti superficiali della contestazione, per l'avvicinarsi di una situazione preri-
voluzionaria (idem per la tendenza a dare per probabile i l colpo di stato, l'equi-
valente negativo della rivoluzione); hanno scambiato la contestazione del potere
(meglio della sua legittimità) con la presa del potere in istituzioni particolari;
da ciò hanno estrapolato la rapida presa del potere in tutte le sfere sociali.
Naturalmente la falsa coscienza ha anche una funzione protettiva. Senza la
illusione della prossimità di un mutamento radicale non è possibile forse far par-
tire un movimento di massa in una situazione di diffusa apatia e spoliticizza-
zione. L'ingenuità e l'incoscienza hanno una funzione positiva in quanto fanno
fare un salto all'esperienza, alla prassi non realizzabile semplicemente con una
crescita organica; l'effetto di choc del movimento è parte integrante dei suoi
«successi » politici. Ma la falsa coscienza ha anche una funzione difensiva, cioè
impedisce ogni revisione dell'impostazione che comporti frustrazioni, delusioni,
rinvii. In nessun caso è possibile che essa possa prolungarsi oltre la fase iniziale
di accensione.
Naturalmente queste osservazioni critiche toccano solo gli aspetti proble-
matici o non sufficientemente problematizzati del movimento. Si ritiene infatti
che non sia possibile affrontare correttamente i l problema della strategia e del-
l'organizzazione e in genere degli sviluppi futuri del movimento senza che esso
abbia chiarito la propria natura e le proprie funzioni: niente sarebbe più peri-
coloso di un fraintendimento. La crisi del movimento nell'ultimo anno — che
non significa scomparsa o sconfitta — deve essere vista anche come i l prodotto
di errori nella concezione del lavoro politico proposta dalle varie dirigenze. Solo
se i l movimento riflette sulla contraddizione tra intenzioni e coscienza sogget-
tive e funzioni latenti, tra autointerpretazione e efficacia politica, può ripren-
dere lo sviluppo come movimento esplicitamente politico.
II. No n è possibile analizzare i l panorama del M . senza prendere sul
serio alcuni tentativi di rispondere all'urgente necessità di una strategia e di
una organizzazione. Non è possibile considerare la formazione di gruppi neo-
leninisti o neo-stalinisti come un evento contingente, che non alteri i l quadro
generale dominato dal movimento d i massa Sembra più corretto cercare d i
interpretarne i l significato specie in vista degli sviluppi futuri. I l movimento di
massa deve fare i conti politici con essi. Tra i gruppi. neo-leninisti o neo-stali-
nisti i l più rilevante, e non solo per i l suo relativo successo nel reclutamento, è
l'Unione marxista-leninista.
Le caratteristiche più salienti sembrano due: 1 ) adozione di un modello
rigidamente « stalinista » nell'organizzazione, nel modo d i costituzione, del
gruppo; 2) adozione di un linguaggio « maoista » per l'analisi e l'agitazione poli-
tica. Ad 1): i l gruppo si presenta non come partito, ma come nucleo di un futuro
partito, differenziandosi così da altri esperimenti del genere « cinesi ». Assume
quindi a prima vista i l ruolo di avanguardia esterna rispetto al movimento di
massa, che si propone di egemonizzare, in parte reclutando quadri e forman-
done, in parte tambureggiando la propria linea in ogni occasione possibile, in
parte con l'effetto dimostrativo dell'« avere » una linea e organizzazione che
comunque i l movimento non ha. L'Unione punta poi su interventi in situazioni
scoperte, in cui possa agire senza temere per ora la concorrenza di altri grup-
petti o del MS. Ci sarebbe quindi uno spunto realmente maoista, se non venisse
del tutto sabotato dal fatto che la (linea » presentata alle masse come « linea
34
















