
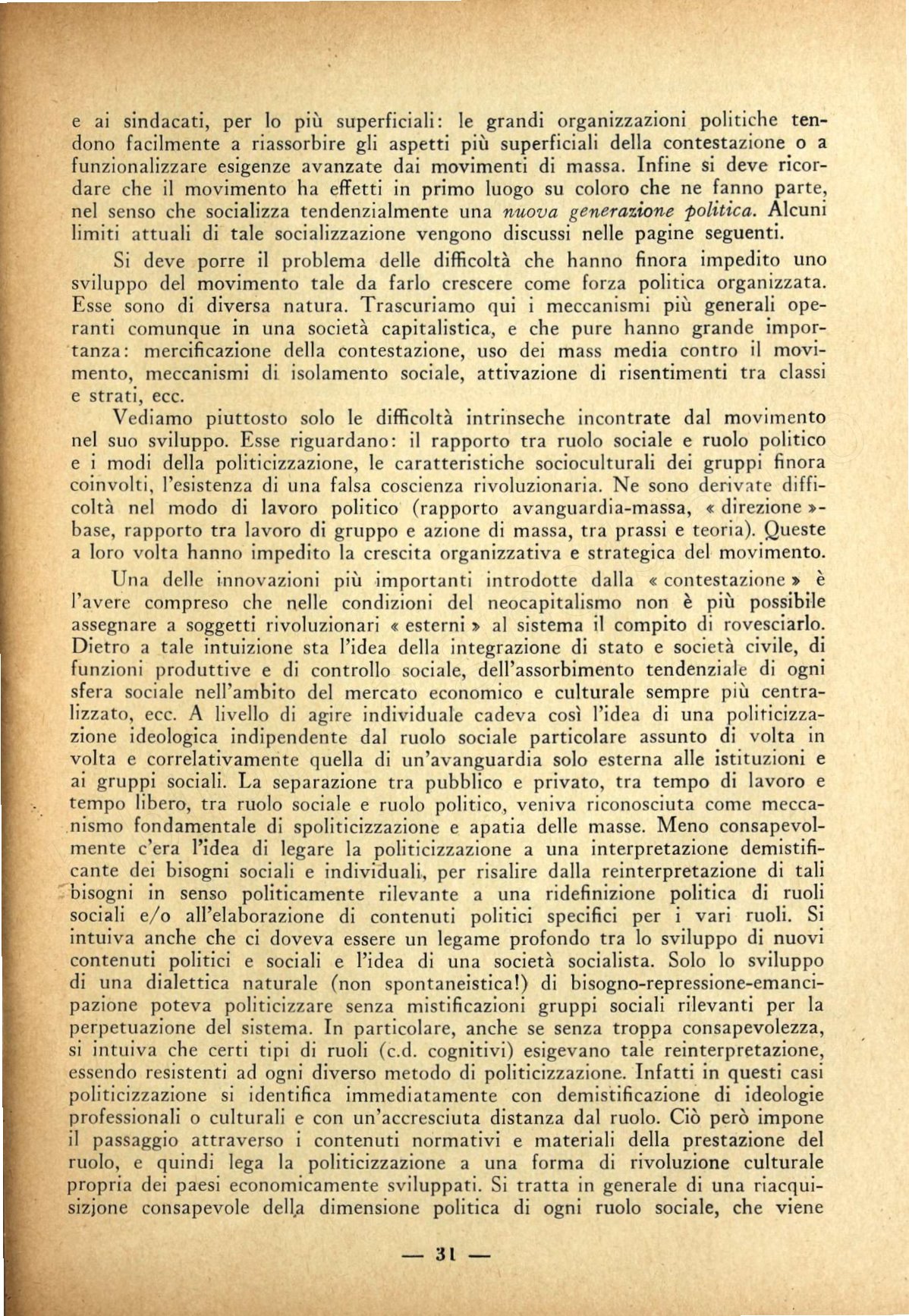
e ai sindacati, per lo più superficiali: l e grandi organizzazioni politiche ten-
dono facilmente a riassorbire gli aspetti più superficiali della contestazione o a
funzionalizzare esigenze avanzate dai movimenti di massa. Infine si deve ricor-
dare che i l movimento ha effetti in primo luogo su coloro che ne fanno parte,
nel senso che socializza tendenzialmente una
nuova generazione politica.
Alcuni
limiti attuali di tale socializzazione vengono discussi nelle pagine seguenti.
Si deve porre i l problema delle difficoltà che hanno finora impedito uno
sviluppo del movimento tale da farlo crescere come forza politica organizzata.
Esse sono di diversa natura. Trascuriamo qui i meccanismi più generali ope-
ranti comunque in una società capitalistica, e che pure hanno grande impor-
tanza: mercificazione della contestazione, uso dei mass media contro i l movi-
mento, meccanismi di isolamento sociale, attivazione di risentimenti tra classi
estrati, ecc.
Vediamo piuttosto solo le difficoltà intrinseche incontrate dal movimento
nel suo sviluppo. Esse riguardano: i l rapporto tra ruolo sociale e ruolo politico
e i modi della politicizzazione, le caratteristiche socioculturali dei gruppi finora
coinvolti, l'esistenza di una falsa coscienza rivoluzionaria. Ne sono derivate diffi-
coltà nel modo d i lavoro politico (rapporto avanguardia-massa, « direzione »-
base, rapporto tra lavoro di gruppo e azione di massa, tra prassi e teoria). Queste
aloro volta hanno impedito la crescita organizzativa e strategica del movimento.
Una delle innovazioni più importanti introdotte dalla « contestazione » è
l'avere compreso che nelle condizioni del neocapitalismo non è più possibile
assegnare a soggetti rivoluzionari « esterni » al sistema i l compito di rovesciarlo.
Dietro a tale intuizione sta l'idea della integrazione di stato e società civile, di
funzioni produttive e di controllo sociale, dell'assorbimento tendenziale di ogni
sfera sociale nell'ambito del mercato economico e culturale sempre più centra-
lizzato, ecc. A livello di agire individuale cadeva così l'idea di una politicizza-
zione ideologica indipendente dal ruolo sociale particolare assunto di volta in
volta e correlativamente quella di un'avanguardia solo esterna alle istituzioni e
ai gruppi sociali. La separazione tra pubblico e privato, tra tempo di lavoro e
tempo libero, tra ruolo sociale e ruolo politico, veniva riconosciuta come mecca-
nismo fondamentale di spoliticizzazione e apatia delle masse. Meno consapevol-
mente c'era l'idea di legare la politicizzazione a una interpretazione demistifi-
cante dei bisogni sociali e individuali, per risalire dalla reinterpretazione di tali
bisogni i n senso politicamente rilevante a una ridefinizione politica d i ruol i
sociali e/o all'elaborazione d i contenuti politici specifici per i var i ruoli. Si
intuiva anche che ci doveva essere un legame profondo tra lo sviluppo di nuovi
contenuti politici e sociali e l'idea di una società socialista. Solo lo sviluppo
di una dialettica naturale (non spontaneistica!) di bisogno-repressione-emanci-
pazione poteva politicizzare senza mistificazioni gruppi sociali rilevanti per la
perpetuazione del sistema. In particolare, anche se senza troppa consapevolezza,
si intuiva che certi tipi di ruoli (c.d. cognitivi) esigevano tale reinterpretazione,
essendo resistenti ad ogni diverso metodo di politicizzazione. Infatti in questi casi
politicizzazione si identifica immediatamente con demistificazione di ideologie
professionali o culturali e con un'accresciuta distanza dal ruolo. Ciò però impone
il passaggio attraverso i contenuti normativi e materiali della prestazione del
ruolo, e quindi lega la politicizzazione a una forma d i rivoluzione culturale
propria dei paesi economicamente sviluppati. Si tratta in generale di una riacqui-
sizione consapevole delta dimensione politica d i ogni ruolo sociale, che viene
- 31
















