
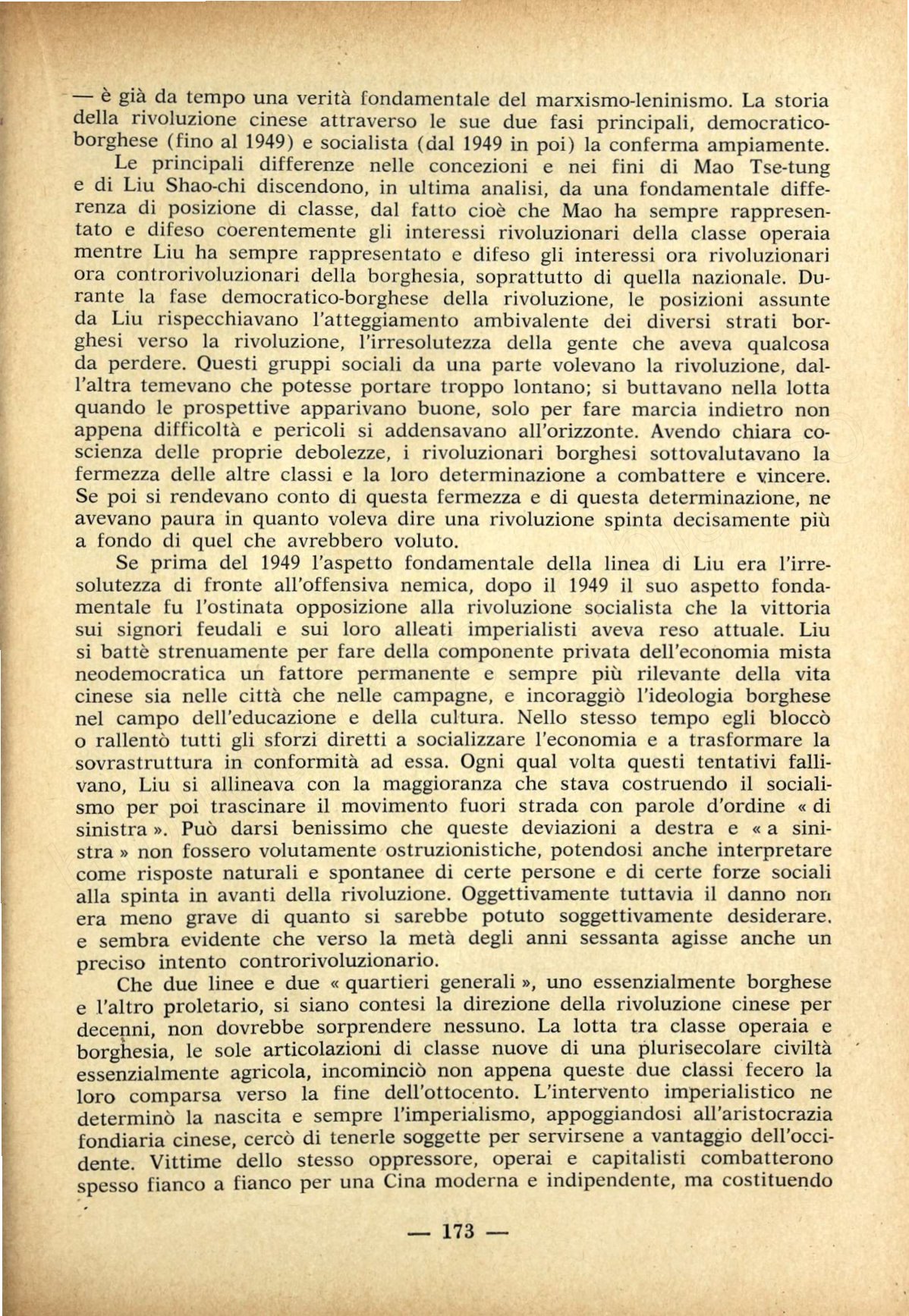
è già da tempo una verità fondamentale del marxismo-leninismo. La storia
della rivoluzione cinese attraverso l e sue due fasi pr incipal i , democratico-
borghese ( f ino al 1949) e socialista (dal 1949 in poi) la conferma ampiamente.
Le pr incipal i di fferenze nel le concezioni e ne i f i n i d i Mao Tse-tung
e d i L i u Shao-chi discendono, i n ul t ima analisi, da una fondamentale di ffe-
renza d i posizione d i classe, dal fat to cioè che Mao ha sempre rappresen-
tato e difeso coerentemente g l i interessi rivoluzionari del la classe operaia
mentre L i u ha sempre rappresentato e difeso gl i interessi ora rivoluzionari
ora controrivoluzionari del la borghesia, soprattutto d i quel la nazionale. Du-
rante l a fase democratico-borghese del la rivoluzione, l e posizioni assunte
da L i u rispecchiavano l'atteggiamento ambivalente de i diversi s t ra t i bor -
ghesi verso l a rivoluzione, l'irresolutezza del la gente che aveva qualcosa
da perdere. Questi gruppi sociali da una parte volevano l a rivoluzione, dal-
l'altra temevano che potesse portare troppo lontano; s i buttavano nella lotta
quando le prospettive apparivano buone, solo per fare marcia indietro non
appena di ff icol tà e pericol i s i addensavano all'orizzonte. Avendo chiara co-
scienza del le propr ie debolezze, i rivoluzionari borghesi sottovalutavano l a
fermezza delle al tre classi e l a loro determinazione a combattere e vincere.
Se poi si rendevano conto di questa fermezza e di questa determinazione, ne
avevano paura in quanto voleva di re una rivoluzione spinta decisamente più
a fondo d i quel che avrebbero voluto.
Se pr ima del 1949 l 'aspetto fondamentale del la l inea d i L i u era l ' i rre-
solutezza d i f ronte all'offensiva nemica, dopo i l 1949 i l suo aspetto fonda-
mentale f u l 'ost inata opposizione al la rivoluzione socialista che l a v i t tor ia
sui signor i feudal i e su i l o r o al leat i imper ial ist i aveva reso attuale. L i u
si battè strenuamente per fare della componente privata dell'economia mista
neodemocratica u n fat tore permanente e sempre p i ù r i levante del la v i t a
cinese sia nel le c i t tà che nel le campagne, e incoraggiò l'ideologia borghese
nel campo dell'educazione e del la cul tura. Nel lo stesso tempo egl i bloccò
o ral lentò tut t i gl i sforzi di ret t i a socializzare l'economia e a trasformare l a
sovrastruttura i n conformi tà ad essa. Ogni qual vol ta questi tentat ivi fal l i -
vano, L i u s i allineava con l a maggioranza che stava costruendo i l sociali-
smo per poi trascinare i l movimento fuor i strada con parole d'ordine « di
sinistra ». Può dars i benissimo che queste deviazioni a destra e « a sini -
stra » non fossero volutamente ostruzionistiche, potendosi anche interpretare
come risposte natural i e spontanee d i certe persone e d i certe forze sociali
alla spinta i n avanti del la rivoluzione. Oggettivamente tuttavia i l danno non
era meno grave d i quanto s i sarebbe potuto soggettivamente desiderare,
e sembra evidente che verso l a metà degl i anni sessanta agisse anche un
preciso intento controrivoluzionario.
Che due l inee e due « quartieri generali », uno essenzialmente borghese
e l 'al t ro proletario, si siano contesi la direzione della rivoluzione cinese per
decenni, non dovrebbe sorprendere nessuno. La lot ta t r a classe operaia e
borghesia, l e sole articolazioni d i classe nuove d i una plurisecolare civi l tà
essenzialmente agricola, incominciò non appena queste due classi fecero l a
loro comparsa verso l a f i ne del l 'ottocento. L' intervento imper ial ist ico n e
determinò l a nascita e sempre l ' imperialismo, appoggiandosi all'aristocrazia
fondiaria cinese, cercò di tenerle soggette per servirsene a vantaggio dell'occi-
dente. Vi t t ime del lo stesso oppressore, operai e capi tal ist i combatterono
spesso fianco a fianco per una Cina moderna e indipendente, ma costituendo
173
















