
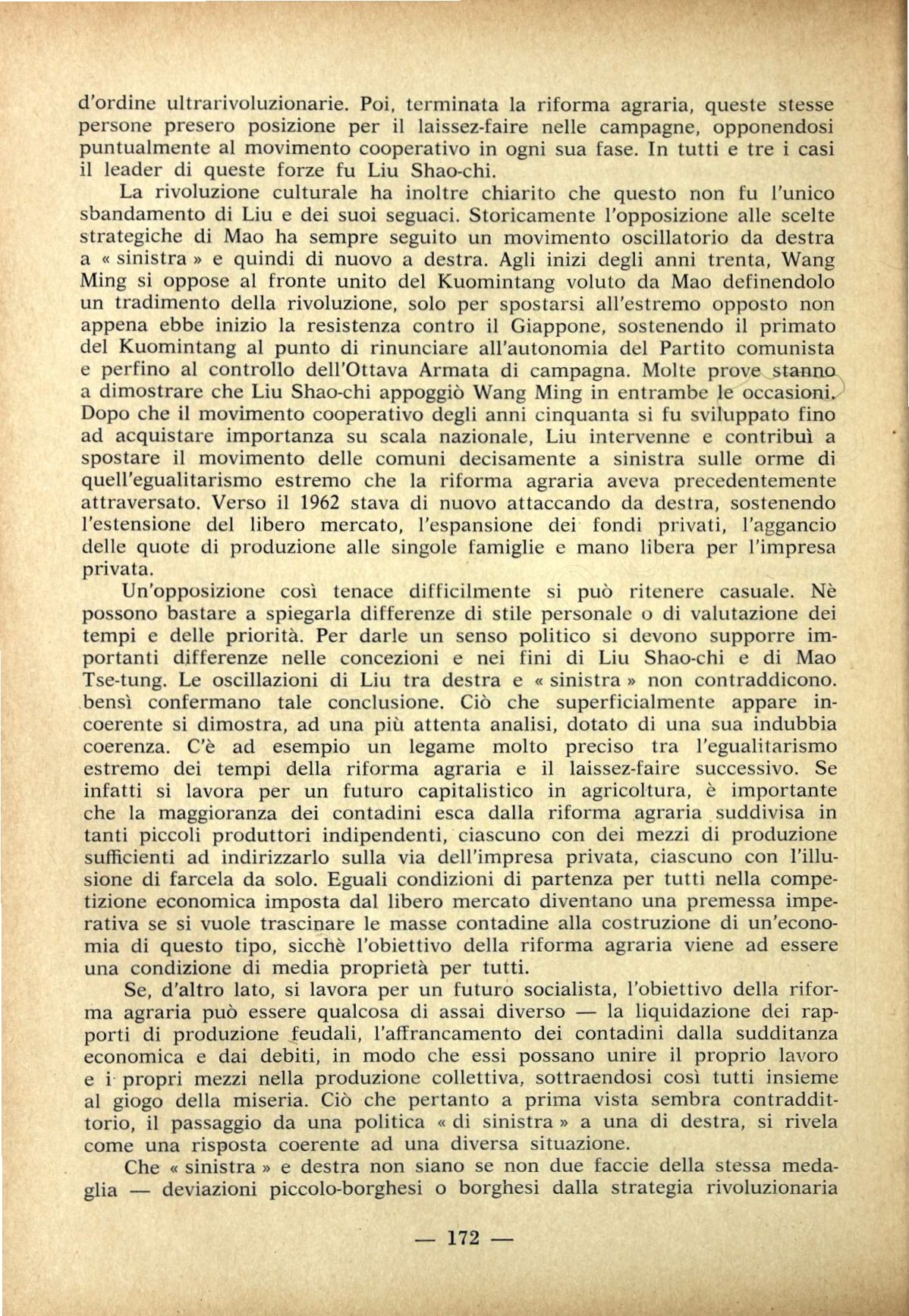
d'ordine ultrarivoluzionarie. Poi, terminata la riforma agraria, queste stesse
persone presero posizione per i l laissez-faire nelle campagne, opponendosi
puntualmente al movimento cooperativo in ogni sua fase. In tutti e tre i casi
il leader di queste forze fu Liu Shao-chi.
La rivoluzione culturale ha inoltre chiarito che questo non f u l'unico
sbandamento di Liu e dei suoi seguaci. Storicamente l'opposizione alle scelte
strategiche di Mao ha sempre seguito un movimento oscillatorio da destra
a « sinistra » e quindi di nuovo a destra. Agli inizi degli anni trenta, Wang
Ming si oppose al fronte unito del Kuomintang voluto da Mao definendolo
un tradimento della rivoluzione, solo per spostarsi all'estremo opposto non
appena ebbe inizio la resistenza contro i l Giappone, sostenendo i l primato
del Kuomintang al punto di rinunciare all'autonomia del Partito comunista
e perfino al controllo dell'Ottava Armata di campagna. Molte prove stanao,
a dimostrare che Liu Shao-chi appoggiò Wang Ming in entrambe ie occasioni)
Dopo che il movimento cooperativo degli anni cinquanta si fu sviluppato fino
ad acquistare importanza su scala nazionale, Liu intervenne e contribuì a
spostare i l movimento delle comuni decisamente a sinistra sulle orme d i
quell'egualitarismo estremo che l a riforma agraria aveva precedentemente
attraversato. Verso i l 1962 stava di nuovo attaccando da destra, sostenendo
l'estensione del libero mercato, l'espansione dei fondi privati, l'aggancio
delle quote di produzione alle singole famiglie e mano libera per l'impresa
privata.
Un'opposizione così tenace difficilmente s i può ritenere casuale. N è
possono bastare a spiegarla differenze di stile personale o di valutazione dei
tempi e delle priorità. Per darle un senso politico si devono supporre im-
portanti differenze nelle concezioni e nei f ini d i Liu Shao-chi e d i Mao
Tse-tung. Le oscillazioni di Liu tra destra e « sinistra » non contraddicono.
bensì confermano tale conclusione. Ciò che superficialmente appare i n-
coerente si dimostra, ad una più attenta analisi, dotato di una sua indubbia
coerenza. C' è a d esempio u n legame mol to preciso t r a l'egualitarismo
estremo dei tempi della riforma agraria e i l laissez-faire successivo. Se
infatti si lavora per un futuro capitalistico i n agricoltura, è importante
che l a maggioranza dei contadini esca dalla riforma agraria _suddivisa i n
tanti piccoli produttori indipendenti, ciascuno con dei mezzi di produzione
sufficienti ad indirizzarlo sulla via dell'impresa privata, ciascuno con l'illu-
sione di farcela da solo. Eguali condizioni di partenza per tutti nella compe-
tizione economica imposta dal libero mercato diventano una premessa impe-
rativa se si vuole trascinare le masse contadine alla costruzione di un'econo-
mia di questo tipo, sicchè l'obiettivo della riforma agraria viene ad essere
una condizione di media proprietà per tutti.
Se, d'altro lato, si lavora per un futuro' socialista, l'obiettivo della rifor-
ma agraria può essere qualcosa di assai diverso — la liquidazione dei rap-
porti di produzione feudali, l'affrancamento dei contadini dalla sudditanza
economica e dai debiti, in modo che essi possano unire i l proprio lavoro
e F propri mezzi nella produzione collettiva, sottraendosi così tutti insieme
al giogo della miseria. Ciò che pertanto a prima vista sembra contraddit-
torio, i l passaggio da una politica «d i sinistra » a una di destra, si rivela
come una risposta coerente ad una diversa situazione.
Che « sinistra » e destra non siano se non due faccie della stessa meda-
glia d e v i a z i on i piccolo-borghesi o borghesi dalla strategia rivoluzionaria
172
















