
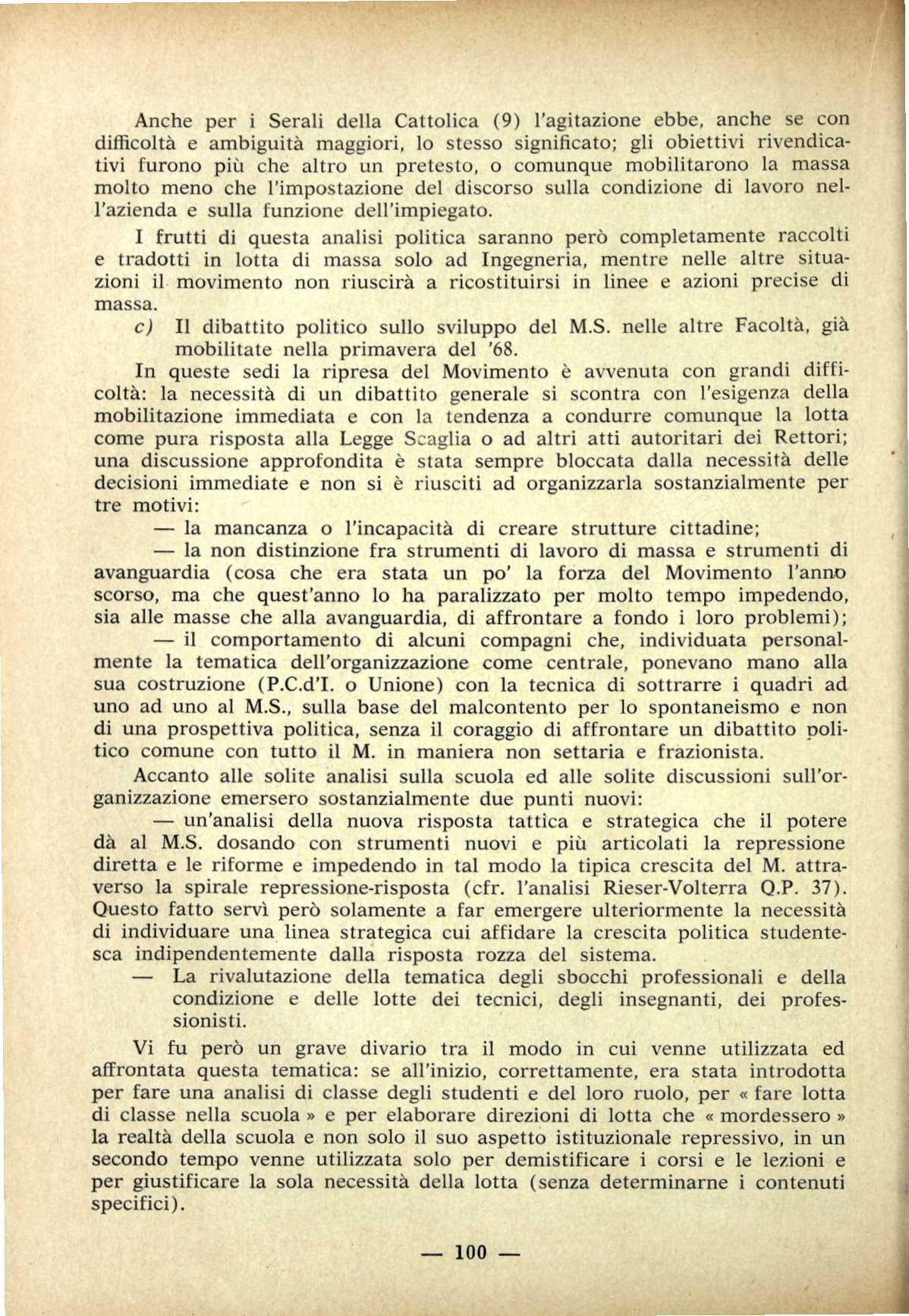
Anche per i Seral i del la Cattol ica ( 9 ) l'agitazione ebbe, anche se con
difficoltà e ambiguità maggiori, l o stesso significato; g l i obiet t ivi rivendica-
tivi furono p i ù che a l t ro un pretesto, o comunque mobi l i tarono l a massa
molto meno che l'impostazione del discorso sul la condizione d i lavoro nel-
l'azienda e sul la funzione dell'impiegato.
I f r u t t i d i questa anal isi pol i t ica saranno però completamente raccol t i
e t radot t i i n l o t t a d i massa solo ad Ingegneria, ment re nel le al t re si tua-
zioni i l movimento non r iusci rà a r icost i tui rsi i n l inee e azioni precise d i
massa.
c)
I l dibat t i to pol i t ico sul lo svi luppo del M.S. nel le al t re Facoltà, già
mobilitate nel la primavera del '68.
In queste sedi l a ripresa del Movimento è avvenuta con grandi d i f f i -
coltà: l a necessità d i un dibat t i to generale s i scontra con l'esigenza del la
mobilitazione immediata e con l a tendenza a condurre comunque l a l ot ta
come pura risposta al la Legge Scaglia o ad a l t r i at t i autor i tar i dei Ret tor i ;
una discussione approfondita è stata sempre bloccata dal la necessità del le
decisioni immediate e non s i è r iusci t i ad organizzarla sostanzialmente per
tre mot ivi :
la mancanza o l ' incapacità d i creare st rut ture ci ttadine;
la non distinzione f ra strumenti d i lavoro d i massa e strument i d i
avanguardia (cosa che e r a stata u n po ' l a forza de l Movimento l ' anno
scorso, ma che quest'anno l o ha paralizzato per mol to tempo impedendo,
sia alle masse che al la avanguardia, d i affrontare a fondo i loro problemi);
il comportamento d i alcuni compagni che, individuata personal-
mente l a tematica dell'organizzazione come centrale, ponevano mano a l l a
sua costruzione (P.C.d' I. o Unione) con l a tecnica d i sot trarre i quadr i ad
uno ad uno al M.S., sul la base del malcontento per l o spontaneismo e non
di una prospettiva politica, senza i l coraggio d i affrontare un dibat t i to pol i-
tico comune con tut to i l M. i n maniera non settaria e frazionista.
Accanto al le sol ite analisi sul la scuola ed al le sol i te discussioni sul l 'or-
ganizzazione emersero sostanzialmente due punt i nuovi:
— un'analisi del la nuova risposta tat t i ca e strategica che i l potere
dà a l M.S. dosando con st rument i nuov i e p i ù ar t icolat i l a repressione
diretta e le r i forme e impedendo in tal modo la t ipica crescita del M. attra-
verso l a spirale repressione-risposta ( c f r. l 'anal isi Rieser-Volterra
Q.P.
37).
Questo fat to servì però solamente a far emergere ulteriormente l a necessità
di individuare una linea strategica cui affidare l a crescita pol i t ica studente-
sca indipendentemente dal la risposta rozza del sistema.
La rivalutazione del la temat ica degl i sbocchi professionali e del la
condizione e del le l o t t e de i tecnici , degl i insegnanti, de i profes-
sionisti.
Vi f u però u n grave divar io t r a i l modo i n cu i venne ut i l izzata ed
affrontata questa tematica: se al l ' inizio, correttamente, era stata introdot ta
per fare una analisi d i classe degli studenti e del loro ruolo, per « fare lot ta
di classe nella scuola)> e per elaborare direzioni d i lot ta che « mordessero »
la realtà della scuola e non solo i l suo aspetto istituzionale repressivo, i n un
secondo tempo venne utilizzata solo per demistificare i corsi e le lezioni e
per giustificare l a sola necessità della lot ta (senza determinarne i contenuti
specifici).
— 100
















