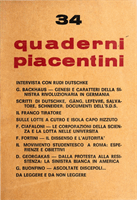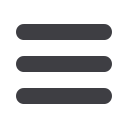
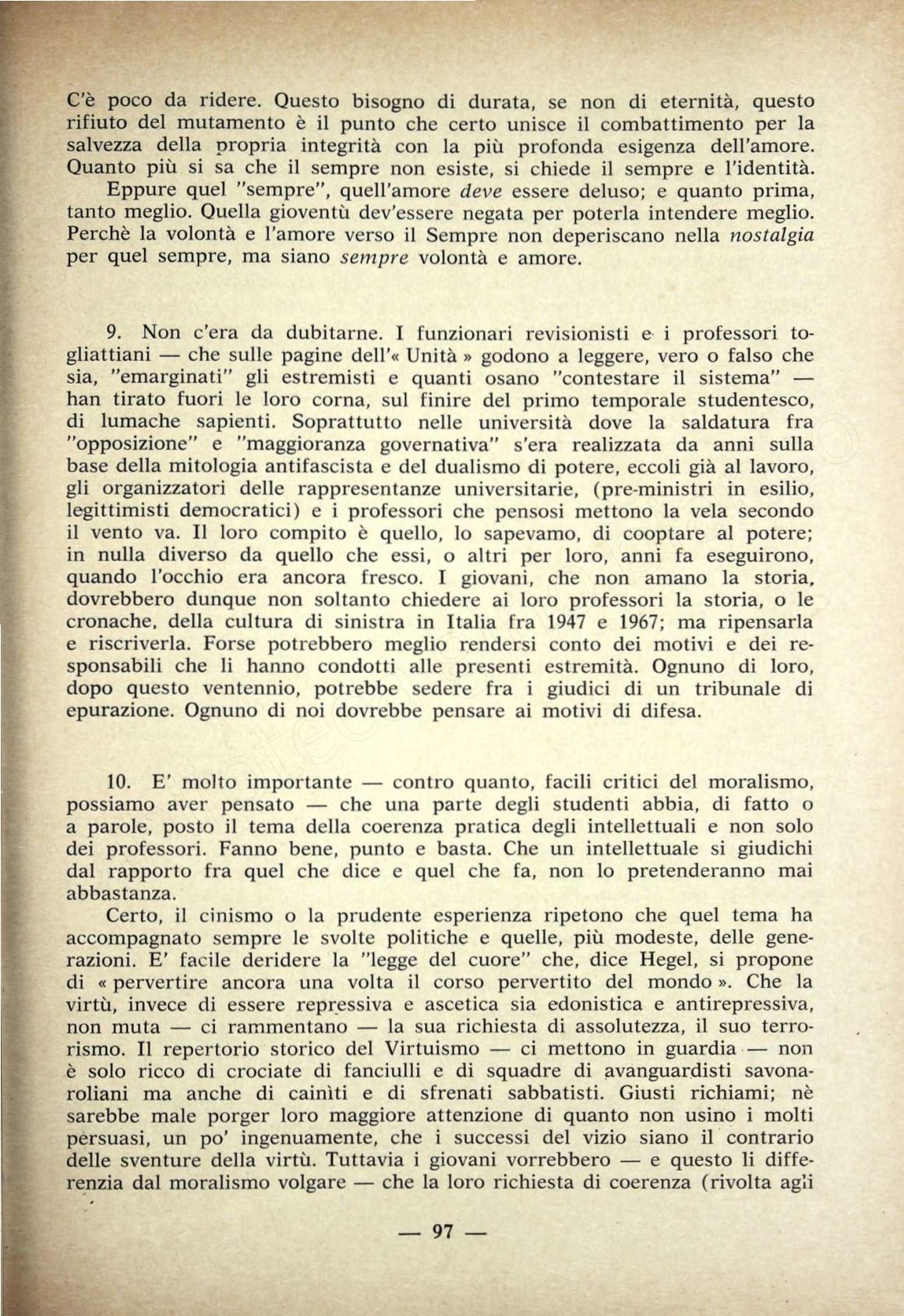
C'è poco da ridere. Questo bisogno d i durata, se non d i eternità, questo
rifiuto del mutamento è i l punto che certo unisce i l combattimento per la
salvezza della propria integrità con l a più profonda esigenza dell'amore.
Quanto più si sa che i l sempre non esiste, si chiede i l sempre e l'identità.
Eppure quel "sempre", quell'amore
deve
essere deluso; e quanto prima,
tanto meglio. Quella gioventù dev'essere negata per poterla intendere meglio.
Perchè la volontà e l'amore verso i l Sempre non deperiscano nella
nostalgia
per quel sempre, ma siano
sempre
volontà e amore.
9. N o n c'era da dubitarne. I funzionari revisionisti e i professori to-
gliattiani — che sulle pagine dell'« Unità » godono a leggere, vero o falso che
sia, "emarginati" gl i estremisti e quanti osano "contestare i l sistema"
han tirato fuori le loro corna, sul finire del primo temporale studentesco,
di lumache sapienti. Soprattutto nelle università dove l a saldatura f r a
"opposizione" e "maggioranza governativa" s'era realizzata da anni sulla
base della mitologia antifascista e del dualismo di potere, eccoli già al lavoro,
gli organizzatori delle rappresentanze universitarie, (pre-ministri i n esilio,
legittimisti democratici) e i professori che pensosi mettono la vela secondo
il vento va. I l loro compito è quello, lo sapevamo, di cooptare al potere;
in nulla diverso da quello che essi, o al tri per loro, anni f a eseguirono,
quando l'occhio era ancora fresco. I giovani, che non amano l a storia,
dovrebbero dunque non soltanto chiedere ai loro professori la storia, o le
cronache, della cultura di sinistra in Italia fra 1947 e 1967; ma ripensarla
e riscriverla. Forse potrebbero meglio rendersi conto dei motivi e dei re-
sponsabili che l i hanno condotti alle presenti estremità. Ognuno d i loro,
dopo questo ventennio, potrebbe sedere f ra i giudici d i un tribunale d i
epurazione. Ognuno di noi dovrebbe pensare ai motivi di difesa.
10. E ' molto importante c o n t r o quanto, facili critici del moralismo,
possiamo aver pensato — che una parte degli studenti abbia, d i fatto o
a parole, posto i l tema della coerenza pratica degli intellettuali e non solo
dei professori. Fanno bene, punto e basta. Che un intellettuale si giudichi
dal rapporto f ra quel che dice e quel che fa, non lo pretenderanno mai
abbastanza.
Certo, i l cinismo o la prudente esperienza ripetono che quel tema ha
accompagnato sempre le svolte politiche e quelle, più modeste, delle gene-
razioni. E ' facile deridere la "legge del cuore" che, dice Hegel, si propone
di « pervertire ancora una volta i l corso pervertito del mondo ». Che l a
virtù, invece di essere repressiva e ascetica sia edonistica e antirepressiva,
non muta — ci rammentano — la sua richiesta di assolutezza, i l suo terro-
rismo. I l repertorio storico del Virtuismo — ci mettono in guardia — non
è solo ricco di crociate di fanciulli e d i squadre d i Avanguardisti savona-
roliani ma anche d i cainìti e d i sfrenati sabbatisti. Giusti richiami; n è
sarebbe male porger loro maggiore attenzione di quanto non usino i molti
persuasi, un po' ingenuamente, che i successi del vizio siano i l contrario
delle sventure della virtù. Tuttavia i giovani vorrebbero — e questo l i diffe-
renzia dal moralismo volgare c h e la loro richiesta di coerenza (rivolta agli
— 97