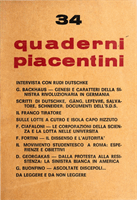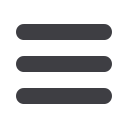
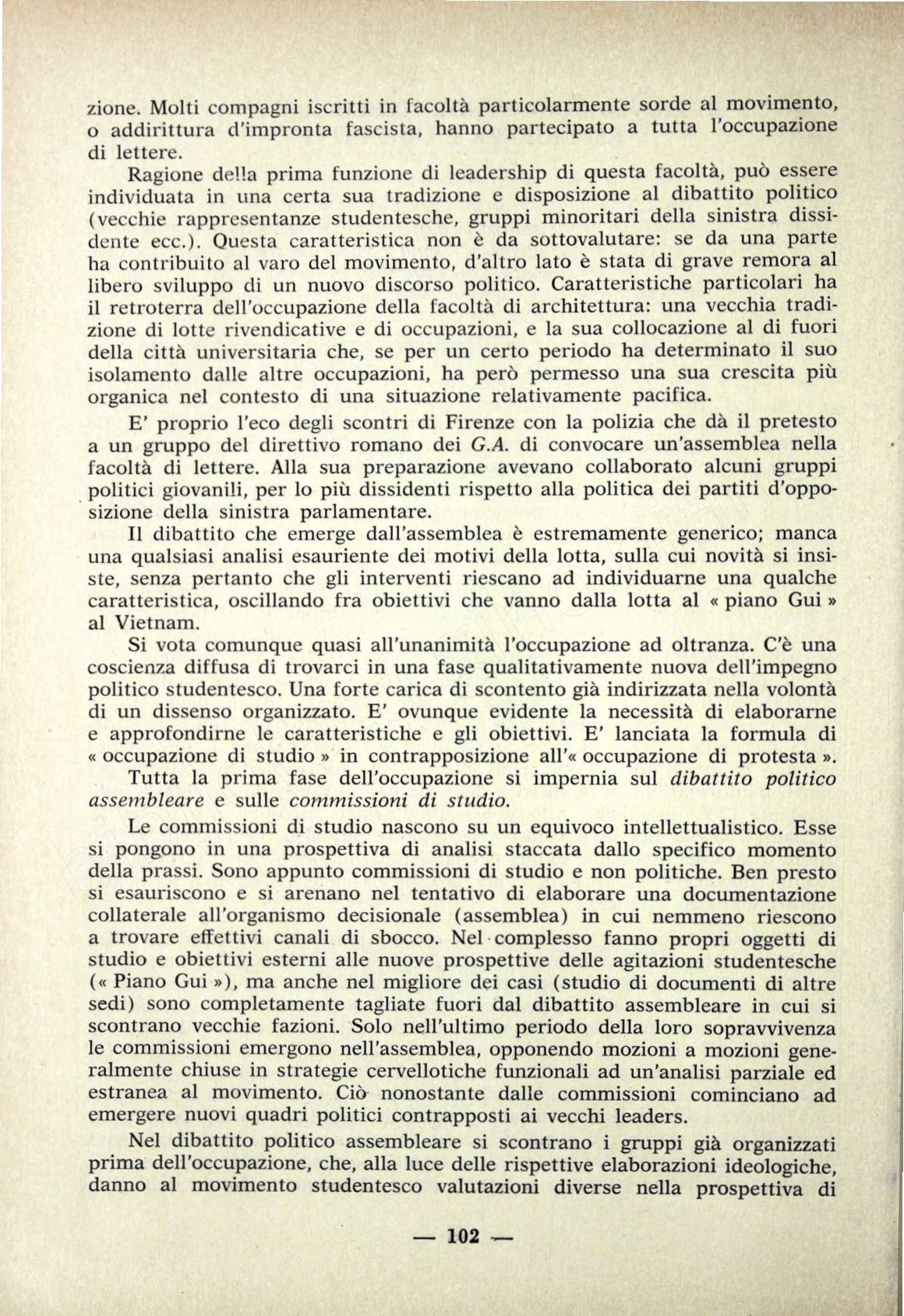
zione. Mo l t i compagni iscr i t t i i n facoltà particolarmente sorde al movimento,
o addi r i t tura d ' impronta fascista, hanno par tecipato a t u t t a l 'occupazione
di lettere.
Ragione del la pr ima funzione d i leadership d i questa facoltà, può essere
individuata i n una cer ta sua tradizione e disposizione a l d i ba t t i t o pol i t i co
(vecchie rappresentanze studentesche, gruppi mi nor i tar i del la sinist ra dissi-
dente ecc.). Questa carat ter ist ica non è da sottovalutare: se da una par te
ha cont r ibui to al varo del movimento, d'al t ro lato è stata d i grave remora al
libero svi luppo d i un nuovo discorso pol i t ico. Caratteristiche par t icolar i ha
i l ret roterra dell'occupazione del la facol tà d i archi tet tura: una vecchia t radi -
zione d i lot te rivendicative e d i occupazioni, e la sua collocazione al d i f uor i
della c i t tà universi tar ia che, se per un cer to per iodo ha determinato i l suo
isolamento dal le a l t re occupazioni, ha però permesso una sua cresci ta p i ù
organica ne l contesto d i una situazione relat ivamente paci f ica.
E' propr io l 'eco degl i scontr i d i Firenze con la pol izia che dà i l pretesto
a un gruppo del di ret t ivo romano dei
G.A.
d i convocare un'assemblea nel la
facoltà d i lettere. A l l a sua preparazione avevano col laborato al cuni grupp i
pol i t ici giovani l i, per lo più dissidenti r ispet to al la pol i t ica dei par t i t i d'oppo-
sizione del la sinistra parlamentare.
I l dibat t i to che emerge dall'assemblea è estremamente generico; manca
una qualsiasi analisi esauriente dei mot ivi del la lotta, sul la cui novi tà si insi-
ste, senza pertanto che g l i intervent i riescano ad individuarne una qualche
caratteristica, osci l lando f r a obiet t ivi che vanno dal la l ot ta a l « piano Gu i »
al Vietnam.
Si vota comunque quasi al l 'unanimi tà l'occupazione ad oltranza. C'è una
coscienza di ffusa di trovarci i n una fase qual itativamente nuova del l ' impegno
pol itico studentesco. Una forte carica di scontento già indirizzata nella volontà
di un dissenso organizzato. E ' ovunque evidente l a necessità d i elaborarne
e approfondi rne l e caratterist iche e g l i obiet t ivi . E ' lanciata l a f ormu l a d i
«occupazione d i studio)> i n contrapposizione al l '« occupazione d i protesta ».
Tutta l a p r ima fase dell'occupazione s i impernia su l
d i ba t t i t o po l i t i co
assembleare e sul le commissioni d i studio.
Le commissioni d i studio nascono su un equivoco intel lettual ist ico. Esse
si pongono i n una prospet t iva d i anal isi staccata da l l o speci f ico momento
della prassi. Sono appunto commissioni d i studio e non pol itiche. Ben presto
si esauriscono e s i arenano ne l tentat ivo d i elaborare una documentazione
collaterale al l 'organismo decisionale (assemblea) i n cu i nemmeno riescono
a t rovare effet t ivi canal i d i sbocco. Ne l complesso fanno p r op r i ogget t i d i
studio e obiet t ivi esterni al le nuove prospettive del le agitazioni studentesche
(« Piano Gui »), ma anche nel migl iore dei casi (studio d i document i d i al t re
sedi) sono completamente tagl iate f uo r i da l dibat t i to assembleare i n cu i s i
scontrano vecchie fazioni. Solo nel l 'ul t imo per iodo del la l o r o sopravvivenza
le commissioni emergono nell'assemblea, opponendo mozioni a mozioni gene-
ralmente chiuse i n strategie cervellotiche funzional i ad un'anal isi parziale ed
estranea a l movimento. C i ò nonostante da l l e commissioni cominciano a d
emergere nuovi quadr i pol i t ici contrappost i ai vecchi leaders.
Nel dibat t i to pol i t ico assembleare s i scontrano i gruppi già organizzati
prima dell'occupazione, che, alla luce delle rispettive elaborazioni ideologiche,
danno a l mov imento studentesco valutazioni diverse ne l l a prospet t iva d i
102 ,