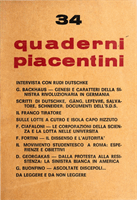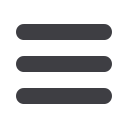

il tono era p i ù gi rondino che giacobino e po i p i ù giacobino che marxista.
Si può misurare l'ampiezza del vuoto lasciato dai par t i t i e dal la l oro dimis-
sione — per non di re, p i ù i n genere, dall'educazione repubbl icana-democra-
tica — dal fat to che quasi nessuno ha fondato la sua rivendicazione d i gioia,
integrità e autenticità su di una considerazione delle ragioni storiche e sociali
che facevano nascere quel bisogno e quel di r i t to, ma l o ha rivendicato come
un d i r i t t o naturale e ne ha fat to l o scopo d i ogrA azione ( i n questo almeno
giustificando l e interpretazioni socio-psicologiche del "desider io dissidente")
(2), sempre avendo all'orizzonte le grandi parole d i imperial ismo, socialismo,
rivoluzione, nel le forme che i l supermarket cul turale era venuto proponendo
negli u l t imi tempi . Nul la esprime megl io l a catastrofe del la generazione che
oggi è f r a i quaranta e cinquant 'anni : i giovani pronunciano l e mete del la
rivoluzione social ista ignorandone i pr i nc i p i , sono p i ù v i c i n i ag l i u t op i s t i
che a Lenin. Non sanno; e dovranno imparare con pena.
Se l a richiesta et ica s i fosse misurata al la real tà dei rappor t i d i classe,
gioia, integr i tà e autent ici tà sarebbero faci lmente apparse, come sono, beni
non individual i che s i realizzano solo nell 'azione comune pe r una meta, d i
cui essi non sono che i l benef ico
fal l-out,
i l "sovrappiù". E invece, ident i f i -
cando con l'appassionata protesta cont ro l a mor te, che è d i
ogn i
giovane,
le f inal i tà pol i t iche del movimento, non s i f a che offuscarle. F i n che l ' iden-
tificazione è compiuta dag l i student i stessi , poco male. M a n o n s i deve
contribuire a indebol i re i n moral ismo l a dissidenza e a dissolvere i l desi-
derio i n estetismo.
Posizioni s imi l i sono cer to d i t u t t a un'ala de l movimento giovani le o
studentesco internazionale; che si è sempre fat ta sentire anche i n alcune r ivi -
ste. Esse sembrano in adorazione dell'angoscia di classe — come senso di una
crescente i l legi t t imi tà, d'una distruzione del l ' ident i tà — che tende a sormon-
tarsi nel la tensione tragica chiedendo l ' immediata realizzazione del soggetto.
Esaltano esse l a catastrofe oblat iva d i una gioventù pur issima e satanica,
per la moltiplicazione dionisiaca che da quell'angoscia si ripromettono. Al lora
bisogna esser mo l t o espl ici t i : bisogna dichiarare che ognuno è padrone d i
essere neonietzschiano ma non d i par lare, nel lo stesso tempo, d i condizio-
namento d i classe o d i proletar iato. E ' i l caso, di rei , d i ch i a r i r megl io l e
proprie responsabilità ideologiche. E a questo punto dovrebbe essere r ipetuto
senza equivoci che i l discorso marxista
non
è però una al ternat iva a quel le
ipotesi di comportamento, non ha niente a che fare con la "fel ici tà", non può
proporre a l t r o c he u n a interpretaizone
parziale
d e l mondo e sape r d i
proporla.
E quando s i dice parziale, cominciamo a prendere questo termine anzi-
tutto nel suo senso p i ù for te e corrente, non faci lmente dialet t ico — come
invece s i f a d i sol i to quando «parzial i tà proletar ia » viene ident i f icata a l l a
volenterosa Negazione de l l a Negazione, s ì che t i r i p r end i con u n a mano
quel che avevi lasciato sfuggire dal l 'al tra, non senza po i tender d i muscol i
e ar rotar d i dent i da tenebrosi Geni del la Distruzione e dell'Odio... Non c'è
bisogno d i t ruccarsi i n tragico. La real tà è già abbastanza severa. Quel che
di s t r i du l o e atroce, d i disperato e dissipato s'accompagna d a u n secolo
all'impresa de l socialismo, e nessun festone celebrat ivo l o nasconderà, non
(2) Mi riferisco al lo scritto d i
E.
Fachinelli nel n. 33 d i
Q.P.
92