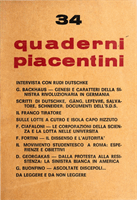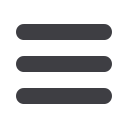
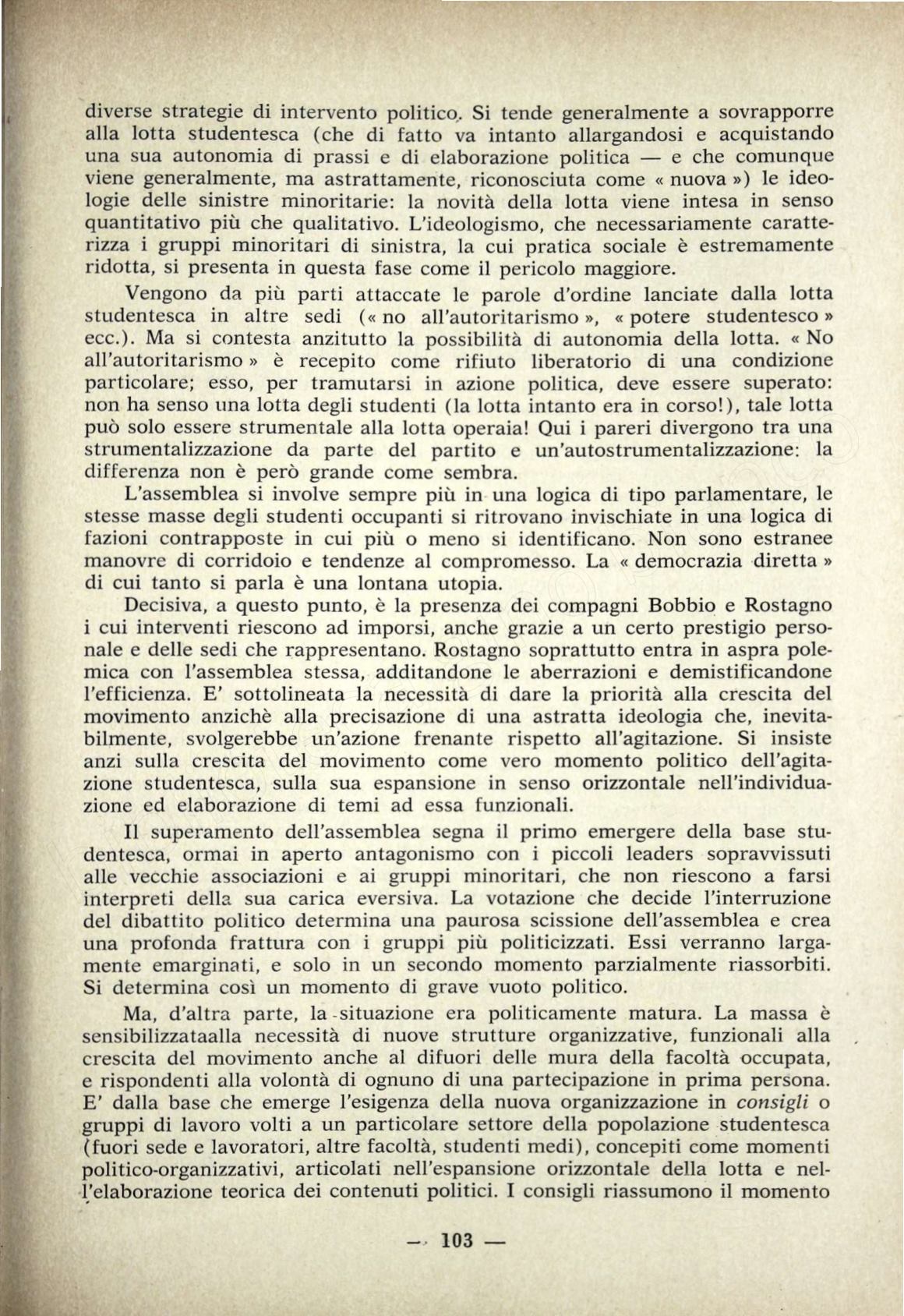
diverse strategie d i intervento politico.. Si tende generalmente a sovrapporre
alla l o t t a studentesca ( che d i f a t t o v a i ntanto al largandosi e acquistando
una sua autonomia d i prassi e d i elaborazione pol i t ica — e che comunque
viene generalmente, ma astrattamente, riconosciuta come (< nuova ») l e ideo-
logie del le sinist re minor i tar ie: l a nov i tà del la l o t t a viene intesa i n senso
quantitativo p i ù che qual i tat ivo. L'ideologismo, che necessariamente caratte-
rizza i gruppi mi nor i t ar i d i sinistra, l a cu i prat ica sociale è estremamente
ridotta, si presenta in questa fase come i l pericolo maggiore.
Vengono da p i ù pa r t i attaccate l e parole d'ordine lanciate da l l a l o t t a
studentesca i n a l t r e sed i ( « no al l 'autor i tar ismo », « potere studentesco »
ecc.). Ma s i contesta anzi tut to l a possibi l i tà d i autonomia del la lot ta. « No
al l 'autor i tar ismo» è recepi to come r i f i u t o l i be r a t o r i o d i u n a condizione
particolare; esso, pe r t ramutars i i n azione pol i t ica, deve essere superato:
non ha senso una lotta degli studenti ( la lotta intanto era in corso!), tale lot ta
può solo essere strumentale al la lot ta operaia! Qui i parer i divergono t ra una
strumentalizzazione d a pa r t e d e l pa r t i t o e un'autostrumentalizzazione: l a
differenza non è però grande come sembra.
L'assemblea si involve sempre p i ù i n una logica d i t i po parlamentare, le
stesse masse degl i studenti occupanti si r i trovano invischiate i n una logica d i
fazioni contrapposte i n cu i p i ù o meno s i ident i f icano. No n sono estranee
manovre d i corr idoio e tendenze a l compromesso. La « democrazia d i re t t a»
di cui tanto si par la è una lontana utopia.
Decisiva, a questo punto, è la presenza dei compagni Bobbio e Rostagno
i cui intervent i riescono ad imporsi , anche grazie a un certo prest igio perso-
nale e delle sedi che rappresentano. Rostagno soprattutto entra in aspra pole-
mica con l'assemblea stessa, additandone l e aberrazioni e demist i f icandone
l'efficienza. E ' sottol ineata l a necessità d i dare l a pr i or i tà al la cresci ta de l
movimento anzichè a l l a precisazione d i una ast rat ta ideologia che, inevi ta-
bilmente, svolgerebbe un'azione f renante r i spet to al l 'agitazione. S i ins i ste
anzi su l l a cresci ta de l movimento come vero momento po l i t i co del l 'agi ta-
zione studentesca, sul la sua espansione i n senso orizzontale nel l ' individua-
zione ed elaborazione d i t emi ad essa funzional i .
I l superamento dell'assemblea segna i l p r imo emergere del la base stu-
dentesca, o rma i i n aper to antagonismo con i pi ccol i leaders sopravvissut i
alle vecchie associazioni e a i grupp i mi nor i tar i , che non r iescono a f a r s i
interpret i del la sua car ica eversiva. L a votazione che decide l ' interruzione
del dibat t i to pol i t ico determina una paurosa scissione dell'assemblea e crea
una profonda f r a t t u r a con i grupp i p i ù pol i t icizzat i . Ess i ver ranno larga-
mente emarginat i , e solo i n un secondo momento parzialmente r iassorbi t i .
Si determina così un momento d i grave vuoto pol i t ico.
Ma, d ' a l t ra par te, l a -situazione era pol i t icamente matura. L a massa è
sensibilizzataalla necessità d i nuove s t rut ture organizzative, funzional i a l l a
crescita de l movimento anche a l d i f uor i del le mura del la facol tà occupata,
e rispondent i al la volontà di ognuno d i una partecipazione i n pr ima persona.
E' dal la base che emerge l'esigenza del la nuova organizzazione i n
consigl i
o
gruppi d i lavoro vol t i a un part icolare settore del la popolazione studentesca
( fuor i sede e lavoratori, altre facoltà, studenti medi), concepiti come moment i
pol itico-organizzativi, ar t icolat i nell'espansione orizzontale del la l o t t a e nel -
l'elaborazione teorica dei contenuti pol i t ici . I consigli riassumono i l momento
—• 103 —