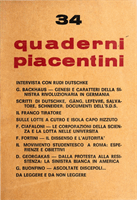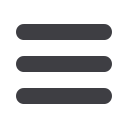
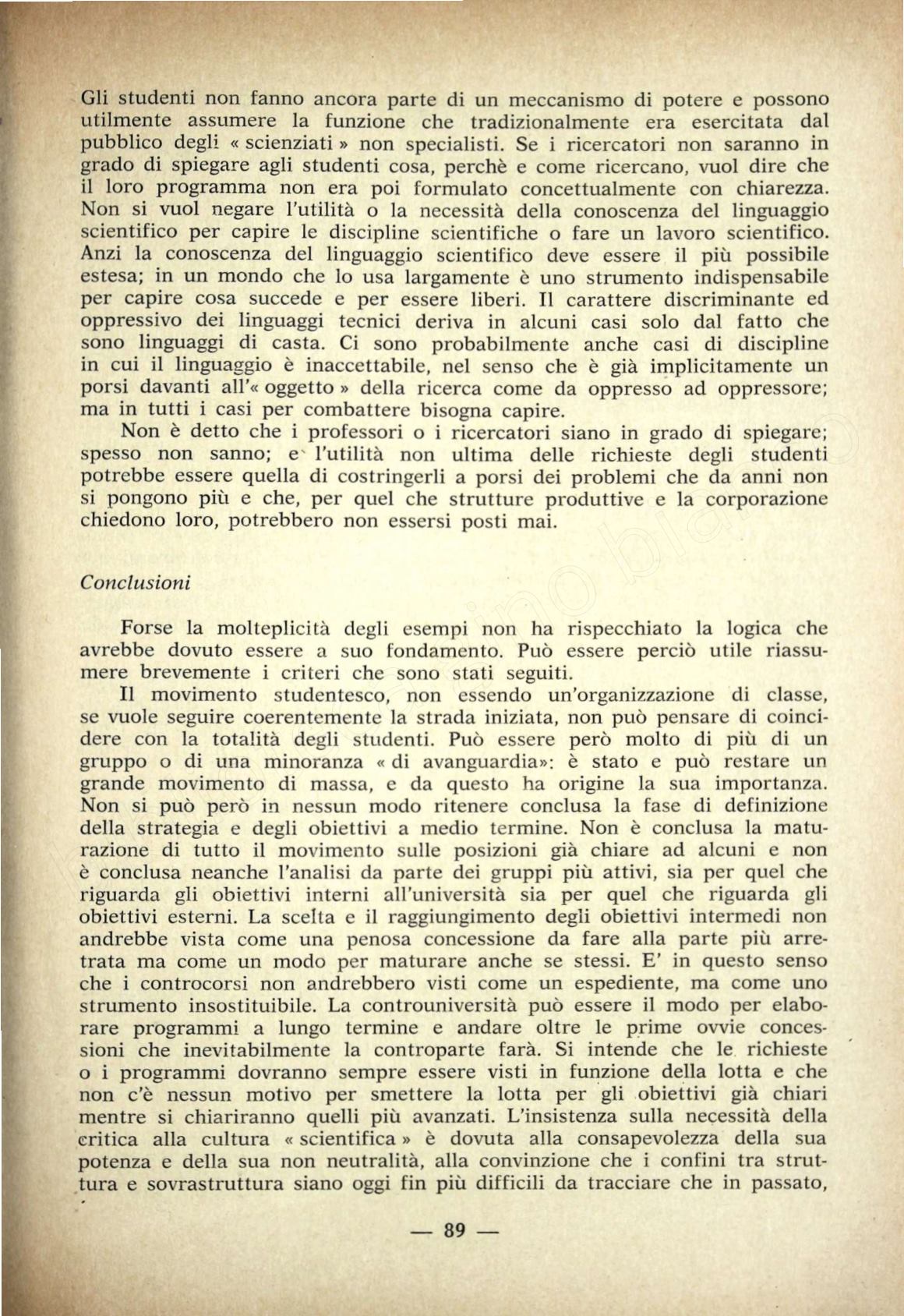
Gli studenti non fanno ancora parte d i un meccanismo d i potere e possono
utilmente assumere l a funzione che tradizionalmente e r a esercitata d a l
pubblico degl i « scienziati » non specialisti. Se i ricercatori non saranno i n
grado di spiegare agli studenti cosa, perchè e come ricercano, vuol di re che
il l oro programma non era po i formulato concettualmente con chiarezza.
Non s i vuol negare l 'ut i l i tà o l a necessità del la conoscenza del linguaggio
scientifico per capire le discipline scientifiche o fare un lavoro scientifico.
Anzi l a conoscenza de l linguaggio scientifico deve essere i l p i ù possibi le
estesa; i n un mondo che lo usa largamente è uno strumento indispensabile
per capire cosa succede e per essere l iber i . I l carattere discriminante ed
oppressivo de i l inguaggi tecnici der iva i n alcuni casi solo da l f a t t o che
sono linguaggi d i casta. C i sono probabi lmente anche casi d i discipl ine
in cu i i l linguaggio è inaccettabile, nel senso che è già implicitamente un
porsi davanti al l '« oggetto » del la ricerca come da oppresso ad oppressore;
ma i n t u t t i i casi per combattere bisogna capire.
Non è detto che i professori o i ricercatori siano i n grado d i spiegare;
spesso n o n sanno; e - l 'ut i l i tà n o n u l t ima de l l e r ichieste deg l i student i
potrebbe essere quella d i costringerli a porsi dei problemi che da anni non
si pongono p i ù e che, per quel che strut ture produtt ive e l a corporazione
chiedono loro, potrebbero non essersi posti mai.
Conclusioni
Forse l a mol tepl ici tà degl i esempi non ha rispecchiato l a logica che
avrebbe dovuto essere a suo fondamento. Può essere perciò ut i l e riassu-
mere brevemente i cr i ter i che sono stat i seguiti.
I l movimento studentesco, n o n essendo un'organizzazione d i classe,
se vuole seguire coerentemente la strada iniziata, non può pensare d i coinci-
dere con l a total i tà degl i studenti. Può essere però mo l to d i p i ù d i u n
gruppo o d i una minoranza « di avanguardia»: è stato e può restare u n
grande movimento d i massa, e da questo ha origine l a sua importanza.
Non s i può però i n nessun modo ritenere conclusa l a fase d i definizione
della strategia e degl i obiet t ivi a medio termine. Non è conclusa l a matu-
razione d i t u t t o i l movimento sul le posizioni g i à chiare ad alcuni e non
è conclusa neanche l'analisi da parte dei gruppi p i ù attivi, sia per quel che
riguarda g l i obiet t ivi i ntern i al l 'università s i a pe r quel che r iguarda g l i
obiettivi esterni. La scelta e i l raggiungimento degli obiett ivi intermedi non
andrebbe vista come una penosa concessione da fare al la parte p i ù arre-
trata ma come un modo per maturare anche se stessi. E ' i n questo senso
che i controcorsi non andrebbero vist i come un espediente, ma come uno
strumento insostituibile. La controuniversità può essere i l modo per elabo-
rare programmi a lungo termine e andare o l t re l e pr ime ovvie conces-
sioni che inevitabilmente l a controparte farà. S i intende che l e richieste
o i programmi dovranno sempre essere vist i i n funzione del la lot ta e che
non c 'è nessun mot i vo pe r smettere l a l o t t a pe r g l i obiet t ivi g i à ch i ar i
mentre s i chiariranno quel l i p i ù avanzati. L'insistenza sul la necessità del la
critica a l l a cul tura « scientifica» è dovuta a l l a consapevolezza del la sua
potenza e del la sua non neutralità, al la convinzione che i conf ini t r a strut-
tura e sovrastruttura siano oggi f i n p i ù di ff ici l i da tracciare che i n passato,
— 89