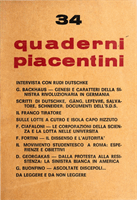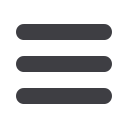
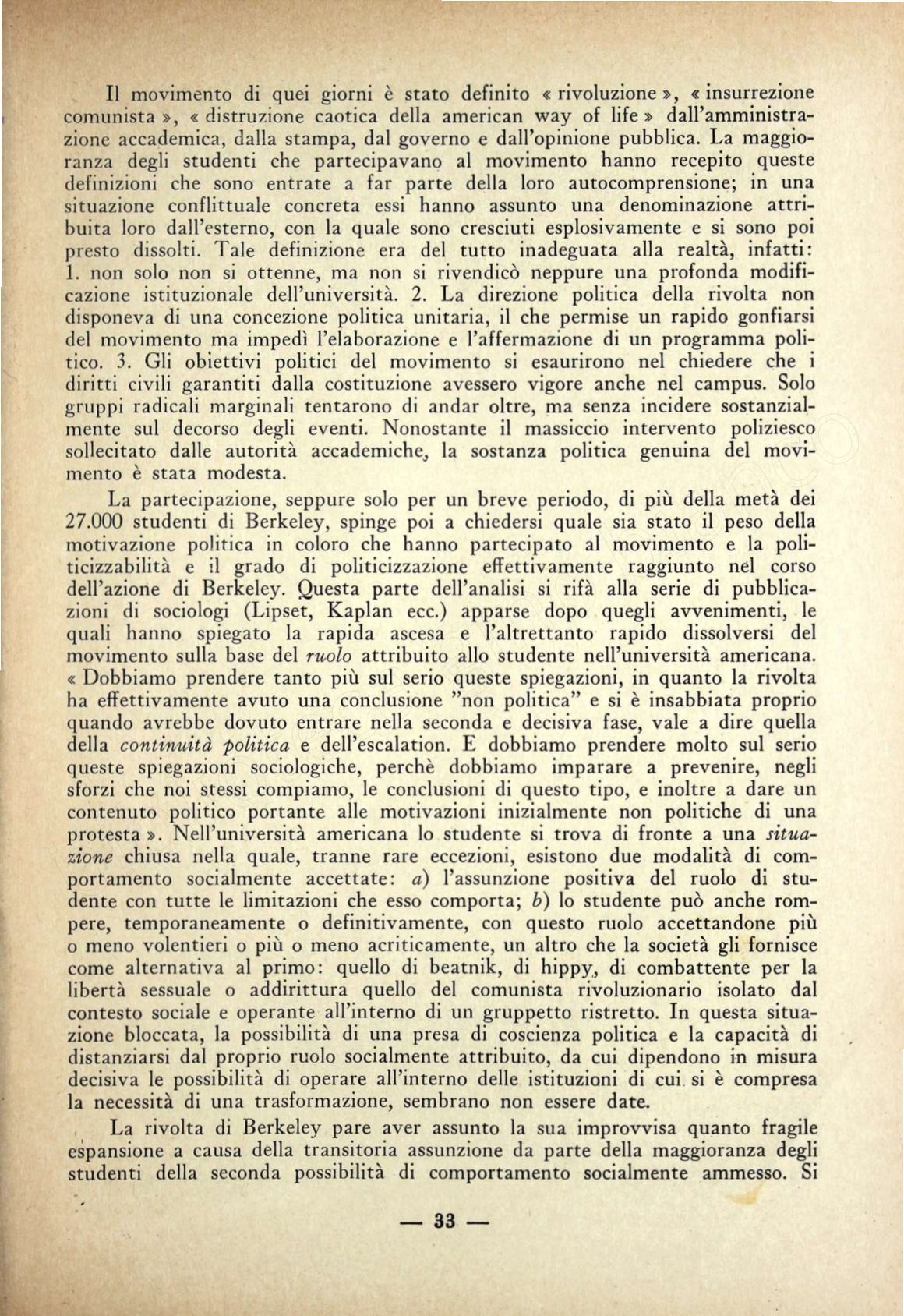
Il movimento di quei giorni è stato definito « rivoluzione », « insurrezione
comunista », « distruzione caotica della american way of life » dall'amministra-
zione accademica, dalla stampa, dal governo e dall'opinione pubblica. La maggio-
ranza degli studenti che partecipavano al movimento hanno recepito queste
definizioni che sono entrate a far parte della loro autocomprensione; i n una
situazione conflittuale concreta essi hanno assunto una denominazione attr i -
buita loro dall'esterno, con la quale sono cresciuti esplosivamente e si sono poi
presto dissolti. Tale definizione era del tut to inadeguata alla realtà, infatti:
1.
non solo non si ottenne, ma non si rivendicò neppure una profonda modifi-
cazione istituzionale dell'università. 2. La direzione politica della rivolta non
disponeva di una concezione politica unitaria, i l che permise un rapido gonfiarsi
del movimento ma impedì l'elaborazione e l'affermazione di un programma poli-
tico. 3. Gl i obiettivi politici del movimento si esaurirono nel chiedere che i
diritti civili garantiti dalla costituzione avessero vigore anche nel campus. Solo
gruppi radicali marginali tentarono di andar oltre, ma senza incidere sostanzial-
mente sul decorso degli eventi. Nonostante i l massiccio intervento poliziesco
sollecitato dalle autorità accademiche, la sostanza politica genuina del movi-
mento è stata modesta.
La partecipazione, seppure solo per un breve periodo, di più della metà dei
27.000 studenti di Berkeley, spinge poi a chiedersi quale sia stato i l peso della
motivazione politica in coloro che hanno partecipato al movimento e la poli-
ticizzabilità e i l grado d i politicizzazione effettivamente raggiunto nel corso
dell'azione di Berkeley. Questa parte dell'analisi si rifà alla serie di pubblica-
zioni d i sociologi (Lipset, Kaplan ecc.) apparse dopo quegli avvenimenti, le
quali hanno spiegato l a rapida ascesa e l'altrettanto rapido dissolversi del
movimento sulla base del
ruolo
attribuito allo studente nell'università americana.
«Dobbiamo prendere tanto più sul serio queste spiegazioni, in quanto la rivolta
ha effettivamente avuto una conclusione "non politica" e si è insabbiata proprio
quando avrebbe dovuto entrare nella seconda e decisiva fase, vale a dire quella
della
continuità politica
e dell'escalation. E dobbiamo prendere molto sul serio
queste spiegazioni sociologiche, perchè dobbiamo imparare a prevenire, negli
sforzi che noi stessi compiamo, le conclusioni di questo tipo, e inoltre a dare un
contenuto politico portante alle motivazioni inizialmente non politiche di una
protesta ». Nell'università americana lo studente si trova di fronte a una
situa-
zione
chiusa nella quale, tranne rare eccezioni, esistono due modalità di com-
portamento socialmente accettate:
a )
l'assunzione positiva del ruolo d i stu-
dente con tutte le limitazioni che esso comporta;
b)
lo studente può anche rom-
pere, temporaneamente o definitivamente, con questo ruolo accettandone più
omeno volentieri o più o meno acriticamente, un altro che la società gli fornisce
come alternativa al primo: quello di beatnik, di hippy, di combattente per la
libertà sessuale o addirittura quello del comunista rivoluzionario isolato dal
contesto sociale e operante all'interno di un gruppetto ristretto. In questa situa-
zione bloccata, la possibilità di una presa di coscienza politica e la capacità di
distanziarsi dal proprio ruolo socialmente attribuito, da cui dipendono in misura
decisiva le possibilità di operare all'interno delle istituzioni di cui si è compresa
la necessità di una trasformazione, sembrano non essere date.
La rivolta di Berkeley pare aver assunto la sua improvvisa quanto fragile
espansione a causa della transitoria assunzione da parte della maggioranza degli
studenti della seconda possibilità d i comportamento socialmente ammesso. Si
33