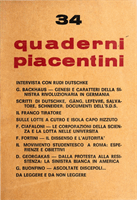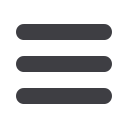
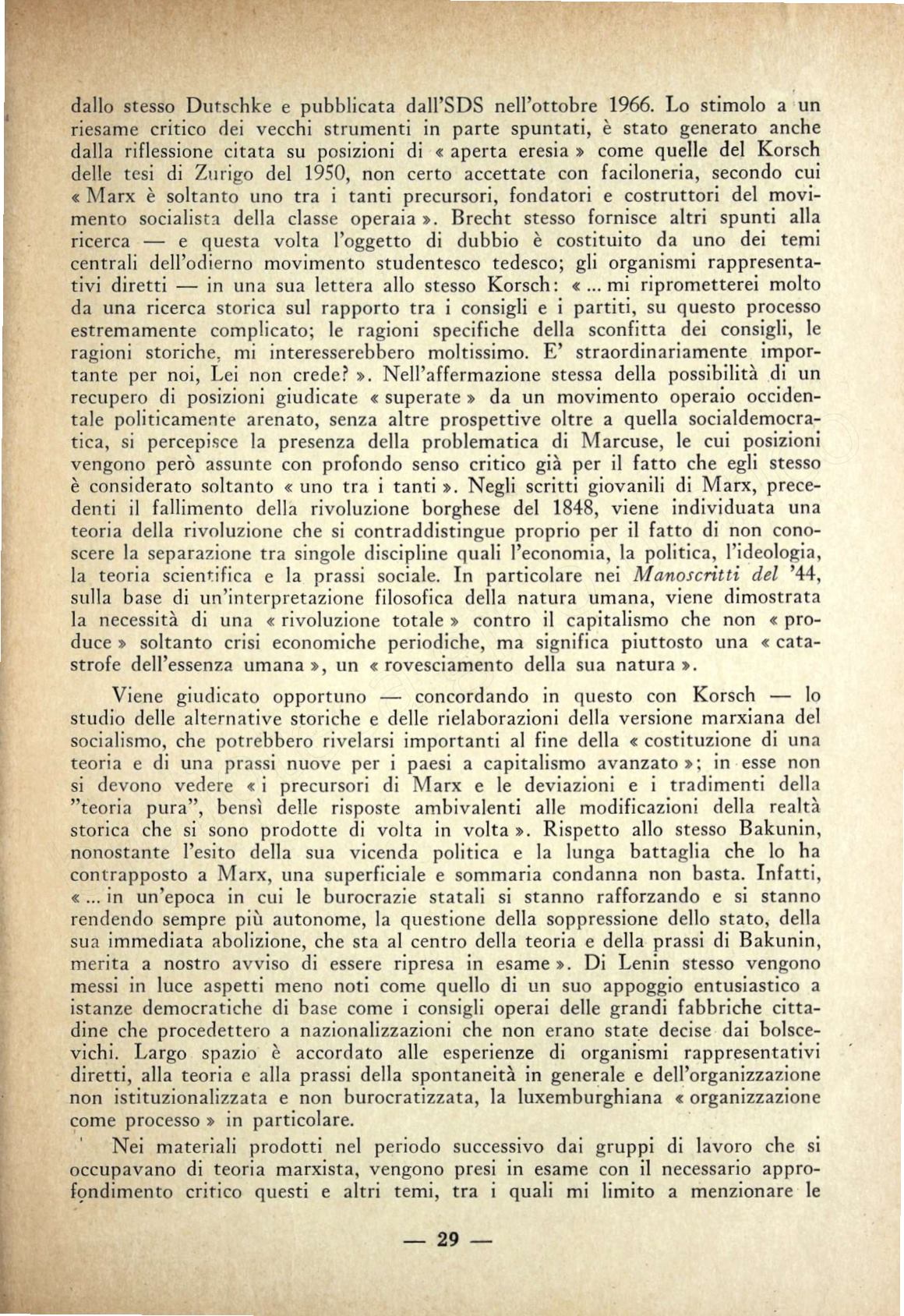
dallo stesso Dutschke e pubblicata dall'SDS nell'ottobre 1966. Lo stimolo a un
riesame critico dei vecchi strumenti in parte spuntati, è stato generato anche
dalla riflessione citata su posizioni di « aperta eresia » come quelle del Korsch
delle tesi di Zurigo del 1950, non certo accettate con faciloneria, secondo cui
«Marx è soltanto uno tra i tanti precursori, fondatori e costruttori del movi-
mento socialista della classe operaia ». Brecht stesso fornisce altri spunti alla
ricerca — e questa volta l'oggetto d i dubbio è costituito da uno dei temi
centrali dell'odierno movimento studentesco tedesco; gli organismi rappresenta-
tivi diretti — in una sua lettera allo stesso Korsch: « ... mi riprometterei molto
da una ricerca storica sul rapporto tra i consigli e i partiti, su questo processo
estremamente complicato; le ragioni specifiche della sconfitta dei consigli, le
ragioni storiche, mi interesserebbero moltissimo. E ' straordinariamente impor-
tante per noi, Lei non crede? ». Nell'affermazione stessa della possibilità di un
recupero di posizioni giudicate « superate» da un movimento operaio occiden-
tale politicamente arenato, senza altre prospettive oltre a quella socialdemocra-
tica, si percepisce la presenza della problematica di Marcuse, le cui posizioni
vengono però assunte con profondo senso critico già per i l fatto che egli stesso
èconsiderato soltanto €uno tra i tanti ». Negli scritti giovanili di Marx, prece-
denti i l fallimento della rivoluzione borghese del 1848, viene individuata una
teoria della rivoluzione che si contraddistingue proprio per i l fatto di non cono-
scere la separazione tra singole discipline quali l'economia, la politica, l'ideologia,
la teoria scientifica e la prassi sociale. I n particolare nei
Manoscritti del '44,
sulla base di un'interpretazione filosofica della natura umana, viene dimostrata
la necessità di una « rivoluzione totale » contro i l capitalismo che non « pro-
duce» soltanto crisi economiche periodiche, ma significa piuttosto una « cata-
strofe dell'essenza umana », un « rovesciamento della sua natura ».
Viene giudicato opportuno — concordando i n questo con Korsch l o
studio delle alternative storiche e delle rielaborazioni della versione marxiana del
socialismo, che potrebbero rivelarsi importanti al fine della « costituzione di una
teoria e di una prassi nuove per i paesi a capitalismo avanzato»; in esse non
si devono vedere « i precursori d i Marx e le deviazioni e i tradimenti della
"teoria pura", bensì delle risposte ambivalenti alle modificazioni della realtà
storica che si sono prodotte di volta in volta ». Rispetto allo stesso Bakunin,
nonostante l'esito della sua vicenda politica e la lunga battaglia che l o ha
contrapposto a Marx, una superficiale e sommaria condanna non basta. Infatti,
«... in un'epoca in cui le burocrazie statali si stanno rafforzando e si stanno
rendendo sempre più autonome, la questione della soppressione dello stato, della
sua immediata abolizione, che sta al centro della teoria e della prassi di Bakunin,
merita a nostro avviso di essere ripresa in esame ». Di Lenin stesso vengono
messi in luce aspetti meno noti come quello di un suo appoggio entusiastico a
istanze democratiche di base come i consigli operai delle grandi fabbriche citta-
dine che procedettero a nazionalizzazioni che non erano state decise dai bolsce-
vichi. Largo spazio è accordato alle esperienze d i organismi rappresentativi
diretti, alla teoria e alla prassi della spontaneità in generale e dell'organizzazione
non istituzionalizzata e non burocratizzata, la luxemburghiana « organizzazione
comeprocesso» in particolare.
Nei materiali prodotti nel periodo successivo dai gruppi di lavoro che si
occupavano di teoria marxista, vengono presi in esame con i l necessario appro-
fondimento critico questi e altri temi, tra i quali mi limito a menzionare le
29