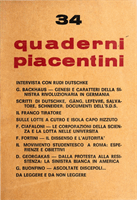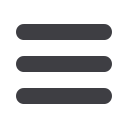
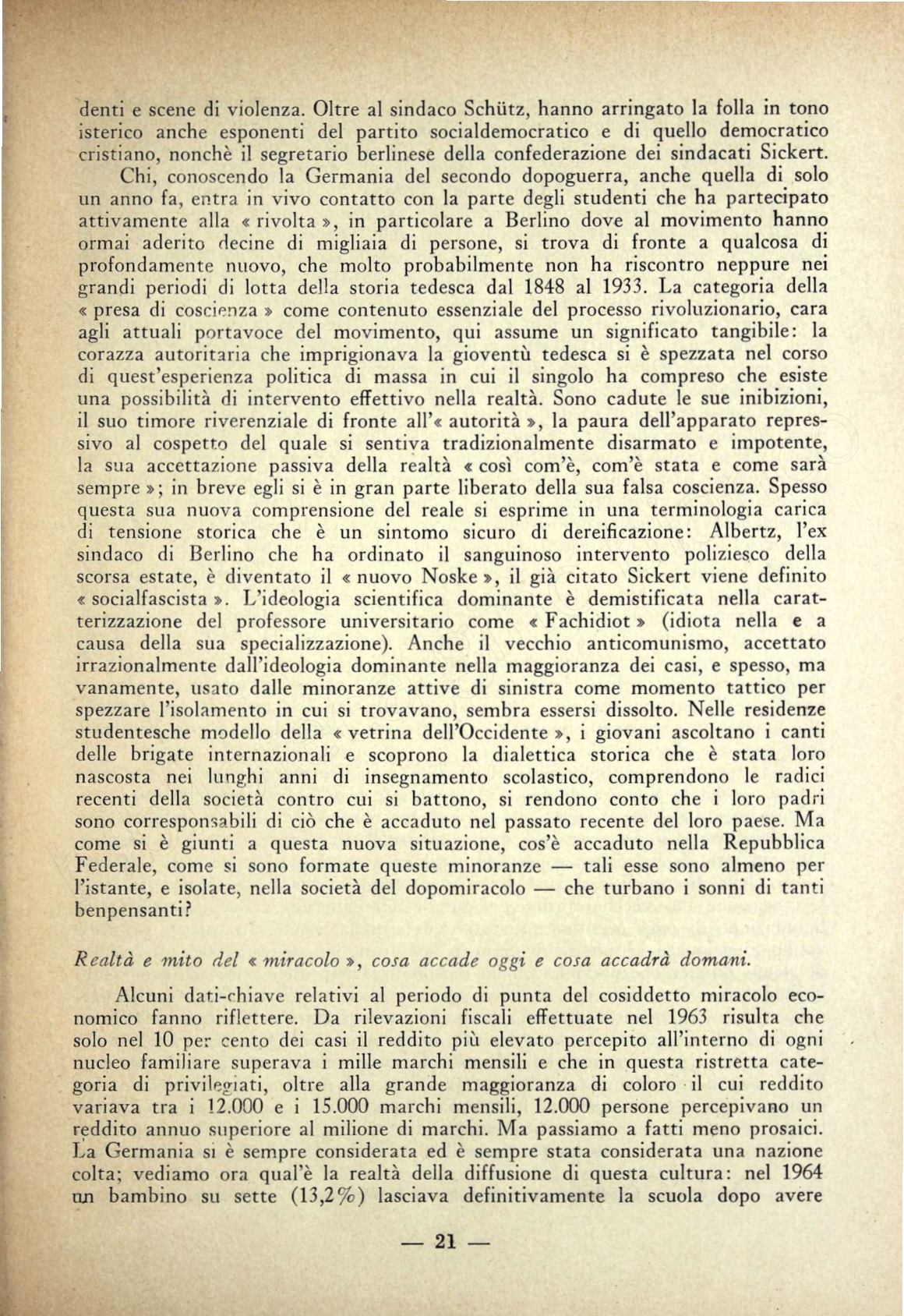
denti e scene di violenza. Oltre al sindaco Schiitz, hanno arringato la folla in tono
isterico anche esponenti del partito socialdemocratico e di quello democratico
cristiano, nonchè il segretario berlinese della confederazione dei sindacati Sickert.
Chi, conoscendo la Germania del secondo dopoguerra, anche quella di solo
un anno fa, entra in vivo contatto con la parte degli studenti che ha partecipato
attivamente alla « rivolta », in particolare a Berlino dove al movimento hanno
ormai aderito decine di migliaia di persone, si trova di fronte a qualcosa di
profondamente nuovo, che molto probabilmente non ha riscontro neppure nei
grandi periodi di lotta della storia tedesca dal 1848 al 1933. La categoria della
«presa di coscienza» come contenuto essenziale del processo rivoluzionario, cara
agli attuali portavoce del movimento, qui assume un significato tangibile: l a
corazza autoritaria che imprigionava la gioventù tedesca si è spezzata nel corso
di quest'esperienza politica di massa in cui i l singolo ha compreso che esiste
una possibilità di intervento effettivo nella realtà. Sono cadute le sue inibizioni,
il suo timore riverenziale di fronte all'« autorità », la paura dell'apparato repres-
sivo al cospetto del quale si sentiva tradizionalmente disarmato e impotente,
la sua accettazione passiva della realtà « così com'è, com'è stata e come sarà
sempre»; in breve egli si è in gran parte liberato della sua falsa coscienza. Spesso
questa sua nuova comprensione del reale si esprime in una terminologia carica
di tensione storica che è un sintomo sicuro d i dereificazione: Albertz, l 'ex
sindaco d i Berlino che ha ordinato i l sanguinoso intervento poliziesco della
scoisaestate, è diventato i l « nuovo Noske », i l già citato Sickert viene definito
«socialfascista ». L'ideologia scientifica dominante è demistificata nella carat-
terizzazione del professore universitario come « Fachidiot » (idiota nella e a
causa della sua specializzazione). Anche i l vecchio anticomunismo, accettato
irrazionalmente dall'ideologia dominante nella maggioranza dei casi, e spesso, ma
vanamente, usato dalle minoranze attive di sinistra come momento tattico per
spezzare l'isolamento in cui si trovavano, sembra essersi dissolto. Nelle residenze
studentesche modello della « vetrina dell'Occidente», i giovani ascoltano i canti
delle brigate internazionali e scoprono l a dialettica storica che è stata loro
nascosta nei lunghi anni d i insegnamento scolastico, comprendono l e radici
recenti della società contro cui si battono, si rendono conto che i loro padri
sono corresponsabili di ciò che è accaduto nel passato recente del loro paese. Ma
come si è giunti a questa nuova situazione, cos'è accaduto nella Repubblica
Federale, come si sono formate queste minoranze — tali esse sono almeno per
l'istante, e isolate, nella società del dopomiracolo c h e turbano i sonni di tanti
benpensanti?
Realtà e mito del «miracolo», cosa accade oggi e cosa accadrà domani.
Alcuni dati-chiave relativi al periodo di punta del cosiddetto miracolo eco-
nomico fanno riflettere. Da rilevazioni fiscali effettuate nel 1963 risulta che
solo nel 10 per cento dei casi i l reddito più elevato percepito all'interno di ogni
nucleo familiare superava i mille marchi mensili e che in questa ristretta cate-
goria d i privilegiati, oltre alla grande maggioranza d i coloro • il cui reddito
variava tra i 12.000 e i 15.000 marchi mensili, 12.000 persone percepivano un
reddito annuo superiore al milione di marchi. Ma passiamo a fatti meno prosaici.
La Germania si è sempre considerata ed è sempre stata considerata una nazione
colta; vediamo ora qual'è la realtà della diffusione di questa cultura: nel 1964
un bambino su sette (13,2%) lasciava definitivamente la scuola dopo avere
21