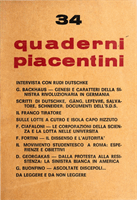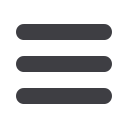
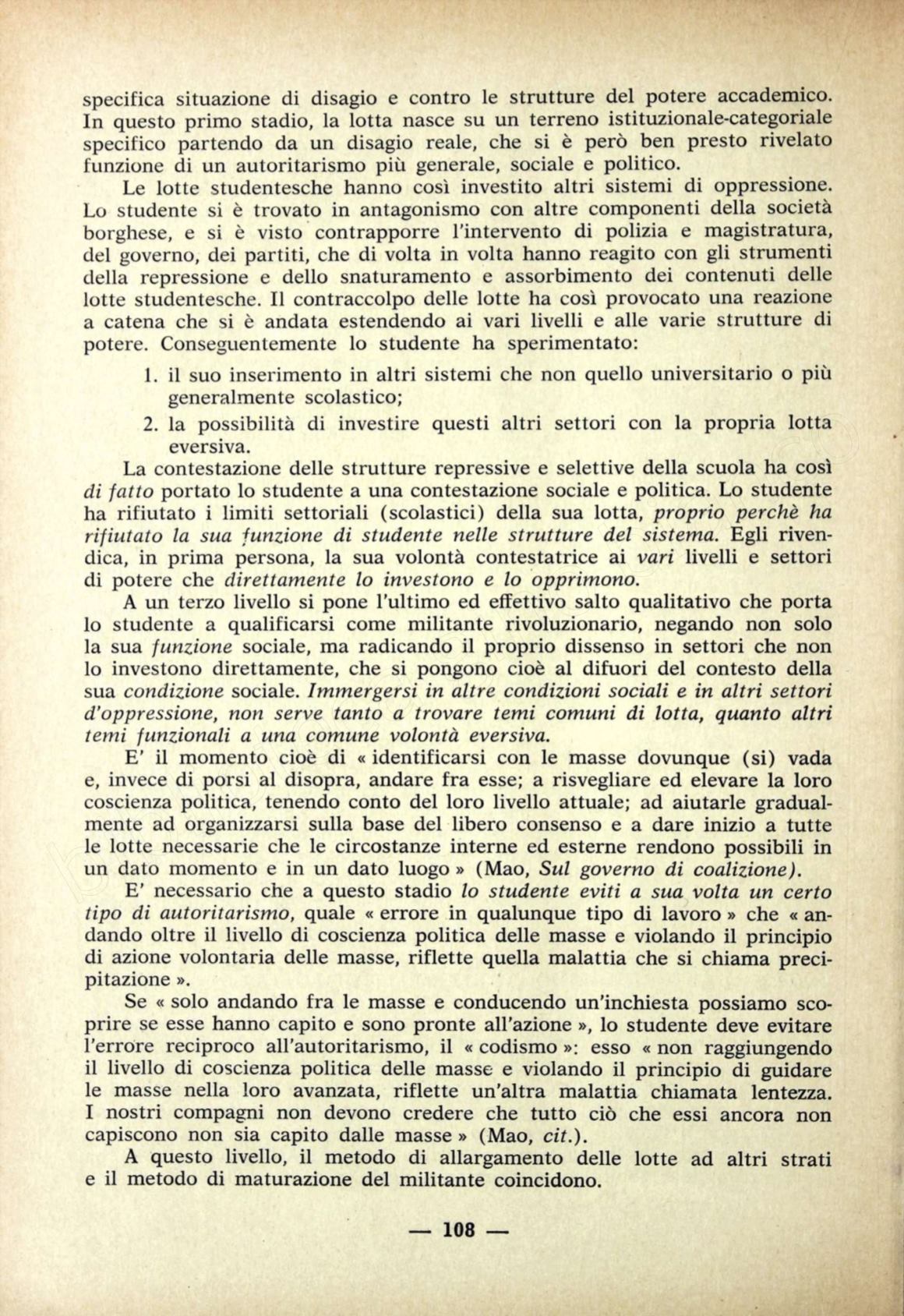
specifica situazione d i disagio e contro le st rut ture del potere accademico.
In questo pr imo stadio, la lot ta nasce su un terreno istituzionale-categoriale
specifico partendo da un disagio reale, che s i è però ben presto r ivelato
funzione d i un autoritarismo più generale, sociale e pol itico.
Le lot te studentesche hanno così investito a l t r i sistemi d i oppressione.
Lo studente si è trovato i n antagonismo con al tre componenti del la società
borghese, e s i è visto contrapporre l ' intervento d i pol izia e magistratura,
del governo, dei part i t i , che di volta in volta hanno reagito con gl i strumenti
della repressione e del lo snaturamento e assorbimento dei contenuti del le
lotte studentesche. I l contraccolpo delle lotte ha così provocato una reazione
a catena che si è andata estendendo ai var i l ivel l i e al le varie strut ture d i
potere. Conseguentemente l o studente ha sperimentato:
1. i l suo inserimento in al tr i sistemi che non quello universitario o più
generalmente scolastico;
2. la possibilità d i investire quest i a l t r i set tor i con l a propr ia l ot ta
eversiva.
La contestazione delle strutture repressive e selettive della scuola ha così
di fatto
portato lo studente a una contestazione sociale e politica. Lo studente
ha r i f iutato i l imi t i settoriali (scolastici) del la sua lotta,
propr io perchè ha
rifiutato l a sua funzione d i studente nelle strut ture del sistema. Egl i riven-
dica, i n pr ima persona, la sua volontà contestatrice a i
var i
l ivel l i e settor i
di potere che direttamente lo investono e lo opprimono.
A un terzo livello si pone l 'ul t imo ed effettivo salto qualitativo che porta
lo studente a qual ificarsi come mi l i tante rivoluzionario, negando non solo
la sua
funzione
sociale, ma radicando i l proprio dissenso i n settori che non
lo investono direttamente, che s i pongono cioè al di fuor i del contesto del la
sua condizione sociale. Immergersi in altre condizioni sociali e in al t r i settori
d'oppressione, non serve tanto a trovare temi comuni d i lotta, quanto a l t r i
temi funzionali a una comune volontà eversiva.
E' i l momento cioè d i « identificarsi con le masse dovunque ( s i ) vada
e, invece di porsi al disopra, andare fra esse; a risvegliare ed elevare la loro
coscienza politica, tenendo conto del loro livello attuale; ad aiutarle gradual-
mente ad organizzarsi sulla base del l ibero consenso e a dare inizio a tut te
le lotte necessarie che le circostanze interne ed esterne rendono possibili in
un dato momento e i n un dato luogo'> (Mao,
Sul governo d i coalizione).
E' necessario che a questo stadio lo studente evi t i a sua volta un certo
tipo d i autoritarismo,
quale « errore i n qualunque t ipo d i lavoro » che « an-
dando oltre i l l ivel lo di coscienza politica delle masse e violando i l principio
di azione volontaria delle masse, ri f lette quella malattia che si chiama preci-
pitazione ».
Se « solo andando f ra le masse e conducendo un'inchiesta possiamo sco-
prire se esse hanno capito e sono pronte all'azione », lo studente deve evitare
l'errore reciproco all'autoritarismo, i l « codismo »: esso « non raggiungendo
i l l ivel lo d i coscienza pol itica delle masse e violando i l principio d i guidare
le masse nel la l oro avanzata, r i f let te un'al t ra malat t ia chiamata lentezza.
I nost r i compagni non devono credere che t u t t o c i ò che essi ancora non
capiscono non sia capito dal le masse)> (Mao,
ci t.).
A questo l ivel lo, i l metodo d i allargamento del le lot te ad a l t r i st rat i
e i l metodo di maturazione del mi l i tante coincidono.
— 108 —