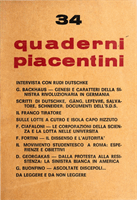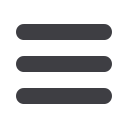
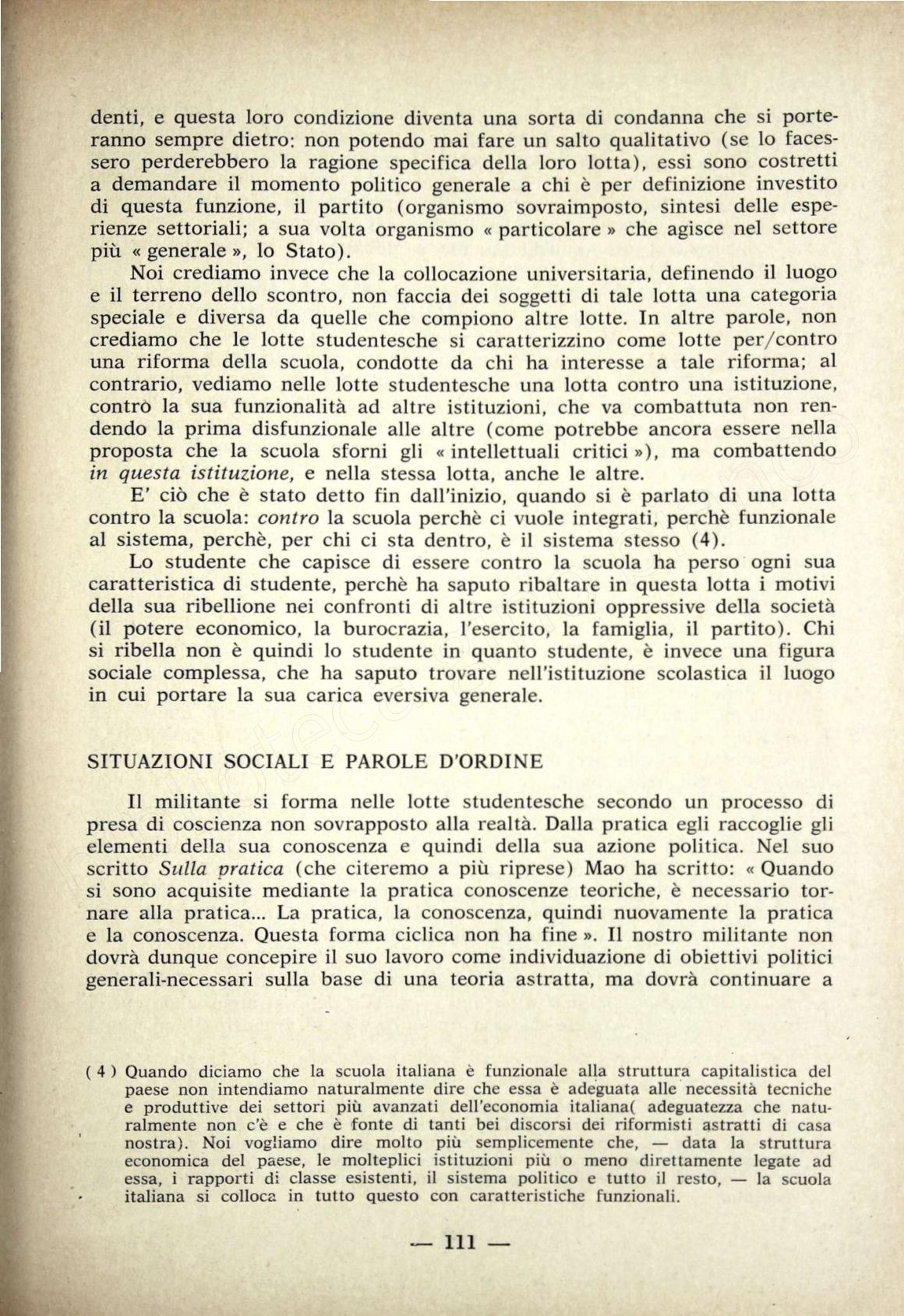
denti, e questa loro condizione diventa una sorta di condanna che si porte-
ranno sempre dietro: non potendo mai fare un salto qualitativo (se lo faces-
sero perderebbero la ragione specifica della loro lotta), essi sono costretti
a demandare i l momento politico generale a chi è per definizione investito
di questa funzione, i l partito (organismo sovraimposto, sintesi delle espe-
rienze settoriali, a sua volta organismo « particolare » che agisce nel settore
più « generale », lo Stato).
Noi crediamo invece che la collocazione universitaria, definendo i l luogo
e i l terreno dello scontro, non faccia dei soggetti di tale lotta una categoria
speciale e diversa da quelle che compiono altre lotte. I n altre parole, non
crediamo che le lotte studentesche si caratterizzino come lotte per/contro
una riforma della scuola, condotte da chi ha interesse a tale riforma; a l
contrario, vediamo nelle lotte studentesche una lotta contro una istituzione,
contro la sua funzionalità ad altre istituzioni, che va combattuta non ren-
dendo la prima disfunzionale alle altre (come potrebbe ancora essere nella
proposta che l a scuola sforni gl i « intellettuali critici »), ma combattendo
in questa istituzione,
e nella stessa lotta, anche le altre.
E' ciò che è stato detto fin dall'inizio, quando si è parlato di una lotta
contro la scuola:
contro
la scuola perché ci vuole integrati, perchè funzionale
al sistema, perché, per chi ci sta dentro, è i l sistema stesso (4) .
Lo studente che capisce di essere contro la scuola ha perso ogni sua
caratteristica di studente, perchè ha saputo ribaltare in questa lotta i motivi
della sua ribellione nei confronti di altre istituzioni oppressive della società
(il potere economico, l a burocrazia, l'esercito, l a famiglia, i l partito). Chi
si ribella non è quindi lo studente in quanto studente, è invece una figura
sociale complessa, che ha saputo trovare nell'istituzione scolastica i l luogo
in cui portare la sua carica eversiva generale.
SITUAZIONI SOCIALI E PAROLE D'ORDINE
Il militante si forma nelle lotte studentesche secondo un processo di
presa di coscienza non sovrapposto alla realtà. Dalla pratica egli raccoglie gli
elementi della sua conoscenza e quindi della sua azione politica. Nel suo
scritto
Sulla pratica
(che citeremo a più riprese) Mao ha scritto: «Quando
si sono acquisite mediante la pratica conoscenze teoriche, è necessario tor-
nare alla pratica... La pratica, la conoscenza, quindi nuovamente la pratica
e la conoscenza. Questa forma ciclica non ha fine ». I l nostro militante non
dovrà dunque concepire il suo lavoro come individuazione di obiettivi politici
generali-necessari sulla base di una teoria astratta, ma dovrà continuare a
( 4 ) Quando diciamo che l a scuola italiana è funzionale alla struttura capitalistica del
paese non intendiamo naturalmente dire che essa è adeguata alle. necessità tecniche
e produttive dei settori più avanzati dell'economia italiana( adeguatezza che natu-
ralmente non c'è e che è fonte di tanti bei discorsi dei riformisti astratti di casa
nostra). No i vogliamo di re molto più semplicemente che, — data l a struttura
economica del paese, l e molteplici istituzioni più o meno direttamente legate ad
essa, i rapporti di classe esistenti, i l sistema politico e tutto i l resto, — la scuola
• i t a l i a n a si colloca i n tutto questo con caratteristiche funzionali.