
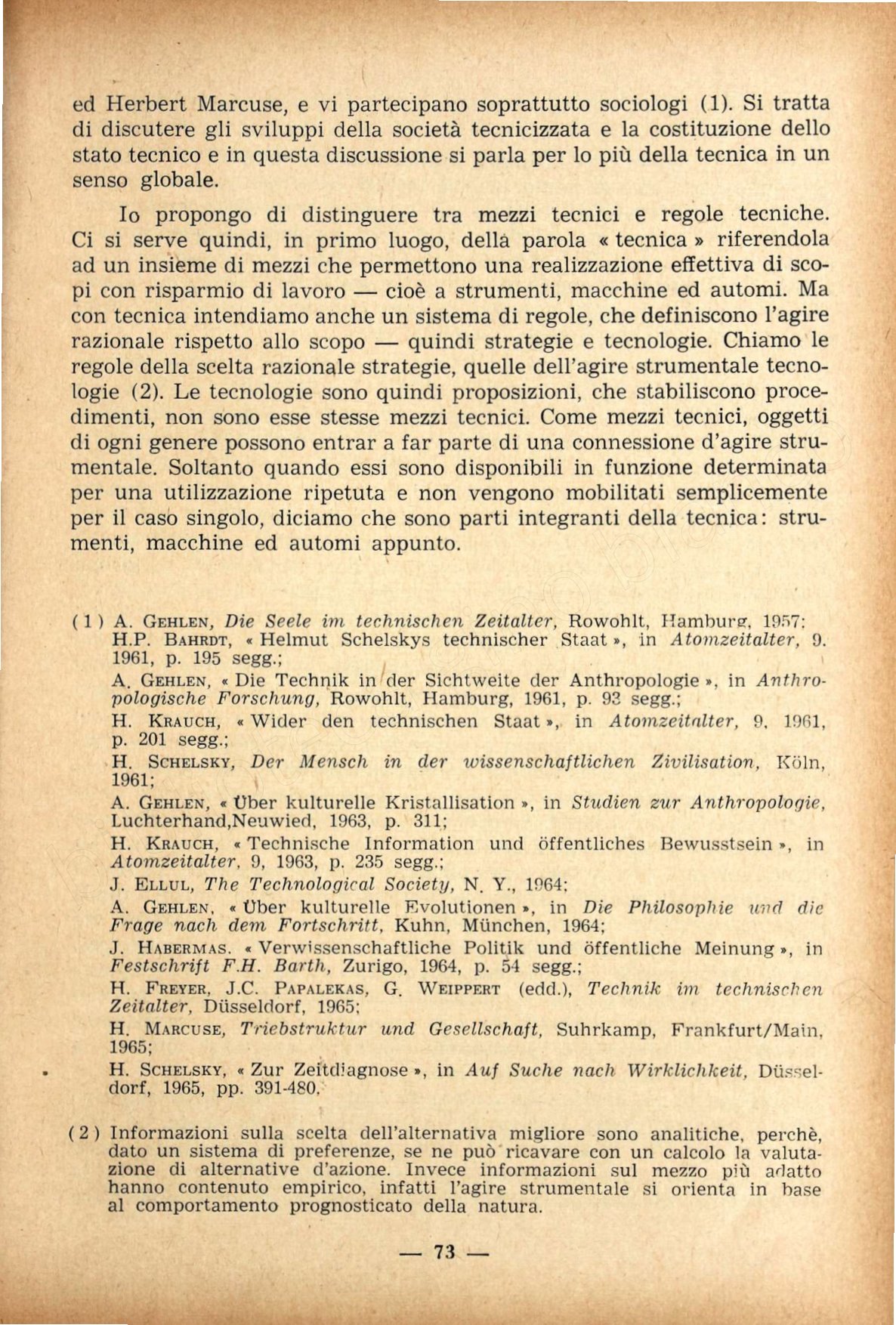
ed Herbert Marcuse, e v i partecipano soprattutto sociologi (1). Si tratta
di discutere gl i sviluppi della società tecnicizzata e la costituzione dello
stato tecnico e in questa discussione si parla per lo più della tecnica in un
senso globale.
I() propongo d i distinguere t r a mezzi tecnici e regole tecniche.
Ci si serve quindi, i n pr imo luogo, della parola « tecnica » riferendola
ad un insieme di mezzi che permettono una realizzazione effettiva di sco-
pi con risparmio di lavoro — cioè a strumenti, macchine ed automi. Ma
con tecnica intendiamo anche un sistema di regole, che definiscono l'agire
razionale rispetto allo scopo — quindi strategie e tecnologie. Chiamo le
regole della scelta razionale strategie, quelle dell'agire strumentale tecno-
logie (2). Le tecnologie sono quindi proposizioni, che stabiliscono proce-
dimenti, non sono esse stesse mezzi tecnici. Come mezzi tecnici, oggetti
di ogni genere possono entrar a far parte di una connessione d'agire stru-
mentale. Soltanto quando essi sono disponibili in funzione determinata
per una utilizzazione ripetuta e non vengono mobi l itati semplicemente
per i l caso singolo, diciamo che sono parti integranti della tecnica: stru-
menti, macchine ed automi appunto.
( 1 ) A . GEHLEN,
Di e Seele i m technischen Zei tal ter,
Rowoh l t , Hamburg, 1957:
H.P. BAHRDT, « He lmut Schelskys techni scher St aa t », i n
Atomze i ta l ter,
9 .
1961, p . 195 segg.;
A. GEHLEN, « Die Techn i k i n der Sichtwei te der Anthropologie », i n
An t hro-
pologische Forschung,
Rowoh l t , Hamburg, 1961, p. 93 segg.;
H. KRAUCH, « Wi der d e n techn i schen S t aa t », i n
At omze i t a l t e r,
9 , 1961,
p. 201 segg.;
H. SCHELSKY, D e r Mensch i n d e r wissenschaf t l ichen Z i v i l i sa t i on ,
1961;
A. GEHLEN, « -Ober ku l ture l l e Kr i stal l i sat ion », i n
Studien z u r Anthropologie,
Luchterhand,Neuwied, 1963, p . 311;
H. KRAUCH, « Technische I n f o rma t i on u n d Offent l iches Bewusstsein », i n
Atomzei tal ter,
9, 1963, p . 235 segg.;
J. ELLuL, The Technological Society, N. Y 1964:
A. GEHLEN, « Ober ku l t u r e l l e Evo l u t i onen », i n
D i e Ph i l osoph i e w i l d d i e
Frage nach dent For t schr i t t , Kuhn , München, 1964;
J. HABERMAS. « Verwissenschaft l iche Po l i t i k u n d òf fent l i che Me i nung », i n
Festschr i f t F. H . Ba r t h ,
Zur i go, 1964, p . 54 segg.;
H. FREYER, J .C. PAPALEKAS, G . WEIPPERT (edd. ) ,
Te c h n i k i n i t echn i sch en
Zei tal ter,
Düsseldorf , 1965;
H. MARCUSE,
Tr i eb s t r u k t u r u n d Gesel lschaft,
Suh r kamp , F r an k f u r t /Ma i n ,
1965;
H. SCHELSKY, « Zur Zeitdiagnose », i n
A u f Suche nach Wi r k l i chke i t ,
Düssel-
dorf, 1965, pp . 391-480.
( 2 ) I n f ormaz i on i su l l a scel ta del l 'al ternat i va mi g l i o r e sono anal i t iche, perchè,
dato un sistema d i preferenze, se ne put , r icavare con u n calcolo l a valuta-
zione d i a l t erna t i ve d'azione. I n v e c e i n f o rmaz i on i s u l mezzo p i ù ada t t o
hanno contenuto emp i r i co, i n f a t t i l ' ag i r e s t rumen t a l e s i o r i en t a i n hase
al compor tamento prognost icato del la natura.
















