
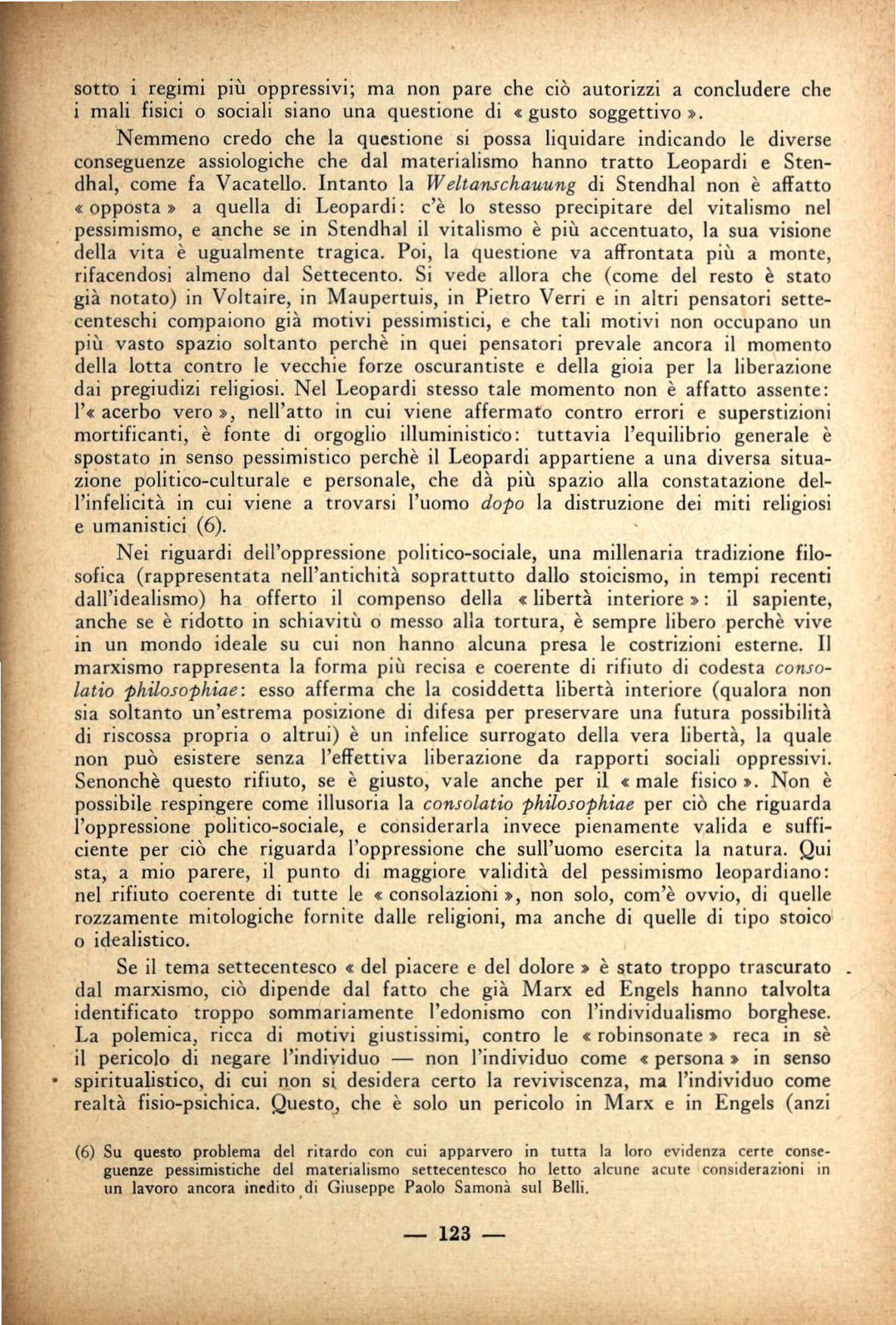
sotto i regimi più oppressivi; ma non pare che ciò autorizzi a concludere che
i mali fisici o sociali siano una questione di « gusto soggettivo ».
Nemmeno credo che la questione si possa liquidare indicando le diverse
conseguenzeassiologiche che dal materialismo hanno tratto Leopardi e Sten-
dhal, come fa Vacatello. Intanto la W
eltanschauung
di Stendhal non è affatto
«opposta» a quella d i Leopardi • c'è lo stesso precipitare del vitalismo nel
pessimismo, e anche se in Stendhal i l vitalismo è più accentuato, la sua visione
della vita è ugualmente tragica. Poi, la questione va affrontata più a monte,
rifacendosi almeno dal Settecento. Si vede allora che (come del resto è stato
già notato) in Voltaire, in Maupertuis, in Pietro Verri e in altri pensatori sette-
centeschi compaiono già motivi pessimistici, e che tali motivi non occupano un
più
vasto spazio soltanto perchè in quei pensatori prevale ancora i l momento
delta lotta contro le vecchie forze oscurantiste e della gioia per la liberazione
dai pregiudizi religiosi. Nel Leopardi stesso tale momento non è affatto assente:
l'« acerbo vero », nell'atto in cui viene affermato contro errori e superstizioni
mortificanti, è fonte di orgoglio illuministico: tuttavia l'equilibrio generale è
spostato in senso pessimistico perchè i l Leopardi appartiene a una diversa situa-
zione politico-culturale e personale, che dà più spazio alla constatazione del-
l'infelicità in cui viene a trovarsi l'uomo
dopo
la distruzione dei mi t i religiosi
eumanistici (6).
Nei riguardi dell'oppressione politico-sociale, una millenaria tradizione filo-
sofica (rappresentata nell'antichità soprattutto dallo stoicismo, in tempi recenti
dall'idealismo) ha offerto i l compenso della « libertà interiore »: i l sapiente,
anchese è ridotto in schiavitù o messo alla tortura, è sempre libero perchè vive
in un mondo ideale su cui non hanno alcuna presa le costrizioni esterne. I I
marxismo rappresenta la forma più recisa e coerente di rifiuto di codesta
conso-
latio philosophiae:
esso afferma che la cosiddetta libertà interiore (qualora non
sia soltanto un'estrema posizione di difesa per preservare una futura possibilità
di riscossa propria o altrui) è un infelice surrogato della vera libertà, la quale
non può esistere senza l'effettiva liberazione da rapporti sociali oppressivi.
Senonchè questo rifiuto, se è giusto, vale anche per i l « male fisico ». Non è
possibile respingere come illusoria la
consolatio philosophiae
per ciò che riguarda
l'oppressione politico-sociale, e considerarla invece pienamente valida e suffi-
ciente per ciò che riguarda l'oppressione che sull'uomo esercita la natura. Qui
sta, a mio parere, i l punto di maggiore validità del pessimismo leopardiano:
nel rifiuto coerente di tutte le « consolazioni », non solo, com'è ovvio, di quelle
rozzamente mitologiche fornite dalle religioni, ma anche di quelle di tipo stoico
o idealistico.
Se il tema settecentesco « del piacere e del dolore » è stato troppo trascurato
dal marxismo, ciò dipende dal fatto che già Marx ed Engels hanno talvolta
identificato troppo sommariamente l'edonismo con l'individualismo borghese.
La polemica, ricca di motivi giustissimi, contro le « robinsonate» reca in sè
il pericolo di negare l'individuo — non l'individuo come c persona» i n senso
• spiritualistico, di cui non si; desidera certo la reviviscenza, ma l'individuo come
realtà fisio-psichica. Questo, che è solo un pericolo in Marx e in Engels (anzi
(6) Su questo problema del ritardo con cui apparvero in tutta la loro evidenza certe conse-
guenzepessimistiche del materialismo settecentesco ho letto alcune acute considerazioni in
un lavoro ancora inedito ,di Giuseppe PaoloSamonà sul Belli.
123
















