
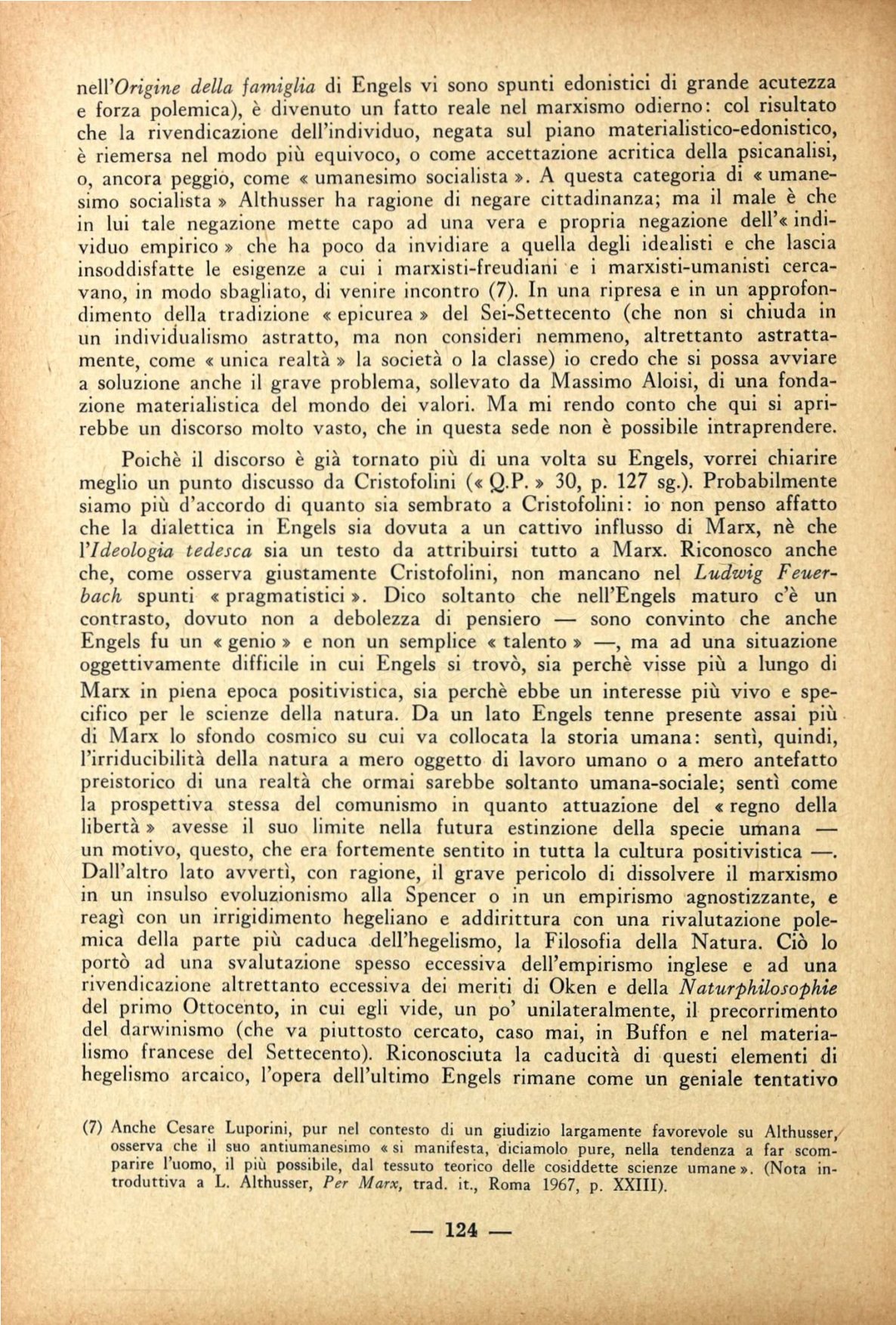
nell'Origine della famiglia
di Engels vi sono spunti edonistici di grande acutezza
eforza polemica), è divenuto un fatto reale nel marxismo odierno: col risultato
che la rivendicazione dell'individuo, negata sul piano materialistico-edonistico,
èriemersa nel modo più equivoco, o come accettazione acritica della psicanalisi,
o, ancora peggio, come « umanesimo socialista ». A questa categoria di « umane-
simo socialista »Althusser ha ragione di negare cittadinanza; ma i l male è che
in lui tale negazione mette capo ad una vera e propria negazione dell'« indi-
viduo empirico » che ha poco da invidiare a quella degli idealisti e che lascia
insoddisfatte le esigenze a cui i marxisti-freudiani e i marxisti-umanisti cerca-
vano, in modo sbagliato, di venire incontro (7). In una ripresa e in un approfon-
dimento della tradizione « epicurea » del Sei-Settecento (che non si chiuda in
un individualismo astratto, ma non consideri nemmeno, altrettanto astratta-
mente, come « unica realtà » la società o la classe) io credo che si possa avviare
asoluzione anche i l grave problema, sollevato da Massimo Aloisi, di una fonda-
zione materialistica del mondo dei valori. Ma mi rendo conto che qui si apri-
rebbe un discorso molto vasto, che in questa sede non è possibile intraprendere.
Poichè i l discorso è già tornato più di una volta su Engels, vorrei chiarire
meglio un punto discusso da Cristofolini (« Q.P. » 30, p. 127 sg.). Probabilmente
siamo più d'accordo di quanto sia sembrato a Cristofolini: io non penso affatto
che la dialettica in Engels sia dovuta a un cattivo influsso di Marx, nè che
l'Ideologia tedesca
sia un testo da attribuirsi tutto a Marx. Riconosco anche
che, come osserva giustamente Cristofolini, non mancano nel
Ludwig Feuer
-
back
spunti « pragmatistici ». Dico soltanto che nell'Engels maturo c'è un
contrasto, dovuto non a debolezza d i pensiero — sono convinto che anche
Engels fu un « genio» e non un semplice « talento » —, ma ad una situazione
oggettivamente difficile in cui Engels si trovò, sia perchè visse più a lungo di
Marx in piena epoca positivistica, sia perchè ebbe un interesse più vivo e spe-
cifico per le scienze della natura. Da un lato Engels tenne presente assai più
di Marx lo sfondo cosmico su cui va collocata la storia umana: send, quindi,
l'irriducibilità della natura a mero oggetto di lavoro umano o a mero antefatto
preistorico di una realtà che ormai sarebbe soltanto umana-sociale; sentì come
la prospettiva stessa del comunismo i n quanto attuazione del « regno della
libertà » avesse i l suo limite nella futura estinzione della specie umana
unmotivo, questo, che era fortemente sentito in tutta la cultura positivistica .
Dall'altro lato avverti, con ragione, i l grave pericolo di dissolvere i l marxismo
in un insulso evoluzionismo alla Spencer o in un empirismo agnostizzante, e
reagì con un irrigidimento hegeliano e addirittura con una rivalutazione pole-
mica della parte più caduca .dell'hegelismo, la Filosofia della Natura. Ciò lo
pone) ad una svalutazione spesso eccessiva dell'empirismo inglese e ad una
rivendicazione altrettanto eccessiva dei meriti di Oken e della
Naturphilosophie
del primo Ottocento, in cui egli vide, un po' unilateralmente, i l precorrimento
del darwinismo (che va piuttosto cercato, caso mai, in Buffon e nel materia-
lismo francese del Settecento). Riconosciuta la caducità di questi elementi di
hegelismo arcaico, l'opera dell'ultimo Engels rimane come un geniale tentativo
(7) Anche Cesare Luporini, pur nel contesto di un giudizio largamente favorevole su Althusser,,
osserva che i l suo antiumanesimo « si manifesta, diciamolo pure, nella tendenza a far scom-
parire l'uomo, i l più possibile, dal tessuto teorico delle cosiddette scienze umane ». (Nota in-
troduttiva a L. Althusser,
Per Marx,
trad. i t., Roma 1967, p. XXIII).
124
















