
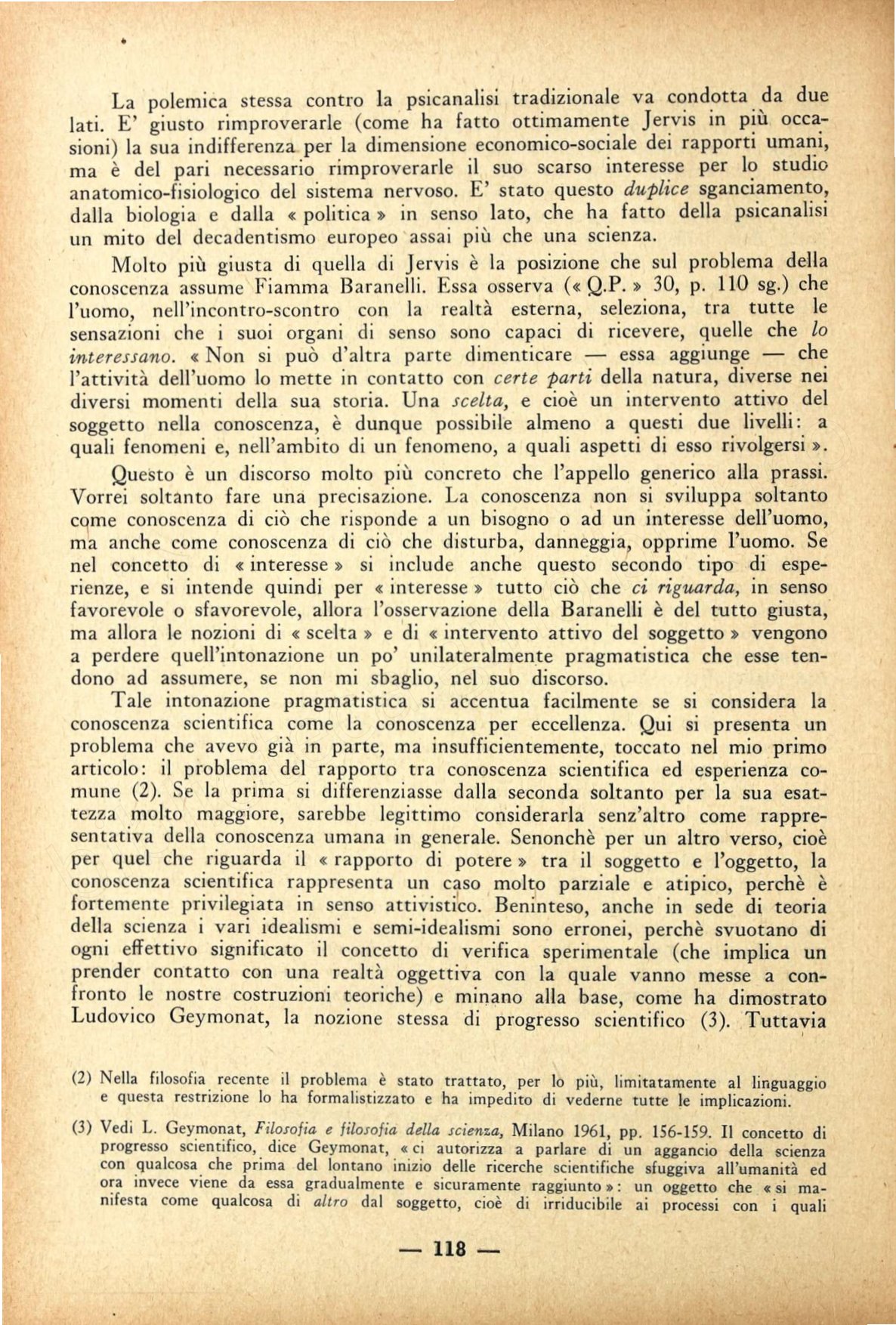
La polemica stessa contro la psicanalisi tradizionale va condotta da due
lati. E' giusto rimproverarle (come ha fatto ottimamente Jervis in più occa-
sioni) la sua indifferenza per la dimensione economico-sociale dei rapporti umani,
ma è del pari necessario rimproverarle i l suo scarso interesse per lo studio
anatomico-fisiologico del sistema nervoso. E' stato questo
duplice
sganciamento,
dalla biologia e dalla « politica » i n senso lato, che ha fatto della psicanalisi
un mito del decadentismo europeo assai più che una scienza.
Molto più giusta di quella di Jervis è la posizione che sul problema della
conoscenzaassume Fiamma Baranelli. Essa osserva (« Q.P. » 30, p. 110 sg.) che
l'uomo, nell'incontro-scontro con l a realtà esterna, seleziona, t r a tut te l e
sensazioni che i suoi organi d i senso sono capaci d i ricevere, quelle che
lo
interessano. «Non
si può d'altra parte dimenticare — essa aggiunge — che
l'attività dell'uomo lo mette in contatto con
certe parti
della natura, diverse nei
diversi momenti della sua storia. Una
scelta,
e cioè un intervento attivo del
soggetto nella conoscenza, è dunque possibile almeno a questi due livelli: a
quali fenomeni e, nell'ambito di un fenomeno, a quali aspetti di esso rivolgersi ».
Questo è un discorso molto più concreto che l'appello generico alla prassi.
Vorrei soltanto fare una precisazione. La conoscenza non si sviluppa soltanto
comeconoscenza di ciò che iisponde a un bisogno o ad un interesse dell'uomo,
maanche come conoscenza di ciò che disturba, danneggia, opprime l'uomo. Se
nel concetto d i « interesse» s i include anche questo secondo t ipo d i espe-
rienze, e si intende quindi per « interesse» tutto ciò che
ci riguarda,
in senso
favorevole o sfavorevole, allora l'osservazione della Baranelli è del tutto giusta,
ma allora le nozioni di « scelta » e di « intervento attivo del soggetto » vengono
aperdere quell'intonazione un po' unilateralmente pragmatistica che esse ten-
dono ad assumere, se non mi sbaglio, nel suo discorso.
Tale intonazione pragmatistica si accentua facilmente se si considera la
conoscenza scientifica come la conoscenza per eccellenza. Qui si presenta un
problema che avevo già in parte, ma insufficientemente, toccato nel mio primo
articolo: i l problema del rapporto tra conoscenza scientifica ed esperienza co-
mune (2). Se la prima si differenziasse dalla seconda soltanto per la sua esat-
tezza molto maggiore, sarebbe legittimo considerarla senz'altro come rappre-
sentativa della conoscenza umana in generale. Senonchè per un altro verso, cioè
per quel che riguarda i l « rapporto di potere » t ra i l soggetto e l'oggetto, la
conoscenza scientifica rappresenta un caso molto parziale e atipico, perchè è
fortemente privilegiata in senso attivistico. Beninteso, anche in sede di teoria
della scienza i vari idealismi e semi-idealismi sono erronei, perchè svuotano di
ogni effettivo significato i l concetto di verifica sperimentale (che implica un
prender contatto con una realtà oggettiva con la quale vanno messe a con-
fronto le nostre costruzioni teoriche) e minano alla base, come ha dimostrato
Ludovico Geymonat, la nozione stessa d i progresso scientifico (3). Tuttavia
(2) Nella filosofia recente i l problema è stato trattato, per lo più, limitatamente a l linguaggio
equesta restrizione lo ha formalistizzato e ha impedito di vederne tutte le implicazioni.
(3) Vedi L. Geymonat,
Filosofia
e
filosofia della scienza,
Milano 1961, pp. 156-159. I l concetto di
progresso scientifico, dice Geymonat, « ci autorizza a parlare d i un aggancio della scienza
con qualcosa che prima del lontano inizio delle ricerche scientifiche sfuggiva all'umanità ed
ora invece viene da essa gradualmente e sicuramente raggiunto »: un oggetto che « si ma-
nifesta come qualcosa d i
al tro
dal soggetto, cioè d i irriducibile a i processi con i qual i
--- 118
















