
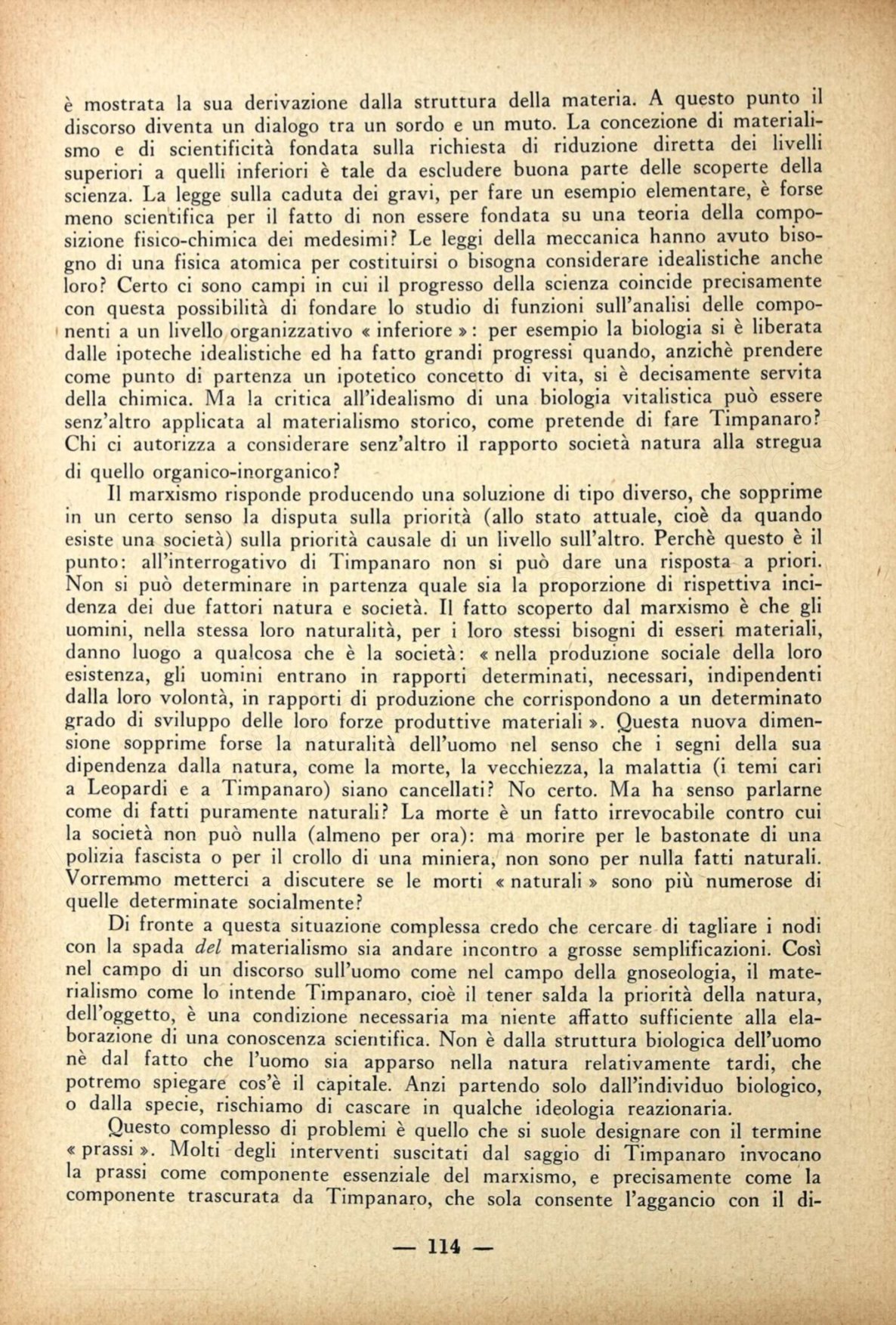
èmostrata la sua derivazione dalla struttura della materia. A questo punto i l
discorso diventa un dialogo tra un sordo e un muto. La concezione di materiali-
smo e di scientificità fondata sulla richiesta d i riduzione diretta dei livelli
superiori a quelli inferiori è tale da escludere buona parte delle scoperte della
scienza. La legge sulla caduta dei gravi, per fare un esempio elementare, è forse
meno scientifica per i l fatto di non essere fondata su una teoria della compo-
sizione fisico-chimica dei medesimi? Le leggi della meccanica hanno avuto biso-
gno di una fisica atomica per costituirsi o bisogna considerare idealistiche anche
loro? Certo ci sono campi in cui i l progresso della scienza coincide precisamente
con questa possibilità di fondare lo studio di funzioni sull'analisi delle compo-
nenti a un livello organizzativo « inferiore »: per esempio la biologia si è liberata
dalle ipoteche idealistiche ed ha fatto grandi progressi quando, anzichè prendere
come punto di partenza un ipotetico concetto di vita, si è decisamente servita
della chimica. Ma la critica all'idealismo di una biologia vitalistica può essere
senz'altro applicata al materialismo storico, come pretende di fare Timpanaro?
Chi ci autorizza a considerare senz'altro i l rapporto società natura alla stregua
di quello organico-inorganico?
Il marxismo risponde producendo una soluzione di tipo diverso, che sopprime
in un certo senso la disputa sulla priorità (allo stato attuale, cioè da quando
esiste una società) sulla priorità causale di un livello sull'altro. Perchè questo è il
punto: all'interrogativo di Timpanaro non si può dare una risposta a priori.
Non si può determinare in partenza quale sia la proporzione di rispettiva inci-
denza dei due fattori natura e società. I l fatto scoperto dal marxismo è che gli
uomini, nella stessa loro naturalità, per i loro stessi bisogni di esseri materiali,
danno luogo a qualcosa che è la società: « nella produzione sociale della loro
esistenza, gl i uomini entrano i n rapporti determinati, necessari, indipendenti
dalla loro volontà, in rapporti di produzione che corrispondono a un determinato
grado di sviluppo delle loro forze produttive materiali ». Questa nuova dimen-
sione sopprime forse la naturalità dell'uomo nel senso che i segni della sua
dipendenza dalla natura, come la morte, la vecchiezza, la malattia ( i temi cari
aLeopardi e a Timpanaro) siano cancellati? No certo. Ma ha senso parlarne
come di fatti puramente naturali? La morte è un fatto irrevocabile contro cui
la società non può nulla (almeno per ora): ma morire per le bastonate di una
polizia fascista o per i l crollo di una miniera, non sono per nulla fatti naturali.
Vorremmo metterci a discutere se le morti « naturali » sono più numerose di
quelle determinate socialmente?
Di fronte a questa situazione complessa credo che cercare di tagliare i nodi
con la spada
del
materialismo sia andare incontro a grosse semplificazioni. Così
nel campo di un discorso sull'uomo come nel campo della gnoseologia, i l mate-
rialismo come lo intende Timpanaro, cioè i l tener salda la priorità della natura,
dell'oggetto, è una condizione necessaria ma niente affatto sufficiente alla ela-
borazione di una conoscenza scientifica. Non è dalla struttura biologica dell'uomo
nè dal fatto che l'uomo sia apparso nella natura relativamente tardi che
potremo spiegare cos'è i l capitale. Anzi partendo solo dall'individuo biologico,
o dalla specie, rischiamo di cascare in qualche ideologia reazionaria.
Questocomplesso di problemi è quello che si suole designare con i l termine
«prassi ». Mol t i degli interventi suscitati dal saggio d i Timpanaro invocano
la prassi come componente essenziale del marxismo, e precisamente come la
componente trascurata da Timpanaro, che sola consente l'aggancio con i l di-
- 114 —
















