
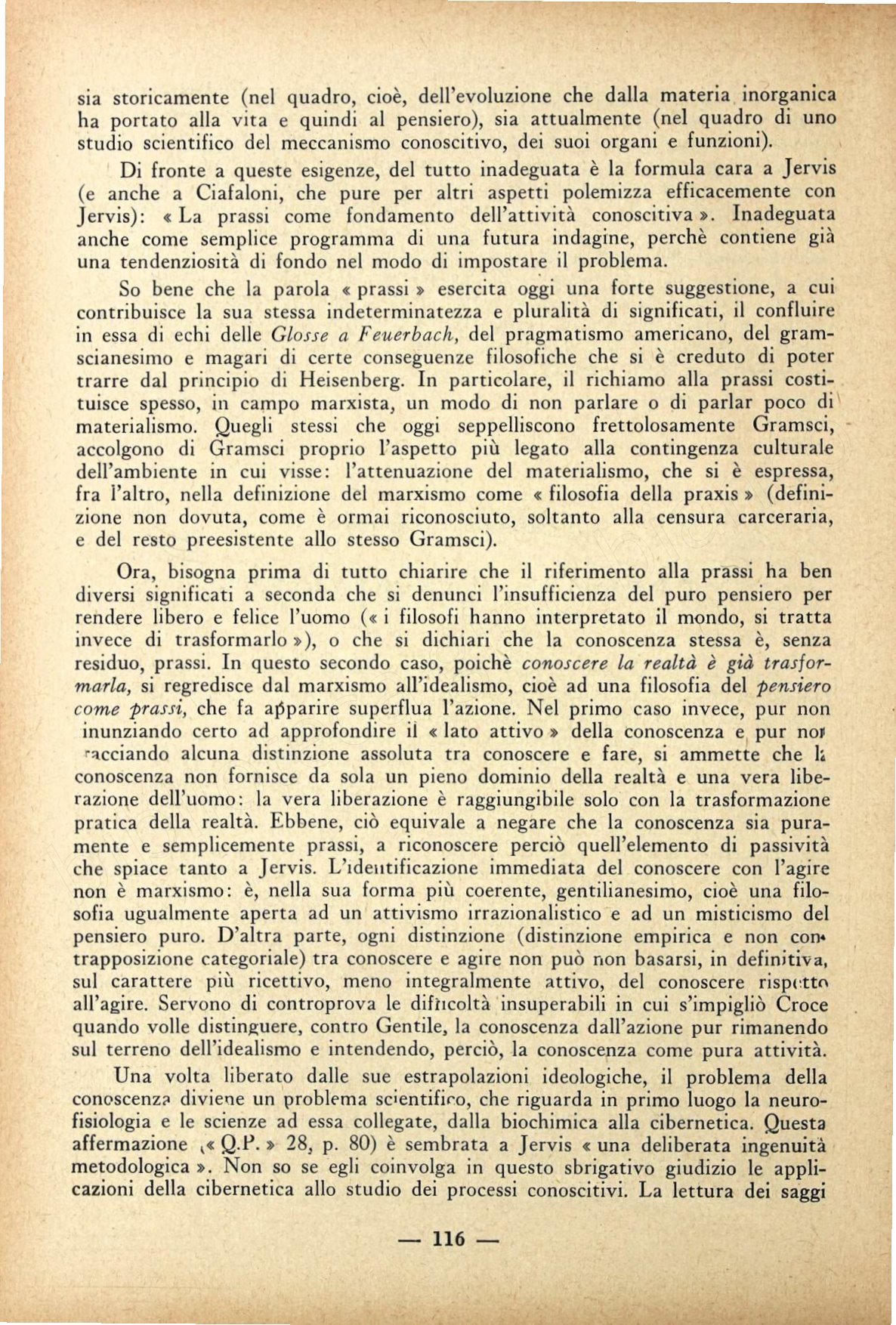
siastoricamente (nel quadro, cioè, dell'evoluzione che dalla materia inorganica
haportato alla vita e quindi al pensiero), sia attualmente (nel quadro di uno
studioscientifico delmeccanismoconoscitivo, dei suoi organi e funzioni).
Di fronte a questeesigenze, del tutto inadeguata è la formula cara a Jervis
(eanche a Ciafaloni, che pure per altri aspetti polemizza efficacemente con
Jervis): « La prassi come fondamento dell'attività conoscitiva ». Inadeguata
anchecome sempliceprogramma di una futura indagine, perche contiene già
unatendenziosità di fondo nel modo di impostare il problema.
Sobene che la parola « prassi » esercita oggi una forte suggestione, a cui
contribuisce la suastessa indeterminatezza e pluralità di significati, il confluire
inessa di echi delle
Glosse
a
Feuerbach,
del pragmatismoamericano, del gram-
scianesimo e magari di certeconseguenzefilosofiche che si è creduto di poter
trarre dal principio di Heisenberg. In particolare, il richiamo alla prassi costi-
tuiscespesso, in campomarxista, un modo di non parlare o di parlar poco di
materialismo. Quegli stessi che oggi seppelliscono frettolosamente Gramsci,
accolgono di Gramsci proprio l'aspetto più legato alla contingenza culturale
dell'ambiente in cui visse: l'attenuazione del materialismo, che si è espressa,
fra l'altro, nella definizione del marxismocome « filosofia della praxis » (defini-
zionenon dovuta, come è ormai riconosciuto, soltanto alla censura carceraria,
edel restopreesistente allo stessoGramsci).
Ora, bisogna prima di tutto chiarire che il riferimento alla prassi ha ben
diversi significati a secondache si denunci l'insufficienza del puro pensiero per
rendere libero e felice l'uomo (« i filosofi hanno interpretato il mondo, si tratta
invece di trasformarlo »), o che si dichiari che la conoscenzastessa è, senza
residuo,prassi. In questosecondocaso, poichè
conoscere la realtà
è
già trasfor-
marla,
si regredisce dal marxismoall'idealismo, cioè ad una filosofia del
pensiero
comeprassi,
che fa apparire superflua l'azione. Nel primo caso invece, pur non
inunziandocerto ad approfondire it « lato attivo » della conoscenza e pur nor
racciandoalcuna distinzione assoluta tra conoscere e fare, si ammette che1.4
conoscenzanon fornisce da sola un pieno dominio della realtà e una vera libe-
razionedell'uomo: la vera liberazione è raggiungibilesolocon la trasformazione
pratica della realtà. Ebbene, ciò equivale a negare che la conoscenza sia pura-
mente e semplicementeprassi, a riconoscere perciò quell'elemento di passività
chespiace tanto a Jervis. L'identificazione immediata del conoscerecon l'agire
nonè marxismo: è, nella sua forma più coerente, gentilianesimo, cioè una filo-
sofiaugualmente aperta ad un attivismo irrazionalistico e ad un misticismo del
pensieropuro. D'altra parte, ogni distinzione (distinzione empirica e non cone
trapposizionecategoriale) traconosceree agirenonpuònonbasarsi, in definitiva,
sul carattere più ricettivo, meno integralmente attivo, del conoscere rispetto
all'agire. Servono di controprova le difiicoltà insuperabili in cui s'impigliòCroce
quandovolle distinguere, controGentile, laconoscenzadall'azione pur rimanendo
sul terrenodell'idealismo e intendendo, perciò, la conoscenzacome pura attività.
Una volta liberato dalle sue estrapolazioni ideologiche, i l problema della
conoscenzadiviene unproblemascientifico, cheriguarda in primo luogo la neuro-
fisiologiae le scienze ad essacollegate, dalla biochimica alla cibernetica. Questa
affermazione1/4«Q.P. » 28, p. 80) è sembrata a Jervis «una deliberata ingenuità
metodologica». Non so se egli coinvolga in questo sbrigativo giudizio le appli-
cazioni della cibernetica allo studio dei processi conoscitivi. La lettura dei saggi
116
















