
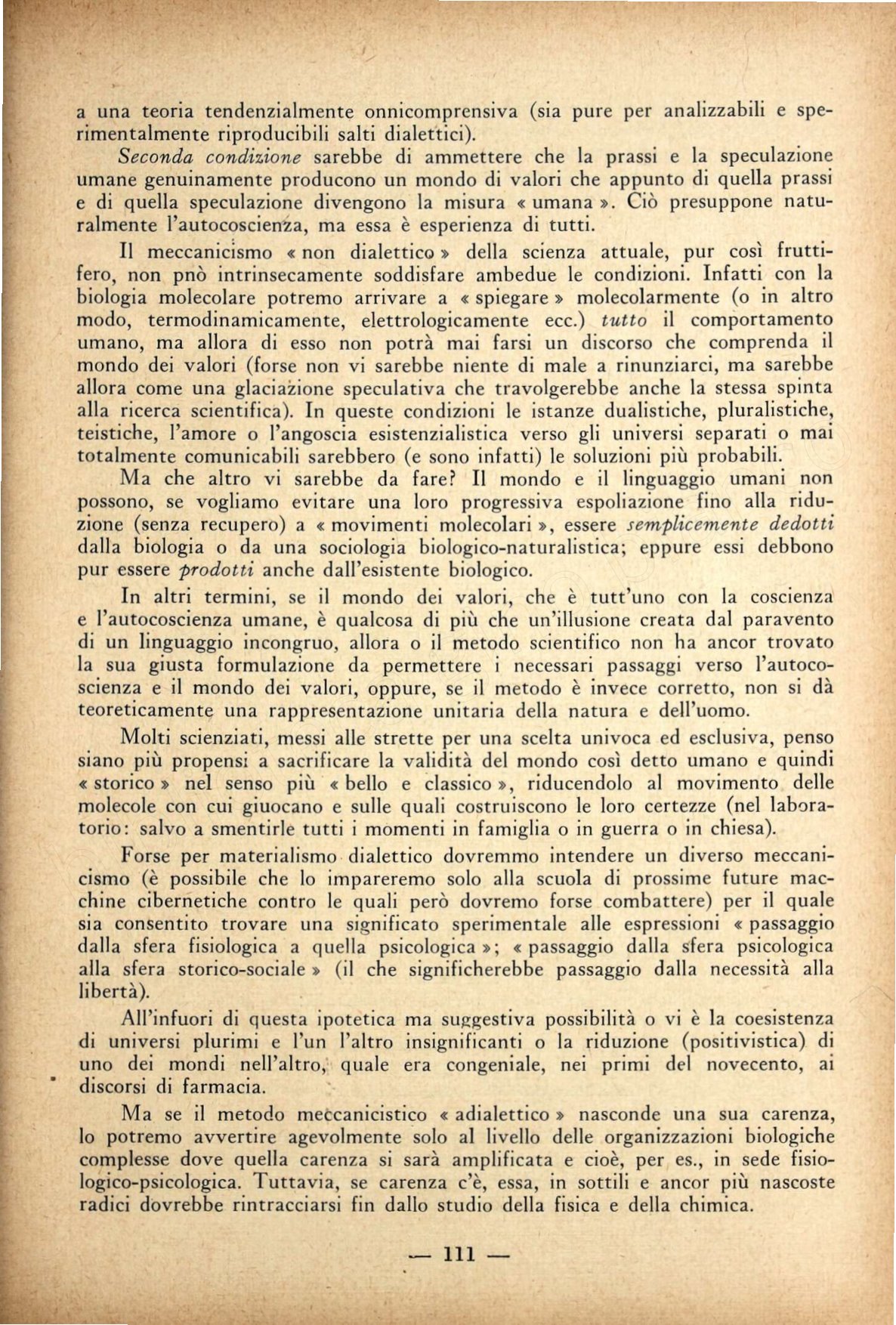
auna teoria tendenzialmente onnicomprensiva (sia pure per analizzabili e spe-
rimentalmente riproducibili salti dialettici).
Seconda condizione
sarebbe di ammettere che la prassi e la speculazione
umanegenuinamente producono un mondo di valori che appunto di quella prassi
edi quella speculazione divengono la misura « umana ». Ciò presuppone natu-
ralmente l'autocoscienia, ma essa è esperienza di tutti.
JImeccanicismo « non dialettico » della scienza attuale, pur cosi frut t i -
fero, non pnè intrinsecamente soddisfare ambedue le condizioni. Infatti con la
biologia molecolare potremo arrivare a « spiegare»molecolarmente (o in altro
modo, termodinamicamente, elettrologicamente ecc.)
tut to i l
comportamento
umano, ma allora di esso non potrà mai farsi un discorso che comprenda i l
mondo dei valori (forse non vi sarebbe niente di male a rinunziarci, ma sarebbe
allora come una glaciaiione speculativa che travolgerebbe anche la stessa spinta
alla ricerca scientifica). In queste condizioni le istanze dualistiche, pluralistiche,
teistiche, l'amore o l'angoscia esistenzialistica verso gli universi separati o mai
totalmente comunicabili sarebbero (e sono infatti) le soluzioni più probabili.
Ma che altro v i sarebbe da fare? I l mondo e i l linguaggio umani non
possono, se vogliamo evitare una loro progressiva espoliazione fino alla ridu-
zione (senza recupero) a « movimenti molecolari », essere
semplicemente dedotti
dalla biologia o da una sociologia biologico-naturalistica; eppure essi debbono
pur essere
prodotti
anche dall'esistente biologico.
In altri termini, se i l mondo dei valori, che è tutt'uno con la coscienza
el'autocoscienza umane, è qualcosa di più che un'illusione creata dal paravento
di un linguaggio incongruo, allora o i l metodo scientifico non ha ancor trovato
la sua giusta formulazione da permettere i necessari passaggi verso l'autoco-
scienza e i l mondo dei valori, oppure, se i l metodo è invece corretto, non si dà
teoreticamente una rappresentazione unitaria della natura e dell'uomo.
Molti scienziati, messi alle strette per una scelta univoca ed esclusiva, penso
siano più propensi a sacrificare la validità del mondo così detto umano e quindi
«storico » nel senso più « bello e Classico », riducendolo al movimento delle
molecole con cui giuocano e sulle quali costruiscono le loro certezze (nel labora-
torio: salvo a smentirle tutti i momenti in famiglia o in guerra o in chiesa).
Forse per materialismo dialettico dovremmo intendere un diverso meccani-
cismo (è possibile che lo impareremo solo alla scuola di prossime future mac-
chine cibernetiche contro le quali per?) dovremo forse combattere) per i l quale
sia consentito trovare una significato sperimentale alle espressioni « passaggio
dalla sfera fisiologica a quella psicologica »; « passaggio dalla sfera psicologica
alla sfera storico-sociale» ( i l che significherebbe passaggio dalla necessità alla
libertà).
All'infuori di questa ipotetica ma suggestiva possibilità o vi è la coesistenza
di universi plurimi e l'un l'altro insignificanti o la riduzione (positivistica) di
uno dei mondi nell'altro, quale era congeniale, nei primi del novecento, a i
discorsi di farmacia.
Ma se i l metodo meccanicistico « adialettico » nasconde una sua carenza,
lo potremo avvertire agevolmente solo al livello delle organizzazioni biologiche
complesse dove quella carenza si sarà amplifican e cioè, per es., in sede fisio-
logico-psicologica. Tuttavia, se carenza c'è, essa, in sottili e ancor più nascoste
radici dovrebbe rintracciarsi fin dallo studio della fisica e della chimica.
















