
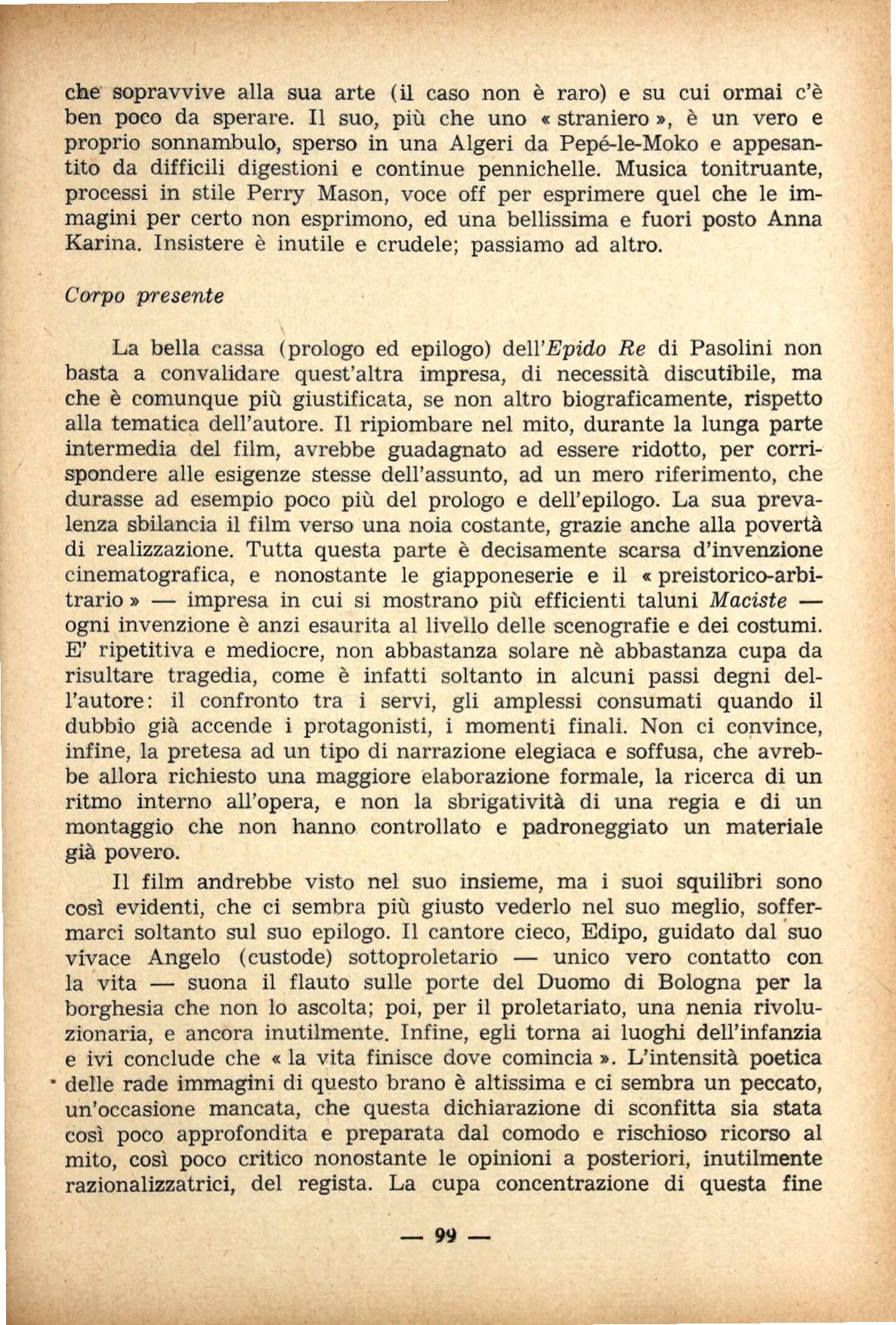
che sopravvive al la sua ar te ( i l caso non è raro) e su cu i ormai c'è
ben poco da sperare. I l suo, p i ù che uno « straniero », è u n vero e
proprio sonnambulo, sperso i n una Alger i da Pepé-le-Moko e appesan-
tito da d i f f i c i l i digest ioni e cont inue pennichelle. Musica toni truante,
processi i n st i le Per ry Mason, voce o f f per esprimere quel che l e im-
magini per certo non esprimono, ed una bellissima e fuor i posto Anna
Karina. Insistere è inut i le e crudele; passiamo ad altro.
ritmo i nterno al l 'opera, e non la sbr igat ivi tà d i una regia e d i u n
montaggio che non hanno control lato e padroneggiato un mater iale
già povero.
I l f i l m andrebbe visto ne l suo insieme, ma i suoi squi l ibr i sono
Corpo presente
La bel la cassa (prologo ed epilogo) del l 'Epido
Re
d i Pasol ini non
basta a conval idare quest 'al tra impresa, d i necessità discut ibi le, ma
che è comunque più giustificata, se non al t ro biograficamente, rispetto
alla tematica dell'autore. I l ripiombare nel mito, durante la lunga parte
intermedia de l f i lm, avrebbe guadagnato ad essere r idot to, pe r corr i -
spondere al le esigenze stesse dell'assunto, ad un mero riferimento, che
durasse ad esempio poco p i ù del prologo e dell'epilogo. L a sua preva-
lenza sbilancia i l f i lm verso una noia costante, grazie anche alla povertà
di realizzazione. Tu t t a questa parte è decisamente scarsa d' invenzione
cinematografica, e nonostante l e giapponeserie e i l « preistorico-arbi-
trario » — impresa i n cui s i mostrano più eff icient i ta l un i
Maciste
ogni invenzione è anzi esaurita al l ivel lo delle scenografie e dei costumi.
E' r ipet i t iva e mediocre, non abbastanza solare nè abbastanza cupa da
risultare tragedia, come è i n f a t t i sol tanto i n al cuni passi degni del -
l'autore c o n f r o n t o t r a i servi , g l i amplessi consumat i quando i l
dubbio già accende i protagonisti, i moment i f inal i . No n c i convince,
infine, la pretesa ad un t ipo di narrazione elegiaca e soffusa, che avreb-
be al lora richiesto una maggiore elaborazione formale, l a ricerca d i un
così evidenti, che c i sembra p i ù giusto vederlo nel suo meglio, soffer-
marci soltanto sul suo epilogo. I l cantore cieco, Edipo, guidato dal suo
vivace Ange l o (custode) sottoproletario — un i co ve r o contat to con
la v i t a — suona i l f lauto su l l e por te de l Duomo d i Bologna pe r l a
borghesia che non lo ascolta; poi , per i l proletariato, una nenia r ivolu-
zionaria, e ancora inuti lmente. Inf ine, egl i torna a i luoghi dell ' infanzia
e i v i conclude che « la vi ta finisce dove comincia ». L' intensi tà poetica
delle rade immagini di questo brano è altissima e ci sembra un peccato,
un'occasione mancata, che questa dichiarazione d i sconf i tta s i a stata
così poco approfondita e preparata da l comodo e rischioso ricorso a l
mito, cosi poco cr i t ico nonostante le opinioni a posteriori, inut i lmente
razionalizzatrici, de l regista. L a cupa concentrazione d i questa f i ne
- 99
















