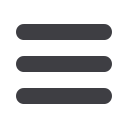
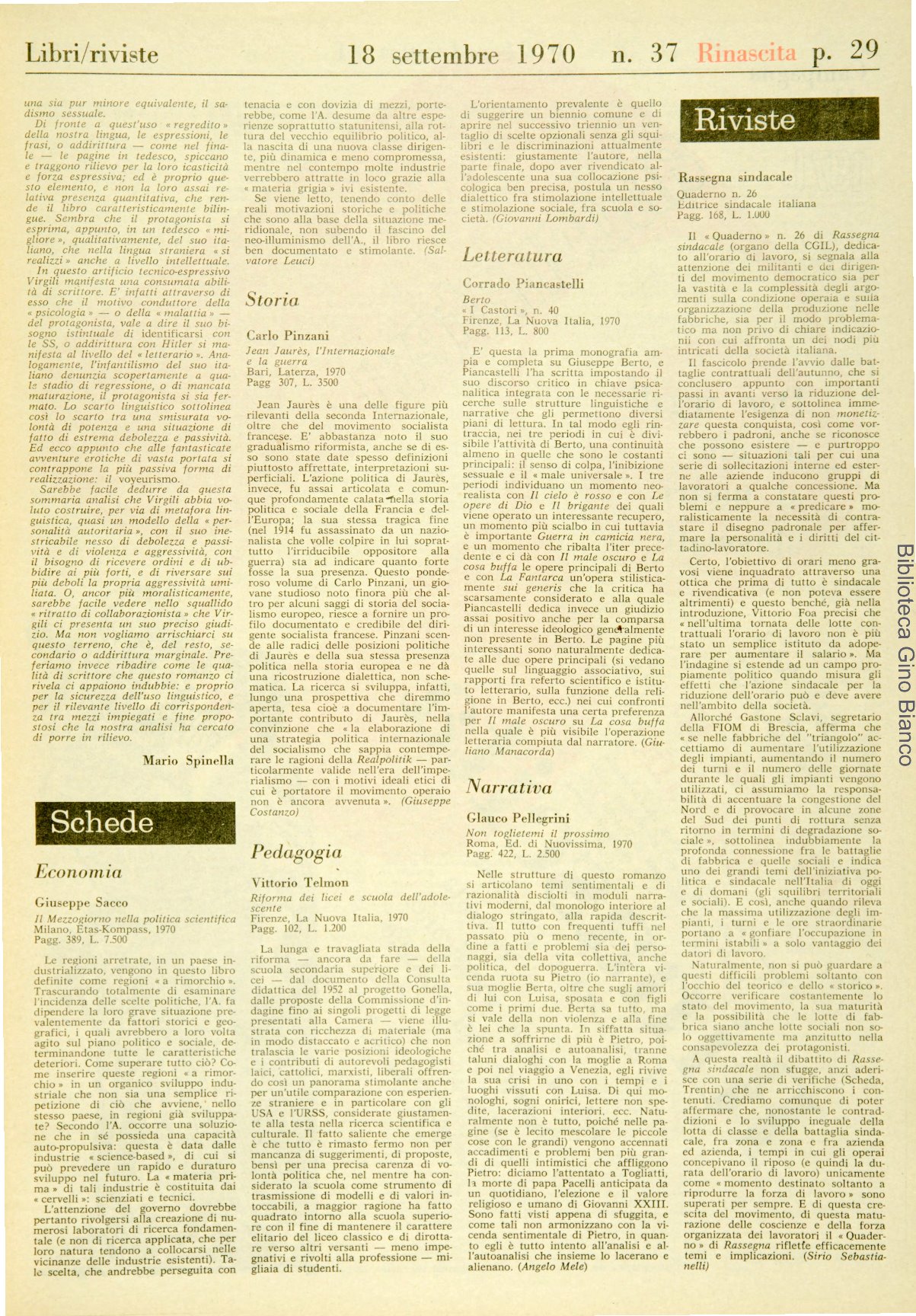
unasiapurminoreequivalente,ilsa-
dismo sessuale.
Difronteaquest'uso«regredito»
delanostralingua,leespressioni,le
frasi,oaddiritura—comenelfina-
le—lepagineintedesco,spiccano
e traggonorilievoperlaloroicasticità
e forzaespressiva;edèproprioque-
stoelemento,enonlaloroassaire-
lativapresenzaquantitativa,cheren-
deil librocarateristicamentebilin-
gue.Sembracheilprotagonistasi
esprima,appunto,inun tedesco«mi-
gliore»,qualitativamente,delsuoita-
liano,chenelalinguastraniera«si
realizzi»anchealivelointeletuale.
Inquestoartificiotecnico-espressivo
Virgilimanifestaunaconsumataabili-
tàdiscrittore.E'infattiatraversodi
esso cheilmotivocondutoredella
« psicologia»—odella«malatia»—
delprotagonista,valeadireilsuobi-
sogno istintualediidentificarsicon
leSS,oaddirituraconHitlersima-
nifestaallivellodel«letterario».Ana-
logamente, l'infantilismodelsuoita-
lianodenunziascopertamenteaqua-
lestadiodiregressione,odimancata
maturazione,ilprotagonistasisiafer-
mato.Loscarto linguisticosottolinea
cosìloscartotraunasmisuratavo-
lontàdipotenzaeunasituazionedi
fatodiestremadebolezzaepassività.
Ed eccoappuntochealefantasticate
avventureerotichedivastaportatasi
contrapponelapiùpassiva formadi
realizzazione:ilvoyeurismo.
Sarebbe facilededuredaquesta
sommariaanalisicheVirgiliabbiavo-
lutocostruire,perviadimetaforalin-
guistica,quasiunmodelodela«per-
sonalitàautoritaria»,conilsuoine-
stricabilenessodidebolezaepassi-
vitàediviolenzaeaggressività,con
ilbisognodiricevereordiniediub-
bidireaipiùforti,ediriversaresui
piùdebolilapropriaaggressivitàumi-
liata.O,ancorpiùmoralisticamente,
sarebbe facilevederenelosqualido
« ritratodicolaborazionista»cheVir-
gilicipresentaunsuoprecisogiudi-
zio.Manonvogliamoarischiarcisu
questo terreno,cheè,delresto,se-
condariooaddirituramarginale.Pre-
feriamo inveceribadirecomelequa-
litàdiscritorechequesto romanzoci
rivelaciappaiono indubbie:eproprio
perlasicurezzadel'uso linguistico,e
perilrilevantelivelodicorisponden-
za tramezzi impiegatiefinepropo-
stosichelanostraanalisihacercato
diporreinrilievo.
MarioSpinela
Schede
Economia
GiuseppeSacco
11Mezzogiornonelapoliticascientifica
Milano,Etas-Kompass,1970
Pag.389,L.7.500
Le regioniarretrate,inunpaese in-
dustrializzato,vengono inquesto libro
definitecome regioni«arimorchio».
Trascurando totalmentediesa
minarel'incidenzadelesceltepolitiche,l
'A.fadipendere lalorogravesituazion
epre-valentementedafattoristoriciegeo-
grafici,iqualiavrebberoalorovolta
agitosulpianopoliticoesociale,de-
terminandonetuttelecaratteristiche
deteriori.Come superaretutociò?Co-
me inserirequesteregioni«arimor-
chio»inunorganicosviluppo indu-
strialechenonsiaunasempliceri-
petizionediciòcheavviene,'nelo
stessopaese,inregionigiàsviluppa-
te?Secondo l'A.occoreunasoluzio-
necheinsépossiedaunacapacità
auto-propulsiva:questaèdatadalle
industrie«science-based»,dicuisi
puòprevedereunrapidoeduraturo
svilupponelfuturo.La«materiapri-
ma »ditaliindustrieècostituitadai
« cerveli»:scienziatietecnici.
L'atenzionedelgovernodovrebbe
pertantorivolgersialacreazionedinu-
merosi laboratoridiricerca fondamen-
tale(enondiricercaapplicata,cheper
loronatura tendonoacolocarsinele
vicinanzedeleindustrieesistenti).Ta-
lescelta,cheandrebbeperseguitacon
tenaciaecondoviziadimezzi,porte-
rebbe,come l'A.desumedaaltreespe-
rienzesoprattutostatunitensi,alarot-
turadelvecchioequilibriopolitico,al-
lanascitadiunanuovaclassedirigen-
te,piùdinamicaemeno compromesa,
mentrenelcontempomolte industrie
verrebberoatratteinlocograziealla
«materiagrigia»iviesistente.
Se vieneletto,tenendocontodele
realimotivazionistoricheepolitiche
che sonoalabasedelasituazioneme-
ridionale,nonsubendoilfascinodel
neo-iluminismodel'A.,illibroriesce
ben documentatoestimolante.
(Sal-
vatoreLeuci)
Storia
CarloPinzani
JeanJaurès, l'Internazionale
e laguera
Bari,Laterza,1970
Pag307,L.3500
JeanJaurèsèunadelefigurepiù
rilevantidelaseconda Internazionale,
oltrechedelmovimentosocialista
francese.E'abbastanzanotoilsuo
gradualismo riformista,anchesedies-
so sonostatedatespessodefinizioni
piutostoaffretate,interpretazionisu-
perficiali.L'azionepoliticadiJaurès,
invece,fuassaiarticolataecomun-
que profondamentecalata-rielastoria
politicaesocialedellaFranciaedel-
l'Europa;lasuastessatragicafine
(nel1914fuassassinatodaunnazio-
nalistachevollecolpireinluisoprat-
tutol'irriducibileoppositorealla
guera)staadindicarequantoforte
fose lasuapresenza.Questoponde-
rosovolumediCarloPinzani,ungio-
vane studiosonotofinorapiùcheal-
troperalcunisaggidistoriadelsocia-
lismoeuropeo, riesceafornireunpro-
filodocumentatoecredibiledeldiri-
gentesocialista francese.Pinzaniscen-
dealeradicideleposizionipolitiche
diJaurèsedellasuastessapresenza
politicanelastoriaeuropeaenedà
una ricostruzionedialetica,nonsche-
matica.Laricercasisviluppa,infatti,
lungounaprospetivachediremmo
aperta, tesacioè-adocumentare l'im-
portantecontributodiJaurès,nela
convinzioneche«laelaborazionedi
unastrategiapoliticainternazionale
delsocialismochesappiacontempe-
rareleragionidela
Realpolitik
—par-
ticolarmentevalidenel'eradel'impe-
rialismo—conimotiviidealieticidi
cuièportatoreilmovimentooperaio
nonèancoraavvenuta».
(Giuseppe
Costanzo)
Pedagogia
VittorioTelmon
Riformadeiliceiescuoladel'adole-
scente
Firenze,LaNuovaItalia,1970
Pag.102,L.1.200
La lungaetravagliatastradadella
riforma—ancoradafare—della
scuolasecondariasupereedeili-
cei—daldocumentodelaConsulta
didaticadel1952alprogettoGonela,
dalepropostedelaCommissioned'in-
dagine finoaisingoliprogetidilegge
presentatialaCamera—vieneillu-
stratacon ricchezzadimateriale(ma
inmododistaccatoeacritico)chenon
tralascialevarieposizioni ideologiche
e icontributidiautorevolipedagogisti
laici,'catolici,marxisti,liberalioffren-
do cosìunpanoramastimolanteanche
perun'utilecomparazioneconesperien-
zestraniereeinparticolarecongli
USA el'URSS,considerategiustamen-
teallatestanelaricercascientificae
culturale.Ilfattosalientecheemerge
è chetuttoèrimasto fermononper
mancanzadisuggerimenti,diproposte,
bensìperunaprecisacarenzadivo-
lontàpoliticache,nelmentrehacon-
sideratolascuolacomestrumentodi
trasmissionedimodeliedivaloriin-
toccabili,amaggior ragionehafatto
quadrato intornoallascuolasuperio-
reconilfinedimantenereilcarattere
elitariodelliceoclassicoedidirotta-
reversoaltriversanti—meno impe-
gnativierivoltialaprofessione—mi-
gliaiadistudenti.
L'orientamentoprevalenteèquelo
disuggerireunbienniocomuneedi
aprirenelsuccessivo trienniounven-
tagliodiscelteopzionalisenzaglisqui-
librielediscriminazioniattualmente
esistenti:giustamentel'autore,nela
partefinale,dopoaverrivendicatoal-
l'adolescenteunasuacolocazionepsi-
cologicabenprecisa,postulaunnesso
dialeticofrastimolazione intelletuale
e stimolazionesociale,frascuolaeso-
cietà. (GiovanniLombardi)
Leteratura
CorradoPiancasteli
Berto
« ICastori»,n.40
Firenze,LaNuovaItalia,1970
Pag.113,L.800
E'questalaprimamonografiaam-
piaecompletasuGiuseppeBerto,e
Piancastelil'hascritta impostandoil
suodiscorsocriticoinchiavepsica-
nalitica integrataconlenecessarieri-
cerchesulestruturelinguistichee
narrativecheglipermettonodiversi
pianidilettura.Intalmodoeglirin-
traccia,neitreperiodiincuièdivi-
sibilel'ativitàdiBerto,unacontinuità
almeno inquelechesonolecostanti
principali:ilsensodicolpa, l'inibizione
sessualeeil«maleuniversale».I tre
periodi individuanounmomentoneo-
realistaconIl
cielo
è
rosso
econ
Le
operediDioe Ilbrigantedeiquali
vieneoperatoun interessante recupero,
unmomentopiùscialbo incuituttavia
è importanteGuerraincamicianera,
eunmomentocheribaltal'iterprece-
denteecidàcon11maleoscuroeLa
cosabufa
leopereprincipalidiBerto
e con
LaFantarca
un'operastilistica-
mente
suigeneris
chelacriticaha
scarsamenteconsideratoealaquale
Piancastellidedica inveceungiudizio
assaipositivoancheperlacomparsa
diun interesse ideologicogendhlmente
nonpresenteinBerto.Lepaginepiù
interessantisononaturalmentededica-
tealedueopereprincipali(sivedano
quelesullinguaggioassociativo,sui
rapportifrarefertoscientificoe istitu-
to leterario,sulafunzionedellareli-
gione inBerto,ecc.)neicuiconfronti
l'autoremanifestaunacertapreferenza
perIlmaleoscurosuLacosabufa
nelaqualeèpiùvisibile l'operazione
leterariacompiutadalnarratore.
(Giu-
lianoManacorda)
Narativa
GlaucoPelegrini
Non toglietemiilprossimo
Roma,Ed.diNuovissima,1970
Pag.422,L.2.500
Nelestruturediquesto romanzo
siarticolanotemisentimentaliedi
razionalitàdiscioltiinmodulinarra-
tivimoderni,dalmonologo interioreal
dialogostringato,allarapidadescrit-
tiva.Iltuttoconfrequentituffinel
pasatopiùomenorecente,inor-
dineafattieproblemisiadeiperso-
naggi,siadellavitacoletiva,anche
politica,deldopoguerra.L'intèravi-
cenda ruotasuPietro(ionarante),e
suamoglieBerta,oltrechesugliamori
diluiconLuisa,sposataeconfigli
come iprimidue.Bertasatutto,ma
sivaledelanonviolenzaeallafine
è leichelaspunta.Insiffatasitua-
zioneasofrirnedipiùèPietro,poi-
ché traanalisieautoanalisi,tranne
talunidialoghiconlamoglieaRoma
epoinelviaggioaVenezia,eglirivive
lasuacrisiinunoconitempie i
luoghivissuticonLuisa.Diquimo-
nologhi,sognionirici,letterenonspe-
dite, lacerazioniinteriori.ecc.Natu-
ralmentenonètuto,poichénelepa-
gine (seèlecitomescolarelepiccole
cose conlegrandi)vengonoaccennati
accadimentieproblemibenpiùgran-
didiqueliintimisticicheafliggono
Pietro:diciamo l'attentatoaTogliatti,
lamortedipapaPacelianticipatada
unquotidiano, l'elezionee ilvalore
religiosoeumanodiGiovanniXXIII.
Sono fattivistiappenadisfuggita,e
come talinonarmonizzanoconlavi-
cenda sentimentalediPietro,inquan-
toegliètutointentoal'analisieal-
l'autoanalisiche insiemelolaceranoe
alienano. (AngeloMele)
Riviste
Rasegna sindacale
Quadernon.26 Editricesindacale italiana
Pag.168,L.1.000
Il«Quaderno»n.26di
Rassegna
sindacale
(organodellaCGIL),dedica-
toal'orariodilavoro,sisegnalaalla
atenzionedeimilitantiedeidirigen-
tidelmovimentodemocraticosiaper
lavastitàelacomplessitàdegliargo-
mentisullacondizioneoperaiaesulla
organizazionedellaproduzionenelle
fabbriche,siaperilmodoproblema-
ticomanonprivodichiare indicazio-
niiconcuiaffrontaundeinodipiù
intricatidellasocietàitaliana.
Ilfascicoloprende l'avviodalebat-
tagliecontrattualidell'autunno,chesi
concluseroappuntoconimportanti
pasi inavantiversolariduzionedel-
l'orariodilavoro,esotolinea imme-
diatamente l'esigenzadinon
monetiz-
zare
questaconquista,cosìcomevor-
rebberoipadroni,anchesericonosce
che possonoesistere—epurtroppo
cisono—situazionitalipercuiuna
seriedisolecitazioni interneedester-
nealleaziende induconogruppidi
lavoratoriaqualcheconcessione.Ma
nonsifermaaconstatarequestipro-
blemieneppurea«predicare»mo-
ralisticamentelanecessitàdicontra-
stareildisegnopadronaleperaffer-
mare lapersonalitàeidirittidelcit-
tadino-lavoratore.
Certo, l'obietivodiorarimenogra-
vosiviene inquadratoatraversounaCr
oticacheprimaditutoèsindacale
e rivendicativa(enonpotevaessere
altrimenti)equestobenché,giànella
introduzione,VitorioFoaprecisiche
« nel'ultimatornatadelelottecon-
trattualil'orariodilavorononèpiù
statounsempliceistitutodaadope-
rareperaumentareilsalario».Ma
l'indaginesiestendeaduncampopro-
piamentepoliticoquandomisuragli
efettichel'azionesindacaleperla
riduzionedel'orariopuòedeveavere
nel'ambitodelasocietà.
AlorchéGastoneSciavi,segretario
delaFIOMdiBrescia,afermache
« senelefabbrichedel"triangolo"ac-
cetiamodiaumentare l'utilizzazione
degli impianti,aumentandoilnumero
deiturnieilnumerodelegiornate
durante lequaligliimpiantivengono
utilizzati,ciassumiamolaresponsa-
bilitàdiaccentuarelacongestionedel
Nordediprovocareinalcunezone
delSuddeipuntidiroturasenza
ritornointerminididegradazioneso-
ciale»,sottolinea indubbiamentela
profondaconnessionefralebataglie
di fabbricaequellesocialieindica
unodeigranditemidel'iniziativapo-
liticaesindacalenell'Italiadioggi
edidomani(glisquilibriterritoriali
esociali).Ecosì,anchequandorileva
che lamassimautilizzazionedegliim-
pianti,iturnieleorestraordinarie
portanoa«gonfiare l'occupazionein
terminiistabili»asolovantaggiodei
datoridilavoro.
Naturalmente,nonsipuòguardarea
questidifficiliproblemisoltantocon
l'occhiodelteoricoedelo«storico».
Occorreverificarecostantementelo
statodelmovimento,lasuamaturità
e lapossibilitàchelelottedifab-
bricasianoanche lottesocialinonso-
looggettivamentemaanzitutonela
consapevolezadeiprotagonisti.
A questarealtàildibatitodi
Rasse-
gna sindacale
nonsfugge,anziaderi-
sce conunaseriediverifiche (Scheda,
Trentin)chenearicchisconoicon-
tenuti.Crediamocomunquedipoter
afermareche,nonostantelecontrad-
dizionielosviluppo inegualedela
lotadiclasseedelabattagliasinda-
cale,frazonaezonaefraazienda
ed azienda,itempiincuiglioperai
concepivanoilriposo(equindiladu-
ratadel'orariodilavoro)unicamente
come«momentodestinatosoltantoa
riprodurelaforzadilavoro»sono
superatipersempre.Ediquestacre-
scitadelmovimento,diquestamatu-
razionedelecoscienzeedellaforza
organizzatadeilavoratoriil«Quader-
no »di
Rassegna
rifleteefficacemente
temieimplicazioni.
(SinoSebastia-
neli)














