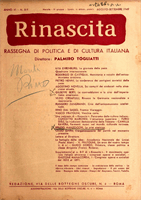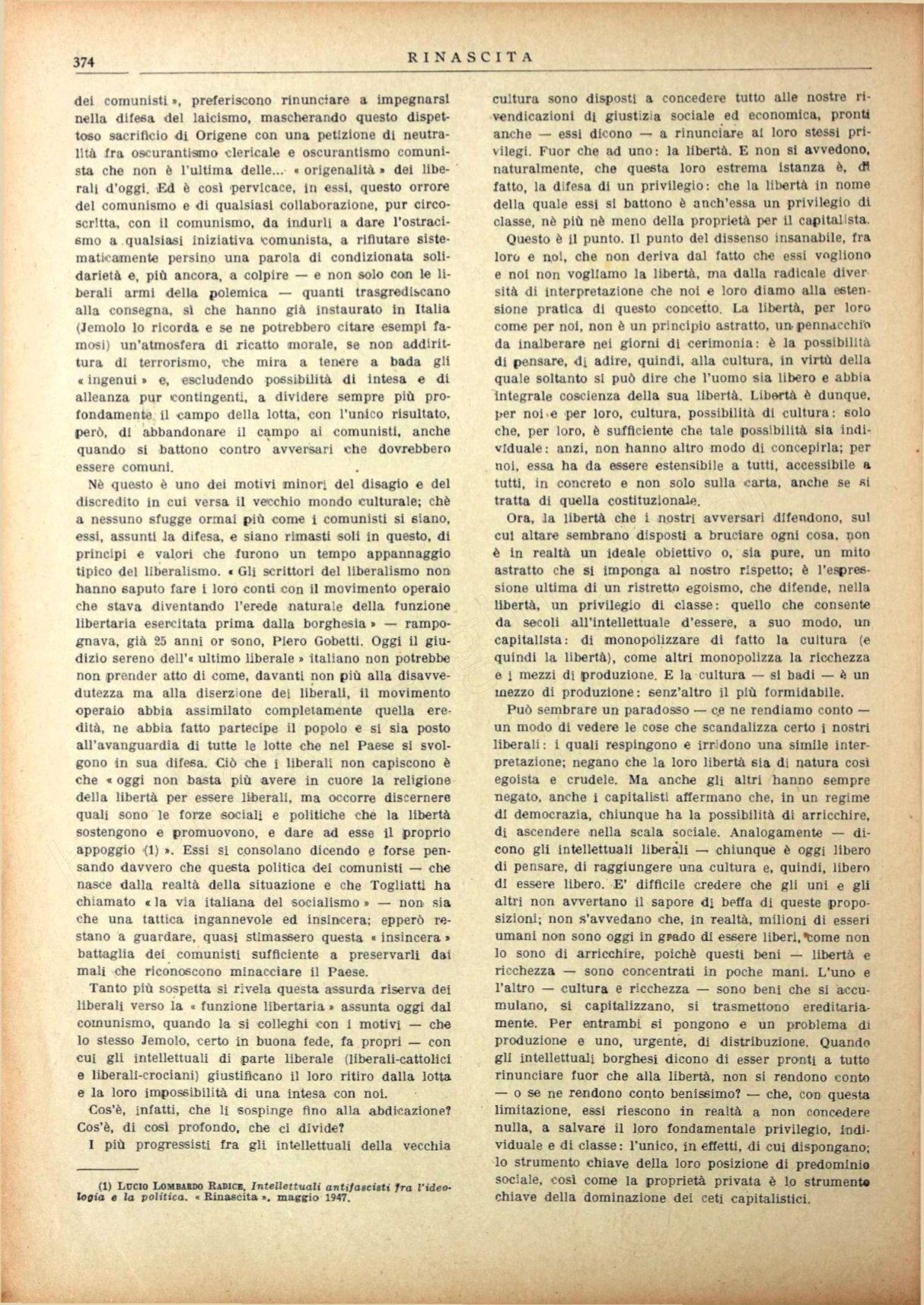
374
R I N A S C I T A
dei comunisti », preferiscono rinunciare a impegnarsi
nella difesa del laicismo, mascherando questo dispet–
toso sacrificio d i Origene con una petizione di neutra–
lità fra oscurantismo clericale e oscurantismo comuni–
sta che non è l 'ul t ima delle.»
-
• origenal i tà * dei libe–
ral i d'oggi. Ed è così pervicace, in essi, questo orrore
del comunismo e di qualsiasi collaborazione, pur circo–
scritta, con i l comunismo, da indur l i a dare l'ostraci–
smo a
.
qualsiasi iniziativa comunista, a rifiutare sìste-
matramente persino una parola di condizionata soli–
dar i e t à e, più ancora, a colpire — e non solo con le l i –
berali armi della polemica — quanti trasgrediscano
alla consegna, si che hanno già instaurato in Italia
{Jemolo lo ricorda e se ne potrebbero citare esempì fa–
mosi) un'atmosfera di ricatto inorale, se non addirit–
tura di terrorismo, che mi ra a tenere a bada gi i
« ingenui » e, escludendo possibilità d i intesa e d i
alleanza pur contingenti, a dividere sempre più pro–
fondamente i l -campo della lotta, con runico risultato,
però, di abbandonare i l campo ai comunisti, anche
quando si battono contro avversari che dovrebbero
essere comuni.
Nè questo è uno dei mot ivi minor i del disagio e del
discredito in cui versa i l vecchio mondo culturale; chè
a nessuno sfugge ormai più come i comunisti si siano,
essi, assunti Ja difesa, e siano rimasti soli in questo, di
principi e valori che furono un tempo appannaggio
tipico del liberalismo. • Gli scrittori del liberalismo non
hanno Gaputo fare i loro conti con i l movimento operaio
che stava diventando l'erede naturale della funzione
libertaria esercitata prima dalla borghes ia» — rampo–
gnava, già 25 anni or sono, Piero Gobetti. Oggi i l giu–
dìzio sereno dell'* ultimo liberale » italiano non potrebbe
non prender atto di come, davanti non più alla disavve¬
dutezza ma alla diserzione dei liberali, i l movimento
operaio abbia assimilato completamente quella ere–
dità, ne abbia fatto partecipe i l popolo e si sia posto
all'avanguardia di tutte le lotte che nel Paese si svol–
gono in sua difesa. Ciò che i liberali non capiscono è
che * oggi non basta più avere i n cuore la religione
della libertà per essere l iberal i , ma occorre discernere
quali sono le forze sociali e polìtiche che la libertà
sostengono e promuovono, e dare ad esse i l proprio
appoggio '(1) ». Essi si consolano dicendo $ forse pen–
sando davvero che questa politica del comunisti — che
nasce dalla real tà della situazione e che Togliatti ha
chiamato « l a vìa italiana del social ismo» — non. sia
che una tattica ingannevole ed insincera; epperò re–
stano a guardare, quasi stimassero questa » ins incera»
battaglia dei comunisti sufficiente a preservarli dai
mali che riconoscono minacciare i l Paese.
Tanto più sospetta si rivela questa assurda riserva dei
liberali verso la « funzione libertaria » assunta oggi dal
comunismo, quando la si colleghi con I mot ivi — che
lo stesso Jemolo, certo in buona fede, fa propri — con
cui gl i intellettuali di parte liberale (liberali-cattolici
e liberali-crociani) giustificano i l loro ri t iro dalia lotta
e Ja loro impossibilità d i una intesa con noi.
Cos'è, infatti, che l i sospìnge fino alla abdicazione?
Cos'è, d i cosi profondo, che ci divide?
I più progressisti fra g l i intellettuali della vaccina
(1) Lucio
LOMBARDO RADICE.
Intellettuali
antifascisti fra l'ideo*
logia e la politica.
» Rinasc i ta », maggio 1947.
cultura sono disposti a concedere tutto alle nostre r i –
vendicazioni di giustizia sociale ed economica, pronti
anche — essi dicono — a rinunciare ai loro stessi pri–
vilegi. Fuor che ad uno: la libertà. E non si avvedono,
naturalmente, che questa loro estrema istanza è, (fi
fatto, la difesa di un privi legio: che la l ibertà in nome
della quale essi si battono è anch'essa un privilegio di
classe, nè più nè meno della propr ietà per i l capitalista.
Questo è i l punto. l i punto del dissenso insanabile, fra
loro e noi, che non deriva dal fatto che essi vogliono
e noi non vogliamo la l ibertà, ma dalla radicale diver–
si tà d i interpretazione che noi e loro diamo alla esten–
sione pratica di questo concetto. La libertà, per loro
come per noi, non è un principio astratto, impennacchio
da inalberare nei giorni di cerimonia: è la possibilità
di pensare, d i adire, quindi, alla cultura, in virtù della
quale soltanto si può dire che l'uomo sia libero e abbia
integrale coscienza della sua libertà. Libertà è dunque,
per noi-e per loro, cultura, possibilità di cultura: solo
che, per loro, è sufficiente che tale possibilità sia indi–
viduale: anzi, non hanno altro modo di concepirla; per
noi, essa ha da essere estensibile a tut t i , accessibile a
tut t i , in concreto e non solo sulla carta, anche se al
tratta di quella costituzionale.
Ora, la libertà che i nostri avversari difendono, sul
cui altare sembrano disposti a bruciare ogni cosa, non
è in real tà un ideale obiettivo o, sia pure, un mito
astratto che si imponga al nostro rispetto; è l'espres–
sione ultima di un ristretto egoismo, che difende, nella
libertà, un privilegio di classe: quello che consente
da secoli all'intellettuale d'essere, a suo modo, un
capitalista: di monopolizzare d i fatto la cultura (e
quindi la libertà), come al t r i monopolizza la ricchezza
e i mezzi di produzione. E la cultura — si badi — è un
mezzo di produzione: senz'altro i l più formidabile.
Può sembrare un paradosso —c.e ne rendiamo conto —
un modo di vedere le cose che scandalizza certo ì nostri
l iberal i : 1 quali respingono e irridono una simile inter–
pretazione; negano che la loro libertà Già di natura così
egoista e crudele. Ma anche gl i al t r i hanno sempre
negato, anche i capitalisti affermano che, i n un regime
di democrazia, chiunque ha la possibilità di arricchire,
di ascendere nella scala sociale. Analogamente — di –
cono gl i intellettuali liberali — chiunque è oggi libero
di pensare, di raggiungere una cultura e, quindi, libero
di essere libero. E' diffìcile credere che gl i uni e g l i
al tri non avvertano i l sapore d i beffa di queste propo–
sizioni; non s'avvedano «che, in real tà, mi l ioni di esseri
umani non sono oggi in gpado di essere liberi , tome non
lo sono di arricchire, poiché questi beni — l ibertà e
ricchezza — sono concentrati In poche mani. L'uno e
l 'altro — cultura e ricchezza — sono beni che si accu–
mulano, si capitalizzano, si trasmettono ereditaria–
mente. Per entrambi
si
pongono e un problema di
produzione e uno, urgente, di distribuzione. Quando
gl i intellettuali borghesi dicono di esser pronti a tutto
rinunciare fuor che alla libertà, non si rendono conto
— o se ne rendono conto benissimo? — che, con questa
limitazione, esisl riescono i n real tà a non concedere
nulla, a salvare i l loro fondamentale privilegio, indi–
viduale e d i classe: l'unico, in effetti, di cui dispongano;
lo strumento chiave della loro posizione di predominio
sociale, cosi come la propr ietà privata è lo strumenta
chiave della dominazione dei ceti capitalistici.