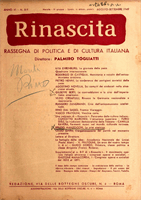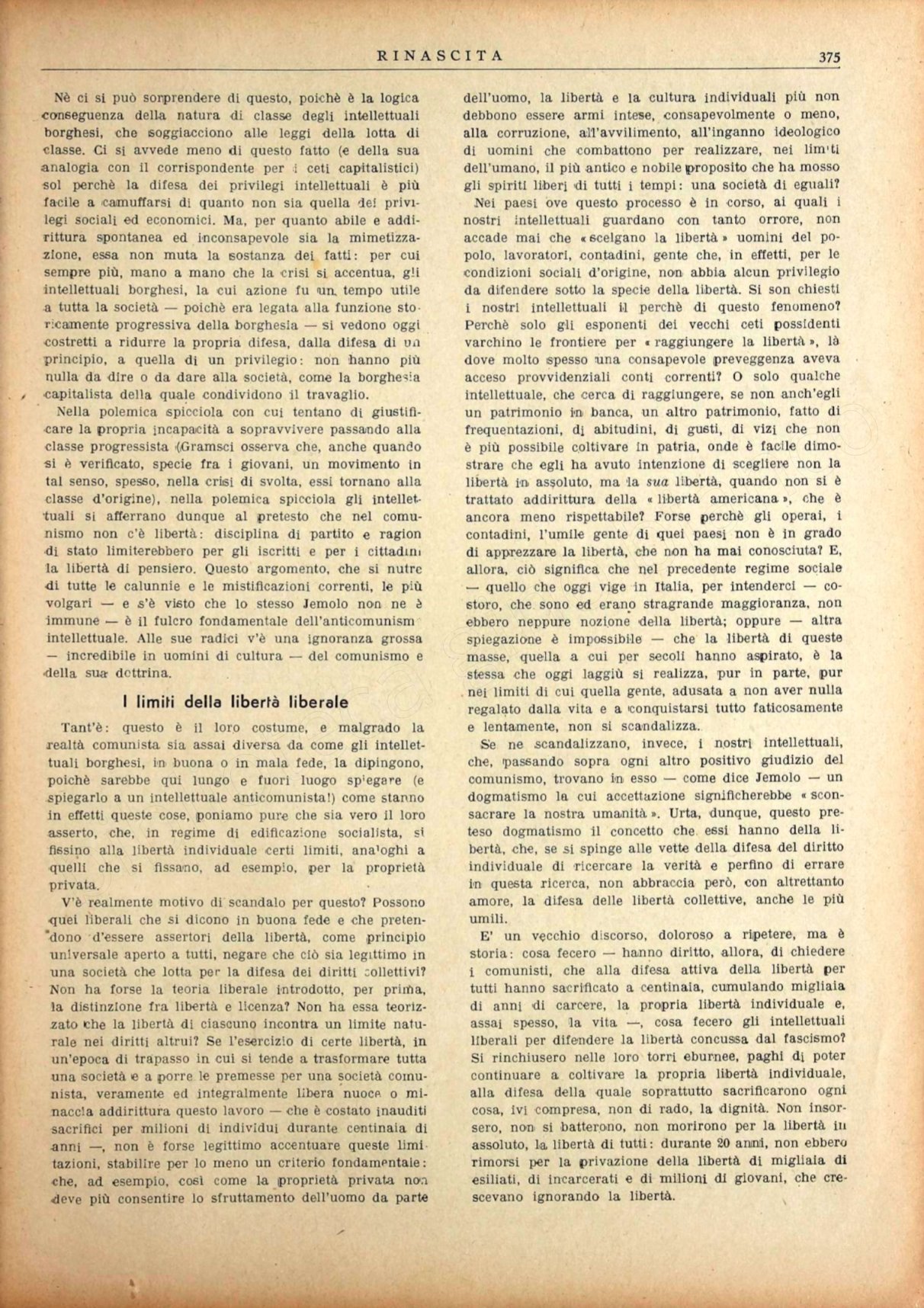
R I N A S C I T A
375
Nè
ci
si può sorprendere di questo, poiché è la logica
conseguenza della natura
di classe
degli intellettuali
borghesi, che soggiacciono alle leggi della lotta di
classe. Ci
si
avvede meno d i questo fatto (e della sua
analogia con i l corrispondente
per d ceti
capitalistici)
sol perchè la
difesa dei privilegi
intellettuali
è
più
facile
a camuffarsi di
quanto
non sia
quella
dei
pr ivi –
legi sociali
ed economici.
Ma,
per
quanto abile e addi–
r i t tura spontanea ed
inconsapevole
sia la mimetizza–
zione, essa non muta la
sostanza
dei fat t i : per cui
sempre più, mano a mano
che la crisi si
accentua,
g l i
intellettuali borghesi,
la cui azione fu
un. tempo
utile
a tutta la
società — poiché era legata alla
funzione sto–
ricamente
progressiva
della
borghesìa
—
si
vedono
oggi
costretti a ridurre
la
propria
difesa,
dalla difesa di
un
principio,
a
quella di un
privilegio: non
hanno più
nulla da dire o da dare
alla società,
come la borghesìa
capitalista della quale
condividono 11 travaglio.
Nella
polemica spicciola con cui tentano
di
giustifi–
care
la propria incapaci tà a sopravvivere passando
alia
classe
progressista ^Gramsci osserva
che, anche quando
s ì
è
verificato,
specie
fra i giovani, un movimento
in
tal senso, spesso, neila
criisi
dì
svolta, essi
tornano
alla
classe
d'origine), nella
polemica spicciola
gl i intellet–
tua l i si afferrano dunque
al pretesto
che
nel comu–
nismo non c'è l iber tà: disciplina di
partito
e
ragion
•di stato
limiterebbero per gl i
iscrìtti
e per
i cittadini
la l ibertà di pensiero.
Questo argomento,
che si nutre
d i tutte te
calunnie
e le mistificazioni correnti, te più
volgari
— e
s'è visto che
lo
stesso
Jemolo
non
ne
è
immune — è i l
fulcro fondamentale
delTanticomunism
-
intellettuale. Alle sue radici v
'è una ignoranza grossa
— incredìbile in
uomini di
cultura
— del
comunismo
e
della
sua dottrina.
I l imi l i de l l a l ibertà l i be r a l e
Tant
' è : questo è i l loro costume,
e malgrado la
real tà comunista sia assai diversa da come
gl i intellet–
tual i
borghesi,
m
buona o in mala
fede, la dipingono,
poiché
sarebbe
qui lungo
e fuori luogo sptegere (e
spiegarlo a un
intellettuale anticomunista!) come stanno
i n effetti
queste cose,
poniamo
pure che sia vero
i l
loro
asserto,
che, in regime dì edificazione
socialista, sì
fissino alla l iber tà
individuale certi l imi t i , anateghi
a
quelli
che si fissano,
ad esempio,
per
la proprietà
privata.
V'è
realmente
motivo di scandalo per questo? Possono
quel liberali
che si dicono
in buona
fede e che preten–
dono
d
'essere assertori
della libertà,
come
principio
universale
aperto a tut t i , negare che ciò sia legittimo in
una società che lotta per la difesa
dei di r i t t i collettivi?
Non ha forse la teorìa
liberale introdotto, per prima,
la distinzione fra l ibertà e licenza7 Non ha essa teoriz–
zato che
la
l ibertà di
ciascuno incontra un limite natu–
rale nei d i r i t t i
altrui? Se
l
'esercizio
di certe l ibertà, in
un'epoca di trapasso
i n cui si tende
a
trasformare tutta
una società e a
porre te premesse per
una società comu–
nista,
veramente ed integralmente libera nuoce, o mi –
naccia addirittura questo lavoro —
ohe è
costato inauditi
sacrifìci
per
mi l i on i di
individui durante centinaia
di
anni —
non
è forse legittimo
accentuare queste l imi
tazìoni, stabilire per lo meno un criterio fondamentale:
che, ad esempio, così come la propr ietà
privata non
deve più consentire lo sfruttamento
dell'uomo da parte
dell'uomo, la l ibertà e la cultura individual i più non
debbono essere armi intese, consapevolmente o meno,
alia corruzione, all'avvilimento, all'inganno ideologico
dì uomini che combattono per realizzare, nei l i n r t i
dell'umano, i l più antico e nobile proposito che ha mosso
g l i spìriti liberi d i tut t i i tempi: una società d i eguali?
Nei paesi ove questo processo è in corso, ai quali i
nostri intellettuali guardano con tanto orrore, non
accade mai che «scelgano la l iber tà» uomini del po–
polo, lavoratori, contadini, gente che, in effetti, per le
condizioni sociali d'origine, non abbia alcun privilegio
da difendere sotto la specie della libertà. Si son chiesti
i nostri intellettuali U perchè di questo fenomeno?
Perchè solo gl i esponenti dei vecchi ceti possidenti
varchino le frontiere per «raggiungere la l iber tà», là
dove molto ispesso una consapevole preveggenza aveva
acceso provvidenziali conti correnti? O solo qualche
intellettuale, che cerca di raggiungere, se non anch'egli
un patrimonio
m
banca, un altro patrimonio, fatto di
frequentazioni, l i abitudini, d i gusti, di vìzi che non
è più possibile coltivare in patria, onde è facile dimo–
strare che egli ha avuto intenzione di scegliere non la
l ibertà in. assoluto, ma la
sua
l ibertà, quando non si è
trattato addirittura della «l iber tà americana
che è
ancora meno rispettabile? Forse perchè gl i operai, i
contadini, l 'umile gente di quei paesi non è in grado
di apprezzare l a libertà, che non ha mai conosciuta? E,
allora, ciò significa che nel precedente regime sociale
— quello che oggi vìge i n Italia, per intenderci — co–
storo, che sono ed erano stragrande maggioranza, non
ebbero neppure nozione della libertà; oppure — altra
spiegazione
è
impossibile — che la l ibertà di queste
masse, quella a cui per secoli hanno aspirato, è la
stessa che oggi laggiù si realizza, pur in parte, pur
.
nei l imi t i di cui quella gente, adusata a non aver nulla
regalato dalla vita e a conquistarsi tutto faticosamente
e lentamente, non si scandalizza.
Se ne scandalizzano, invece, i nostri intellettuali,
che, passando sopra ogni altro positivo giudizio del
comunismo, trovano i n esso — come dice Jemolo — un
dogmatismo la cui accettazione significherebbe « scon–
sacrare la nostra uman i t à ». Urta, dunque, questo pre–
teso dogmatismo i l concetto che essi hanno della l i –
bertà, che, se si spinge alle vette della difesa del diritto
individuale di ricercare la verità e perfino dì errare
m
questa ricerca, non abbraccia però, con altrettanto
amore, la difesa delle libertà collettive, anche le più
umi l i .
E' un vecchio discorso, doloroso a ripetere, ma è
storia: cosa fecero — hanno diritto, allora, di chiedere
i comunisti, che alla difesa attiva della libertà per
tut t i hanno sacrificato a centinaia, cumulando migliaia
di anni d i carcere, la propria l ibertà individuale e,
assai spesso, la vita —, cosa fecero gl i intellettuali
liberali per difendere la l ibertà concussa dal fascismo?
Si rinchiusero nelle loro tor r i eburnee, paghi dì poter
continuare a coltivare la propria libertà individuale,
alla difesa della quale soprattutto sacrificarono ogni
cosa, i v i compresa, non di rado, la digni tà. Non Insor–
sero, non si batterono, non morirono per la libertà i n
assoluto, la libertà d i t u t t i : durante 20 anni, non ebbero
rimorsi per la privazione della l ibertà dì migliaia di
esiliati, di incarcerati e dì mi l i on i di giovani, che cre–
scevano ignorando la libertà.