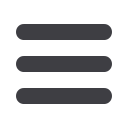
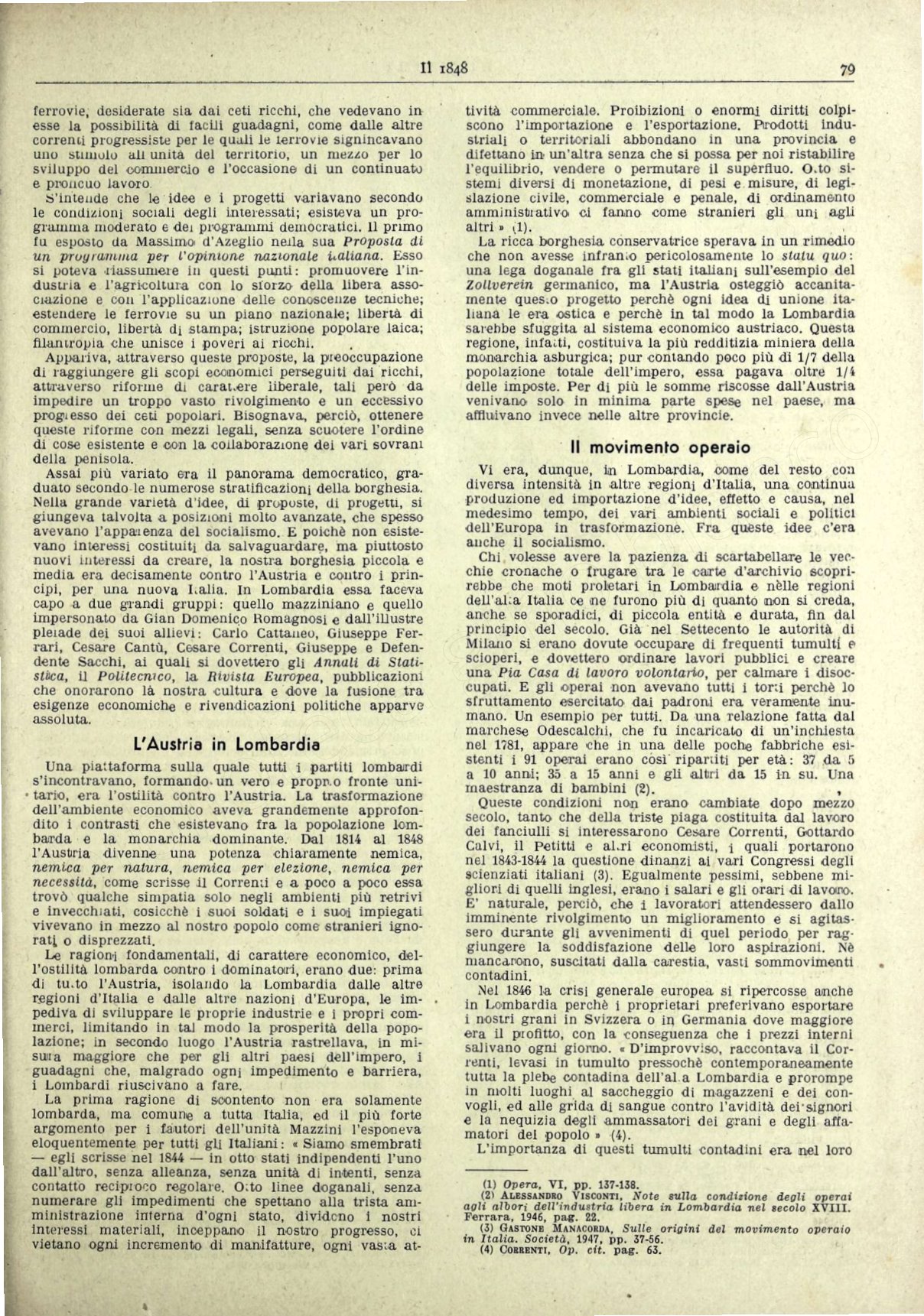
Il1848
7
9
ferrovie,desideratesia dai ceti ricchi, chevedevano in
essela possibilità di facili guadagni,comedalle altre
correntiprogressisteper lequali le ferroviesignincavano
unostimolo ali unita del territorio, unmezzoper lo
sviluppodel commercioe l'occasione di un continuato
eproncuolavoro.
S'intendeche le idee e i progetti variavanosecondo
lecondizioni sociali degli interessati;esistevaun pro-
grammamoderatoedeiprogranunidemocratici.11primo
fuespostodaMassimod'Azeglionellasua
Proposta di
unprogrammaper l'opinionenazionale itatiana.Esso
sipoteva'riassumere in questi punti: promuovere l'in-
dustria e l'agricoltura con lo sforzodella liberaasso-
ciazionee con l'applicazionedelleconoscenzetecniche;
estendere le ferrovie su un pianonazionale; libertà di
commercio, libertà di stampa; istruzionepopolare laica;
filantropiacheunisce í poveri ai ricchi.
Appariva,attraversoquesteproposte, lapreoccupazione
di raggiungere gli scopieconomiciperseguiti dai ricchi,
attraverso riforme di carat.ere liberale, tali però da
impedireun troppovasto rivolgimento e uneccessivo
pro&essodei ceti popolari.Bisognava,perciò,ottenere
questeriformecanmezzi legali,senzascuoterel'ordine
dicoseesistenteecon lacolaborazionedei vari sovrani
dellapenisola.
Assai più variato era i l panoramademocratico, gra-
duatosecondolenumerosestratificazioni dellaborghesia.
Nelagrandevarietàd'idee, di proposte, di progetti, si
giungevatalvoita aposizionimoltoavanzate,chespesso
avevanol'appaienzadel socialismo.Epoichènonesiste-
vanointeressi costituiti dasalvaguardare,mapiuttosto
nuovi interessi dacreare, la nostraborghesiapiccolae
mediaeradecisamentecontro l'Austria econtro i prin-
cipi, per unanuova Lalia. In Lombardiaessafaceva
capoa duegrandi gruppi: quellomazzinianoe quello
impersonatodaGianDomenicoHomagnosiedall'illustre
pleiadedei suoi allievi: CarloCattaneo,GiuseppeFer-
rari,CesareCantù,CesareCorrenti,GiuseppeeDefen-
denteSacchi, ai quali si dovettero gli
Annali di Stati-
stilca, i l Politecnico, la RivistaEuropea,pubblicazioni
cheonorarono là nostra cultura edove la fusione tra
esigenzeeconomichee rivendicazioni politicheapparve
assoluta.
•
L'AustriainLombardia
Unapiattaforma sulla quale tutti i partiti lombairdi
s'incontravano,formando.unveroeproprio fronte uni-
•tario, era l'ostilità contro l'Austria. La trasformazione
dell'ambienteeconomicoavevagrandementeapprofon-
dito i contrasti che'esistevano fra la popolazionelom-
barda e la monarchiadominante. Dal 1814 al 1848
l'Austriadivenne una potenzachiaramentenemica,
nemicaper natura, nemica per elezione,nemica per
necessità,
comescrisse il Correnti e apocoapocoessa
trovòqualchesimpatia solo negli ambienti più retrivi
einvecchiati,cosicchè i suoi soldati e i suoi impiegati
vivevano inmezzoal nostropopolocomestranieri igno-
rati odisprezzati.
Leragioni fondamentali, di carattereeconomico,del-
l'ostilità lombardacontro i dominatori,eranodue:prima
di tutto l'Austria, isolando la Lombardia dalle altre
regioni d'Italia e dalle altre nazioni d'Europa, le im-
pedivadi sviluppare leproprie industriee i propri com-
merci, limitando in tal modo la prosperitàdellapopo-
lazione; in secondoluogo l'Austria rastrellava, in mi-
suramaggioreche per gli altri paesi dell'impero, i
guadagniche,malgradoogni impedimento e barriera,
i Lombardi riuscivano a fare.
Laprima ragione di soontentonon era solamente
lombarda,macomune a tutta Italia, ed i l più forte
argomentoper i fautori dell'unitàMazzini l'esponeva
eloquentementeper tutti gli
« Siamosmembrati
—egli scrissenel1844—in otto stati indipendenti l'uno
dall'altro,senzaalleanza,senzaunità di intenti, senza
contattorecipiocoregolare.Ozto lineedoganali,senza
numeraregli impedimenti chespettano alla tristaam-
ministrazione interna d'ogni stato, dividono i nostri
Interessimateriali, inceppano i l nostroprogresso, ci
vietanoogni incremento di manifatture, ognivas*Laat-
tivitàcommerciale.Proibizioni o enormi diritti colpi-
sconol'importazione e l'esportazione. Prodotti indu-
striali o territoriali abbondano in una provincia e
difettano in un'altrasenzachesipossapernoi r
istabilire
l'equilibrio, vendere o permutare il superfluo.
0.tosi-
stemidiversi di monetazione, di pesi emisure
, di legi-
slazionecivile, commerciale e penale, di ordinamento
amministrativo ci farina comestranieri gli uni agli
altriDkl).
Lariccaborghesiaconservatricesperava in unrimedio
chenonavesseinfrarLopericolosamente lo
statuquo:
unalegadoganale fra gli stati italiani sull'esempiodel
Zollverein
germanico, ma l'Austria osteggiòaccanita-
menteques:oprogettoperchèogni idea di unione ita-
liana le eraosticaeperchè in tal modo la Lombardia
sarebbesfuggita al sistemaeconomicoaustriaco.Questa
regione, infatti, costituiva la più redditiziaminieradella
monarchiaasburgica; purcontandopocopiù di 1/7della
popolazionetotale dell'impero, essapagava oltre 1/4
deleimposte.Per di più lesommeriscossedall'Austria
venivanosolo in minima partespese nel paese,ma
affluivanoinvecenelle altreprovincie.
Ilmovimentooperaio
Vi era, dunque, in Lombardia,come del resto con
diversaintensità, in altre regioni d'Italia, unacontinua
produzioneed importazioned'idee, effetto ecausa, nel
medesimotempo, dei vari ambienti sociali e politici
dell'Europa in trasformazione. Fra queste idee c'era
anche il socialismo.
Chivolesseavere la pazienzadi scartabellare le vec-
chiecronache o
frugare
tra le carted'archivioscopri-
rebbechemoti proletari in Lombardia e nélle regioni
dell'ala Italiacenefurono più di quantonon si creda,
anchesesporadici, di piccolaentità e durata, fin dal
principio del secolo.Già nel Settecento le autorità di
Milano si eranodovute'occuparedi frequenti tumulti e
scioperi, e dovetteroordinare lavori pubblici e creare
unaPiaCasadi lavorovolontario, percalmare i disoc-
cupati. E gli operai nonavevano tutti i torti perchè lo
sfruttamentoesercitatodai padroni eraveramente inu-
mano.Unesempioper tutti. Daunarelazione fatta dal
marcheseOdescalchi,che fu incaricato di un'inchiesta
nel1781,appareche in unadellepochefabbricheesi-
stenti i 91operai eranocasi' ripartiti per età: 37da 5
a10anni; 35 a 15anni e gli altri da15 in. su.Una
maestranzadi bambini (2).
Questecondizioni non eranocambiatedopomezzo
secolo,tantochedella tristepiagacostituitadal lavoro
dei fanciulli si interessaronoCesareCorrenti,Gottardo
Calvi, i l Petitti e alzi economisti, i quali portarono
nel1843-1844laquestionedinanzi ai variCongressidegli
scienziati italiani (3).Egualmentepessimi,sebbenemi-
gliori di quelli inglesi,erano i salariegli orari di lavora.
E'naturale, perciò, che i lavoratoriattendesserodallo
imminenterivolgimento unmiglioramento e si agitas-
serodurante gli avvenimenti di quel periodoper rag-
giungere la soddisfazione delle loro aspirazioni. Nè
manca,riono,suscitati dallacarestia, vasti sommovimenti
contadini.
Nel1846la Crisigeneraleeuropeasi ripercosseanche
inLombardiaperchè i proprietari preferivanoesportare
i nostri grani inSvizzerao inGermaniadovemaggiore
era il profitto, con laconseguenzache i prezzi interni
salivanoogni giorno. «D'improvviso,raccontava il Cor-
renti, levasi in tumultopressochècontemporaneamente
tutta laplebecontadinadell'al.a.Lombardiaeprorompe
inmolti luoghi al saccheggio di magazzeni e dei con-
vogli,edallegrida di sanguecontro l'aviditàdei•signori
ela nequiziadegliammassataridei grani e degli affa-
matori del popolo .(4).
L'importanza di questi tumulti contadini eranel loro
(1)Opera,
VI, pp.137-138.
(21ALESSANDROVISCONTI,
Note sulla condizione degli operai
agli albori dell'industria libera in Lombardianel secolo
XVIII.
Ferrara,1946,pag.22.
(3)GASTONEMANACORDA,
Sulle origini del movimentooperaio
in Italia. Società,
1947,pp.37-56.
(4)CORRENTI,OP. Cit. pag. 63.
















