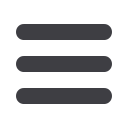
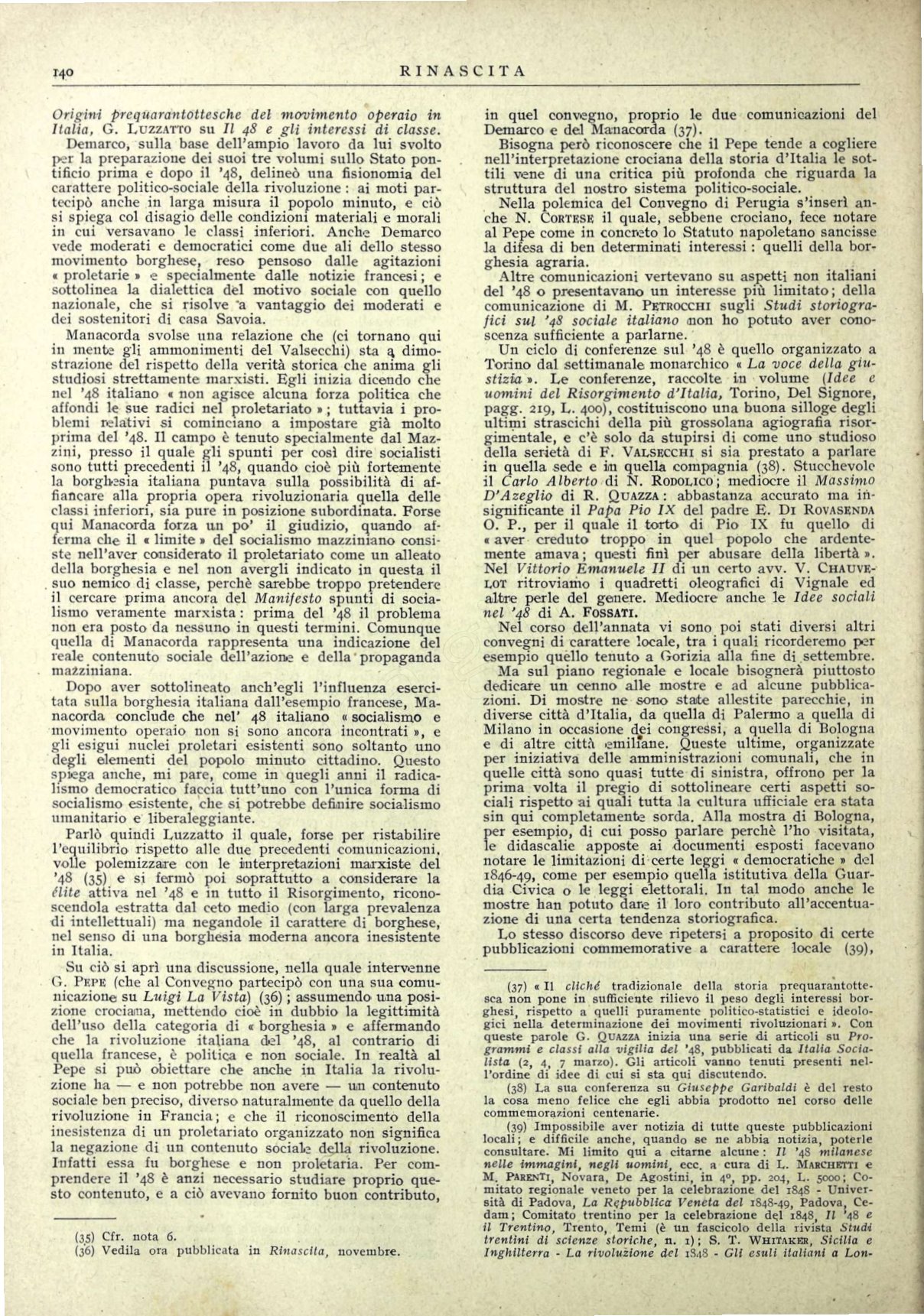
149
RINASCITA
Originiprequarantotteschedelmovimentooperaio in
Italia,
G.LUZZATTOSU
II 48e gli interessi di classe.
Demarco,•sulabasedel'ampiolavorodaluisvolto
perlapreparazionedeisuoitrevolumisulloStatopon-
tificioprimaedopoil '48,delineòunafisionomiadel
caraterepolitico-socialedellarivoluzione:aimotipar-
tecipòancheinlargamisura ilpopolominuto,eciò
sispiegacoldisagiodelecondizionimaterialiemorali
incuiversavanoleclassiinferiori.AncheDemarco
vedemoderatiedemocraticicomeduealidellostesso
movimentoborghese,resopensosodalleagitazioni
«proletarie»especialmentedallenotiziefrancesi;e
sotolinealadialetticadelmotivosocialeconquello
nazionale,chesirisolve'avantaggiodeimoderatie
deisostenitoridicasaSavoia.
Manacordasvolseunarelazioneche(citornanoqui
inmentegliammonimentidelValsecchi)stadimo-
strazionedelrispettodellaveritàstoricacheanimagli
studiosistrettamentemarxisti.Egli iniziadicendoche
nel'48italiano«nonagiscealcunaforzapoliticache
affondilesueradicinelproletariato»;tuttavia i pro-
blemirelativi sicomincianoaimpostaregiàmolto
primadel'48. IlcampoètenutospecialmentedalMaz-
zini,pressoilqualeglispuntipercosìdiresocialisti
sonotuttiprecedentiil '48,quandocioèpiùfortemente
laborghesiaitalianapuntavasullapossibilitàdi af-
fiancareallapropriaoperarivoluzionariaquelladelle
classiinferiori,siapureinposizionesubordinata.Forse
quiManacordaforzaunpo' il giudizio,quandoaf-
fermacheil«limite»delsocialismomazzinianoconsi-
stenel'averconsideratoilproletariatocomeunalleato
delaborghesiaenelnonavergliindicatoinquestail
.suonemicodiclasse,perchèsarebbetroppopretendere
ilcercareprimaancoradel
Manifesto
spuntidisocia-
lismoveramentemarxista:primadel'48 ilproblema
nonerapostodanessunoinquestitermini.Comunque
queladiManacordarappresentaunaindicazionedel
realecontenutosocialedel'azioneedelapropaganda
m atziniana.
Dopoaversottolineatoanch'eglil'influenzaeserci-
tatasullaborghesiaitalianadal'esempiofrancese,Ma-
nacordaconcludechenel' 48italiano«socialismoe
movimentooperaiononSisonoancoraincontrati»,e
gliesiguinucleiproletariesistentisonosoltantouno
•deglielementidelpopolominutocittadino.Questo
spiegaanche,mipare,comeinqueglianni il radica-
lismodemocraticofacciatutt'unoconl'unicaformadi
socialismoesistente,chesipotrebbedefiniresocialismo
umanitarioeliberaleggiante.
ParlòquindiLuzzatto il quale,forseperristabilire
l'equilibriorispettoalledueprecedenticomunicazioni.
vollepolemizzareconleinterpretazionimarxistedel
'48(35) e sifermòpoisoprattuttoaconsiderarela
élite
attivanel'48eintutto ilRisorgimento,ricono-
scendolaestrattadalcetomedio(conlargaprevalenza
diintellettuali)manegandoleilcaratterediborghese,
nelsensodiunaborghesiamodernaancorainesistente
inItalia. Suciòsiaprìunadiscussione,nellaqualeintervenne
G.PEPE(chealConvegnopartecipòconunasuacomu-
nicazionesu
LuigiLaVista)
(36);assumendounaposi-
zionecrociana,metendocioèindubbiolalegittimità
del'usodellacategoriadi «borghesia»eaffermando
chelarivoluzioneitalianadel '48, al contrariodi
quelafrancese,èpoliticaenonsociale. In realtàal
Pepesipuòobiettarecheanchein Italia larivolu-
zioneha—enonpotrebbenonavere—uncontenuto
socialebenpreciso,diversonaturalmentedaquelodela
rivoluzioneinFrancia;eche il riconoscimentodella
inesistenzadiunproletariatoorganizzatononsignifica
lanegazionediuncontenutosocialedellarivoluzione.
Infattiessafuborgheseenonproletaria.Percom-
prendereil '48éanzinecessariostudiareproprioque-
stocontenuto,eaciòavevanofornitobuoncontributo,
•
(35)Cfr.nota6.
(3.6)Vedilaorapubblicata
inRinascita,
novembre.
inquelconvegno,proprioleduecomunicazionidel
DemarcoedelManacorda(37).
BisognaperòriconoscerecheilPepetendeacogliere
nell'interpretazionecrocianadellastoriad'Italialesot-
tilivenediunacriticapiùprofondacheriguardala
strutturadelnostrosistemapolitico-sociale.
NelapolemicadelConvegnodiPerugias'inserìan-
cheN.CORTESEilquale,sebbenecrociano,fecenotare
alPepecomeinconcretoloStatutonapoletanosancisse
ladifesadibendeterminatiinteressi:quellidellabor-
ghesiaagraria.
Altrecomunicazionivertevanosuaspettinonitaliani
del'48opresentavanouninteressepiùlimitato;della
comunicazionediM.Prritoccmsugli
Studistoriogra-
fici sul '48socialeitaliano
nonhopotutoavercono-
scenzasufficienteaparlarne.
Unciclodiconferenzesul'48èqueloorganizzatoa
Torinodalsettimanalemonarchico«
Lavocedellagiu-
stizia».
Leconferenze,raccolte involume
(Idee
e
uominidelRisorgimentod'Italia,
Torino,DelSignore,
pagg.219,L.400),costituisconounabuonasilogedegli
ultimistrascichidellapiùgrossolanaagiografiarisor-
gimentale,ec'èsolodastupirsidicomeunostudioso
delaserietàdi F.VALSECCHIsisiaprestatoaparlare
inquelasedeeinquellacompagnia(38).Stucchevole
il
CarloAlberto
diN.RODOLICO ;mediocreil
Massimo
D'Azeglio
di R.QUAZZA:abbastanzaaccuratomain-
significanteil
PapaPioIX
delpadreE. DiROVASENDA
O.P., per ilquale il tortodi Pio IX fuquellodi
«avercredutotroppo in quelpòpolocheardente-
menteamava;questifiniperabusaredellalibertà».
Nel
VittorioEmanuele //
diuncertoavv.V.CHAUVE-
LOT ritroviamo i quadrettioleograficidiVignaleed
altreperledelgenere.Mediocreanche.
leIdeesociali
nel'48
diA.FOSSATI.
Nelcorsodell'annatavisonopoistatidiversialtri
convegnidicaratterelocale,tra iqualiricorderemoper
esempioquellotenutoaGoriziaallafinedisetembre.
Masulpianoregionaleelocalebisognerapiuttosto
dedicareuncennoallemostreeadalcunepubblica-
zioni.Dimostre
ne
•sonostateallestiteparecchie, in
diversecittàd'Italia,daqueladiPalermoaquelladi
Milanoinoccasionedeicongressi,aqueladiBologna
edi altrecittàemiliane.Questeultime,organizzate
periniziativadelleamministrazionicomunali,chein
quellecittàsonoquasituttedisinistra,offronoperla
primavolta il pregiodisottolinearecertiaspettiso-
cialirispettoaiqualituttalaculturaufficialeerastata
sinquicompletamentesorda.AllamostradiBologna,
peresempio,dicuipossoparlareperchél'hovisitata,
ledidascalieapposteaidocumentiespostifacevano
notarelelimitazionidicerteleggi«democratiche»del
1846-49,comeperesempioquelaistitutivadellaGuar-
diaCivicaoleleggielettorali. In talmodoanchele
mostrehanpotutodareil lorocontributoal'accentua-
zionediunacertatendenzastoriografica.
Lostessodiscorsodeveripetersiapropositodicerte
pubblicazionicommemorativeacaratterelocale(39),
(37)
«
Il
cliché
tradizionale della storia
prequarantotte-
scanonponeinsufficienterilievo ilpesodegliinteressibor-
ghesi,rispettoaquellipuramentepolitico-statistici e ideolo-
gicinelladeterminazionedeimovimentirivoluzionari».Con
questeparoleG.QUAZZAiniziaunaserie di articolisu
Pro-
grammieclassi alla vigilia del
'48,pubblicatida
ItaliaSocia-
lista
(2, 4, 7marzo).Gli articolivannotenutipresentinel-
l'ordinedi ideedi cuisi staquidiscutendo.
(38)Lasuaconferenzasu
GiuseppeGaribaldi
èdelresto
lacosamenofelicecheegliabbiaprodottonelcorsodelle
commemorazionicentenarie.
(39)Impossibileavernotiziadi tuttequestepubblicazioni
locali; e difficileanche,quandoseneabbianotizia,poterle
consultare.Mi limitoqui acitarnealcune:
I l
'48
milanese
neleimmagini,negliuomini,
ecc, acuradi L.mARcurrine
M.PARENTI,
Novara,DeAgostini, in 40,pp.204, L. 5000;Co-
mitatoregionalevenetoper lacelebrazionedel1848- Univer-
sitàdiPadova,
LaRepubblicaVenetadel
1848-49,
Padova,Ce
-
dam;Comitatotrentinoper lacelebrazionedel1848,
Il
'48e
ilTrentino,
Trento,Temi (è unfascicolodellarivista
Studd
trentini di scienzestoriche,
n. i); S. T.WHITAKER,
Sicilia e
Inghilterra - La rivoluìionedel1348- Gli esuli italiani aLon-
















