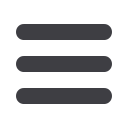
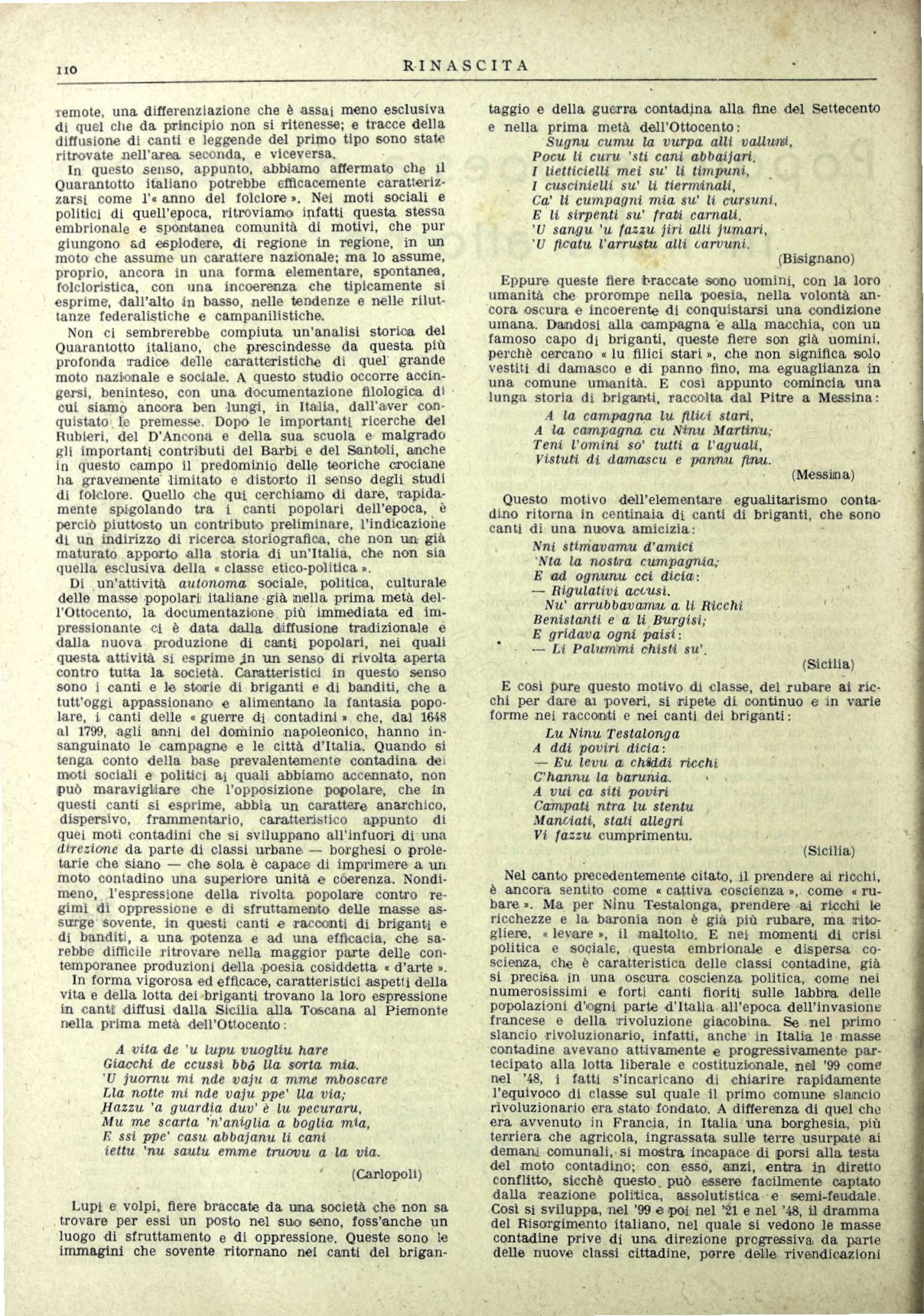
110
RINASCITA
remote,unadifferenziazionecheèassaimenoesclusiva
di quelchedaprincipionon si ritenesse; e traccedella
diffusionedi canti eleggendedel primo tiposonostate
ritrovatenell'areaseconda, e viceversa.
In
questosenso,appunto,abbiamoaffermatoche i l
Quarantotto italiano potrebbeefficacementecaratteriz-
zarsicome l'« annodel folclore31.Nei moti sociali e
politici di quell'epoca, ritroviamo infatti questastessa
embrionale e spontaneacomunità di motivi, che pur
giungonoadesplodere, di regione in regione, in un
motocheassumeuncaratterenazionale;ma loassume,
proprio,ancora in una formaelementare,spontanea,
folcloristica, con una incoerenzache tipicamente si
esprime,dall'alto in basso,nelletendenzee nelle rilut-
tanzefederalistiche e campanilistiche.
Nonci sembrerebbecompiuta un'analisi storica del
Quarantotto italiano, cheprescindesseda questa più
profondaradice delle caratteristiche di quei grande
motonazionaleesociale.Aquestostudiooccorreaccin-
gersi,beninteso, con unadocumentazionefilologica di
cuisiamoamara ben lungi, in Italia, dall'aver con-
quistato le premesse.Dopo le importanti ricerche del
Rubieri, del D'Ancona e della suascuola emalgrado
gli importanti contributi del Barbi edel Santoli,anche
inquestocampo i l predominiodelle teorichecrociane
hagravemente limitato e distorto i l sensodegli studi
di folclore.Quello.chequi cerchiamo di dare, !rapida-
mentespigolando tra i canti popolari dell'epoca, è
perciòpiuttosto un contributopreliminare, l'indicazione
di un indirizzo di ricercastoriografica,chenonufagià.
maturatoapporto alla storia di un'Italia, chenon sia
quellaesclusivadella«classeetico-politica».
Di_un'attività
autonoma
sociale, politica, culturale
dellemassepopolari italianegià, nellaprimametàdel-
l'Ottocento, la documentazione,più immediata ed im-
pressionante•ci è data dalla diffusione tradizionale e
dallanuovaproduzione di canti popolari, nei quali
questaattivitàSiesprime jn unsensodi rivoltaaperta
contro tutta la società.Caratteristici in questosenso
sono i canti e le starie di briganti e di banditi, che a
tutt'oggi.appassionanoe alimentano la fantasiapopo-
lare, i canti delle«guerre di contadini»che, dal1648
al1799,agli anni del dominio,napoleonico,hanno in-
sanguinato le campagnee le città, d'Italia.Quando si
tengaconto dellabaseprevalentementecontadinadei
moti sociali e politici ai quali abbiamoaccennato,non
puòmaravigliare che l'opposizionepopolare, che in
questi canti si esprime, abbia un carattereanarchico,
•dispersivo, frammentario, caratteristico appunto d i
queimoti contadiniche si sviluppano all'infuori di una
direzione
daparte di classi urbane—borghesi o prole-
tariechesiano—chesolaècapacedi imprimerea un
motocontadinounasuperioreunità ecóerenza.Nondi-
meno,l'espressione della rivolta popolarecontro re-
gimi di oppressionee di sfruttamentodellemasseas-
surgesovente, in questi canti e racconti di briganti e
di banditi, a una'potenzae ad una efficacia, chesa-
rebbedifficile ritrovare nellamaggior partedellecon-
temporaneeproduzioni dellapoesiacosiddetta«d'arte».
Informavigorosaedefficace,caratteristiciaspettidella
vitaedella lottadei briganti trovano la loroespressione
in canti diffusi dalla Sicilia allaToscana al Piemonte
nellaprimametà.dell'Ottocento:
Avitade 'u lupu vuogliuhare
Giacchideccussibbóha sortamia.
'Ujuornumi ndevaju anonemboseare
Lianottemi ndevajuppe' lla via;
liazzu 'a guardiaduv'è tu pecuraru,
Mumescarta 'n'aniglia a bogliamia,
Essi ppe'casuabbajanu li cani
iettu 'nu sautuemmetruovu a la via.
(Carlopoli)
Lupievolpi, fierebraccatedaufnasocietàche.nonsa
trovareper essi un posto nel suoseno,foss'ancheun
luogo di sfruttamento e di oppressione.Questesono le
immaginichesoventeritornano nei canti del brigan-
taggioe dellaguerracontadina alla finedelSettecento
enella primametàdell'Ottocento:
Sugnucumu la vurpa alli valluni,
Pocu li
CUTU
'sti cani abbaijari.
I lietticielli mei su' li timpuni,
I cuscinielli su' l i tiermfinali,
Ca' li cumpagnimiasu' li cursuni,
Eli sirpenti su' frati carnali.
'Usangu 'u fazzu jiri alli jumari,
'Uflcatu l'arrustu alli carvuni.
(Bisignano)
Eppurequestefiere'braccatesonouomini, con la loro
umanitàcheprorompenellapoesia, nella volontà an-
coraoscuraeincoerente di conquistarsi unacondizione
umana.Dandosi allacampagna"eallamacchia,conun
famosocapo di briganti, queste fiereson già uomini,
perchècercano« lu filici stari»,chenonsignificasolo
vestiti di damascoe di panno fino,maeguaglianza in
unacomuneumanità. E così appuntocomincia una
lungastoria di briganti, raccolta dal Pitre a
Messina:
Ala campagna tu ftlwi stari,
Ala campagnacuNinuMartinu;
'reni l'omini so' tutti a l'aguati,
Vistuti di darrnaseuepanna finu.
(Messina)
Questomotivo dell'elementareegualitarismo conta-
dinoritorna in centinaia di canti di briganti, chesono
canti di unanuovaamicizia:
Nnistiiriavamud'amici
'Nta la nostracumpagnia;
Eadognunucei dieta:
Rigulativiaccusi.
Nu'arrubbavamua. li Ricchi
Benistantie a li Burgisi;
Egridavaogni paisi:
-- Li PaluirreiniMisti su'.
(Sicilia)
Ecosì
Purequesto
motivo di classe,del rubare
ai
ric-
chi per dare ai poveri, si ripete di continuo e in varie
formenei racconti enei canti dei briganti:
LuNinuTestalonga
Addi poviri
Eulevu a chikldi ricchi
C'hannulabarunia.
Avui ca siti poviri
Campatintra tu stentu
Manciati, stati allegri
Vi fazzu
cumprimentu.
(Sicilia)
Nel-cantoprecedentementecitato, il prendereai ricchi,
èancorasentitocome«cattivacoscienza»,come« ru-
bare».Ma per NinuTestalonga,prendere ,ai ricchi le
ricchezzee la baronianon è già più rubare,maMa-
glierie,«levare», i l maltolto. E nei momenti di crisi
politica e sociale, ,questaembrionale e dispersa.Co-
scienza,che è caratteristicadelle classi contadine, già
siprecisa in unaoscuracoscienzapolitica, come nei
numerosissimi e forti canti fioriti sulle labbra delle
popolazionid'ogni parte d'Italia, all'epocadell'invasione
francese e della !rivoluzionegiacobina. Se nel primo
slanciorivoluzionario, infatti, anche in Italia lemasse
contadineavevanoattivamenteeprogressivamentepar-
tecipatoalla lotta liberaleecostituzionale, nel '99come
nel '48, i fatti s'incaricano di chiarire rapidamente
l'equivoco di classesul quale il primocomuneslancio
rivoluzionarioerastatofondato.Adifferenza di quelche
eraavvenuto in Francia, in Italia unaborghesia, più
terrieracheagricola, ingrassatasulle terreusurpate ai
demanicomunali, simostraincapacedi porsi alla testa
delmotocontadino; conessa, anzi, entra in diretto
conflitto',sicchèquesto,puòessere'facilmentecaptato
dallareazione politica, assolutistica .e semi-feudale.
Cosìsi sviluppa,nel '99epoi nel '21enel '48, il dramma
delRisorgimento italiano, nel quale si vedono lemasse
contadineprive di unadirezioneprogressiva,daparte
delenuoveclassi cittadine, porre delle rivendicazioni
















