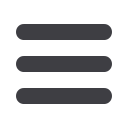
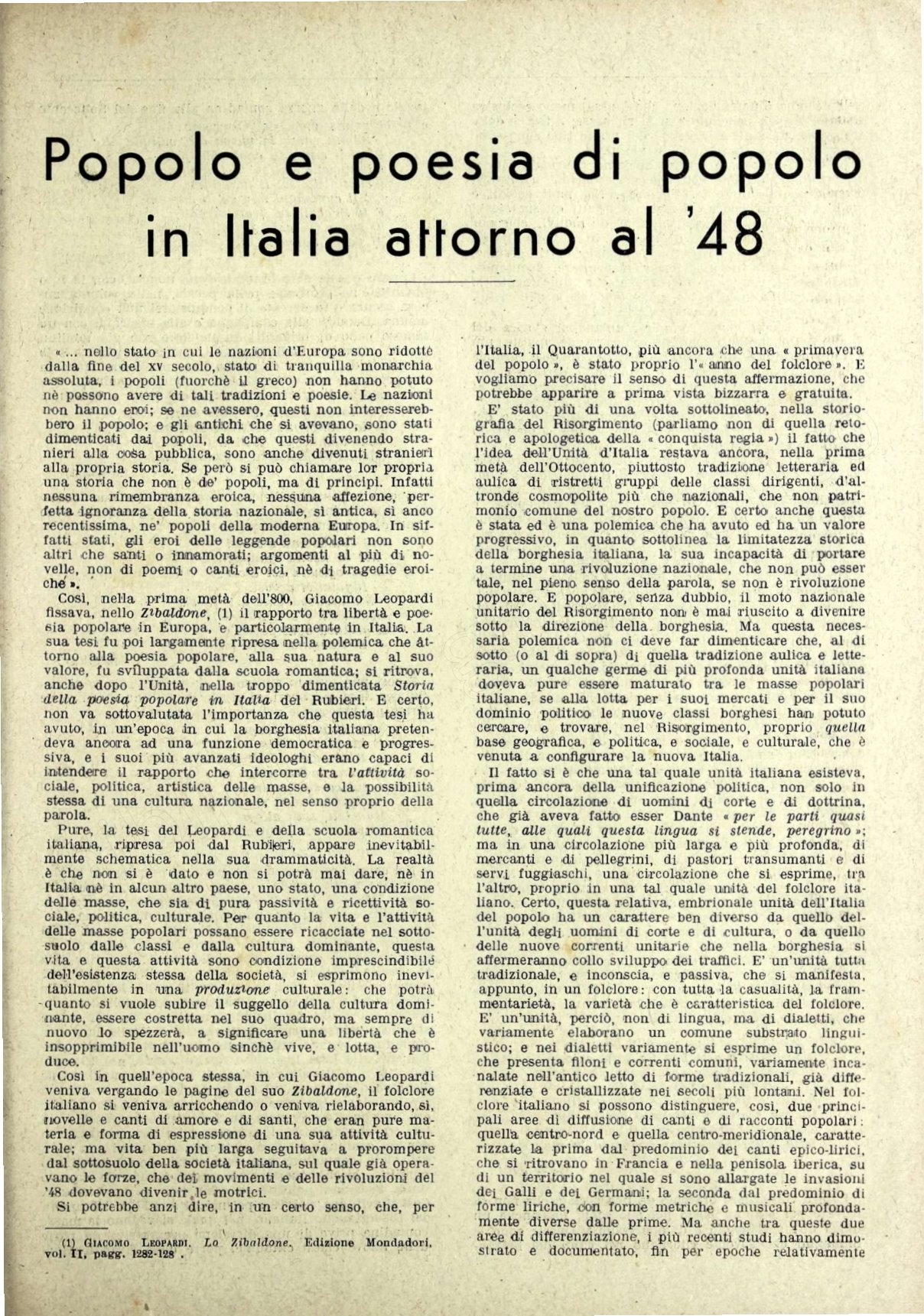
Popoloepoesiadipopolo
inItaliaattornoal '48
« ... nellostato in cui lenazionid'Europasonoridotte
dalla fine del xvsecolo, stato di tranquillamonarchia
assoluta, i popoli (fuorchè i l greco) nonhannopotuto
nèpossoinoavere di tali tradizioni epoesie.Lenazioni
nonhannoeroi; seneavessero,questinoninteressereb-
bero il popolo; e gli antichi che si avevano,sonostati
dimenticati dai popoli, da chequestidivenendostra-
nieri alla,coSapubblica,sonoanchedivenuti stranieri
allapropriastoria.Seperò si puòchiamare lor propria
unastoriachenonède' popoli,ma di principi. Infatti
nessunarimembranzaeroica, nessunaaffezione, •per-
fettaignoranzadellastorianazionale, sl antica, sì anco
recentissima, ne' popoli dellamodernaEuropa. In sif-
fatti stati, gli eroi delle leggendepopolari non sono
altri che santi o innamorati; argomenti al più di no-
velle,non di poemi o canti eroici, nè di tragedieeroi-
chili». •Così,nella primametàdell'800,GiacomoLeopardi
fissava,nello
Zibaldone,(1)
il rapporto tra libertàepoe-
siapopolare in Europa,«eparticolarmente in Italia. La
suatesi fupoi largamenteripresanellapolemicacheti,t-
torno alla poesiapopolare, alla sua natura e al suo
valore, fu sviluppatadallascuolaromantica; si ritrova,
anchedopo l'Unità, nella troppo dimenticata
Storia
dellapoeslapopolare in Italia del Rulpieri. E certo,
nonva sottovalutata l'importanza chequesta tesi ha
avuto, in un'epoca in cui la borghesia italianapreten-
devaancora ad una funzionedemocratica e progres-
siva, e i suoi più avanzati ideologhi eranocapaci di
intendere i l rapporto che intercorre tra
l'attività
so-
ciale, politica, artistica dellerpa,sse, e la possibilit[t.
stessadi unaculturanazionale, nelsensopropriodella
parola. Pure, la tesi del Leopardi e della scuolaromantica
italiana, ripresa poi dal Rublieri, .appare inevita.bil-
menteschematica nella sua drammaticità. La realtà
èchenon si è 'dato e non si potràmai dare, nè in
Italianè in alcunaltropaese,unostato,unacondizione
dellemasse,che sia di purapassività e ricettività so-
ciale,politica, culturale. Per quanto la vita e l'attività
déllemassepopolaripossanoesserericacciatenel sotto-
suolodalle classi e dalla culturadominante,questa
vita e questa attività sonooandizioneimprescindibilé
del'esistenzastessadellasocietà, si esprimono inevi-
tabilmente in una
produzione
culturale: che potrà
-quanto si vuolesubire i l suggellodella culturadomi-
nante,esserecostretta nel suoquadro, masempre di
nuovo lo spezzerà, a significare una libertà che è
insopprimibilenell'uomosinchè vive, e• lotta, e pro-
duce.Così in quell'epocastessa, in cuiGiacomoLeopardi
venivavergando lepaginedel suo
Zibaldone,
il folclore
italiano si venivaarricchendoovenivarielaborando,sì,
fflovele
ecanti di amoree di santi, cheeranpurema-
teria e forma di espressione di unasua attività cultu-
rale; ma vita ben più larga seguitava a prorompere
dalsottosuolodellasocietàitaliana, sul qualegià,opera-
vanole forze,chedei,movimenti edelle rivoluzioni del
'48dovevanodivenir,lemotrici.
Sipotrebbe anzi dire, in un certosenso, che, per
(1)GIACOMOLEOPARDI.
Lo Zibaldone.
EdizioneMondadori,
vol. ILPagg.1282-128.
l'Italia, il Quarantotto, piùancoracheunaaprimavera
delpopolo», è stato proprio l'«annodel folclore». E
vogliamoprecisare il sensodi questaaffermazione,che
potrebbeapparire a prima vista bizzarra e gratuita.
E' stato più di una volta sottolineata, nella storio-
grafiadelRisorgimento(parliamonon di quella reto-
ricaeapologeticadella«conquistaregia») i l fattoche
l'ideadell'Unità d'Italia restavaancora, nella prima
metàdell'Ottocento, piuttosto tradizione letteraria ed
aulica di ristretti gruppi delle classi •dirigenti, d'al-
trondecosmopolite più che nazionali, che non patri-
moniocomunedel nostropopolo. E certoanchequesta
èstataedèunapolemicachehaavutoedhaunvalore
progressivo, in quantosottolinea la limitatezzastorica
dellaborghesia italiana, la sua incapacità di portare
atermineunarivoluzionenazionale,chenonpuòesser
tale, nel pienosensodellaparola,senonè rivoluzione
popolare. E popolare,senzadubbio, i l motonazionale
unitariodelRisorgimentononèmai riuscito a divenire
sotto la direzione dellaborghesia.. Ma questaneces-
sariapolemicanon ci deve far dimenticareche, al di
sotto(o al di sopra) di quella tradizioneaulicae lette-
raria, unqualchegermedi piùprofondaunità italiana
dovevapureesserematurato tra lemassepopolari
italiane, se alla lotta per i suoi mercati e per i l suo
dominiopolitico le nuoveclassi borghesi han potuto
cercare, e trovare, nel Risorgimento, proprio
quella
basegeografica,epolitica, e sociale, e culturale, cheè
venutaa configurare la nuova Italia.
•
Il fatto si ècheuna tal qualeunità italianaesisteva,
primaancora della unificazione 'politica, non solo in
quellacircolazione di uomini di corte e di dottrina,
chegià aveva fatto esserDante «
per le parti quasi
tutte, alle quali questa. lingua si stende,peregrino»;
ma in una circolazione più larga e più profonda, di
mercanti e di pellegrini, di pastori transumanti e di
servi fuggiaschi, una -circolazioneche si esprime, tra
l'altro., proprio in una tal qualeunità del folclore ita-
liano.Certo,questarelativa,embrionaleunità dell'Italia
delpopoloha un caratterebendiverso da quellodel-
l'unità degli uomini di corte e di cultura, o daquello
delenuove correnti unitarie che nella borghesia si
afermerannocollosviluppodei traffici. E' un'unità tutta
tradizionale, e inconscia, e passiva, che si manifesta,
appunto, in un folclore: con tutta lacasualità, la frani-
mentarietà, la varietàche è caratteristicadel folclore.
E'un'unità, perciò, non di lingua, ma di dialetti, che
variamenteelaborano un comunesubstrato lingui-
stico; e nei dialetti variamente si esprimeun folclore,
chepresenta filoni ecorrenti comuni,variamente inca-
nalatenell'antico letto di forme tradizionali, già diffe-
renziatee cristallizzate nei secoli più lontani. Nel fol-
clore'italiano si possonodistinguere, così, due princi-
paliaree di diffusione di canti e di racconti popolari:
quel'a.centro-norde quellacentro-meridionale,caratte-
rizzateLaprima dal predominio dei canti epico-lirici,
chesi 'ritrovano in •Franciae nellapenisolaiberica, su
di un territorio nel quale si sonoallargate le invasioni
deiGalli e deiGermani; la secondadal predominio di
formeliriche, cionformemetricheemusicali profonda-
mentediversedalle prime. Maanche tra questedue
areedi differenziazione, i più recenti studihannodimo-
strato e documentato, fin per epocherelativamente
















