
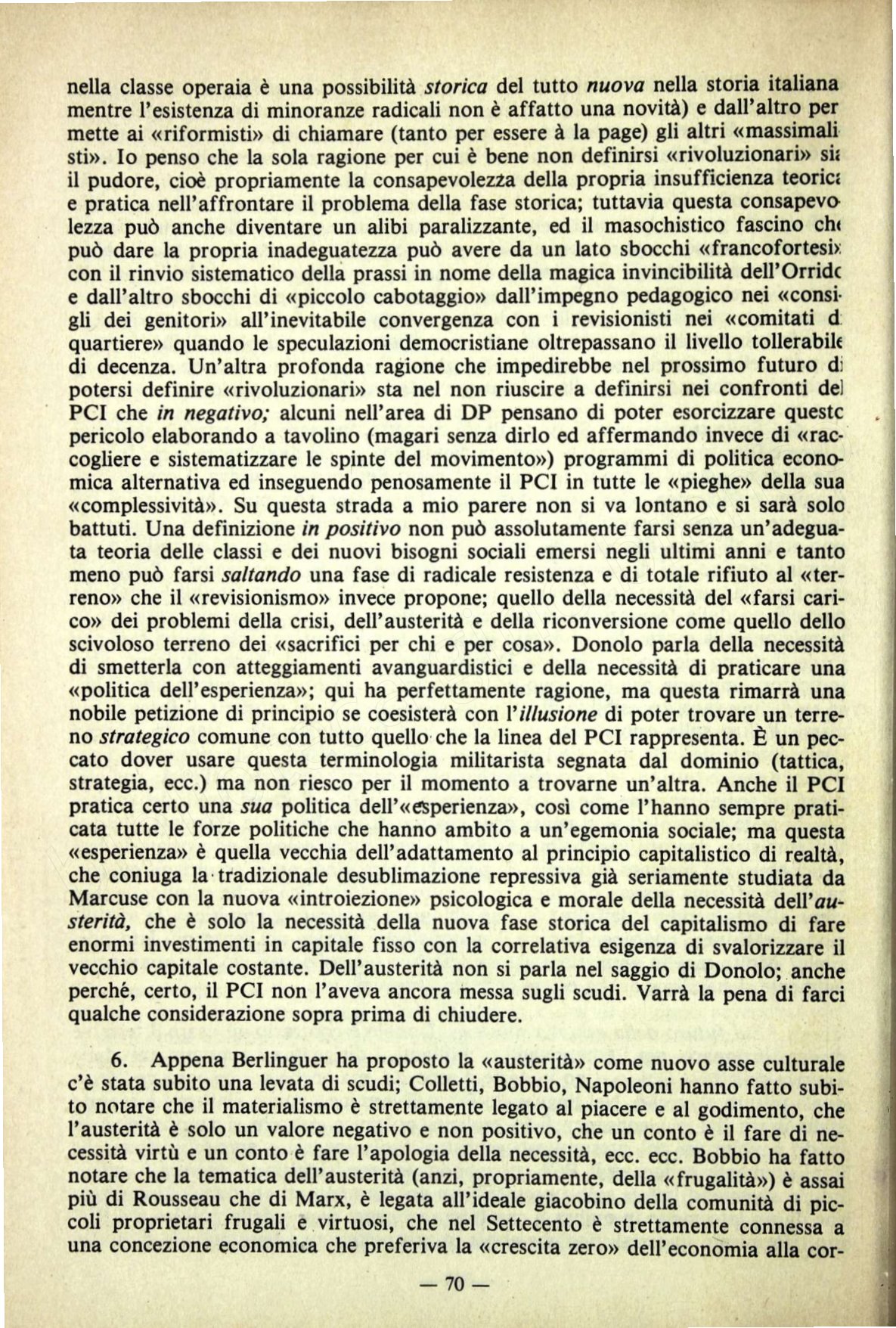
nellaclasse operaia è una possibilità
storica
del tutto
nuova
nella storia italiana
mentre l'esistenza di minoranze radicali non è affatto una novità) e dall'altro per
mette ai «riformisti» di chiamare (tanto per essere à la page) gli altri «massimali
sti». Io pensoche la sola ragione per cui è bene non definirsi «rivoluzionari» sia
il pudore, cioè propriamente la consapevolezza della propria insufficienza teorica
epratica nell'affrontare il problema della fase storica; tuttavia questaconsapevc>
lezza può anche diventare un alibi paralizzante, ed il masochistico fascino clu
puòdare la propria inadeguatezza può avere da un lato sbocchi «francofortesix
con il rinvio sistematico della prassi in nome dellamagica invincibilità dell'Orridc
edall'altro sbocchi di «piccolo cabotaggio» dall'impegno pedagogico nei «consi-
gli dei genitori» all'inevitabile convergenza con i revisionisti nei «comitati d
quartiere» quando le speculazioni democristiane oltrepassano il livello tollerabilc
di decenza. Un'altra profonda ragione che impedirebbe nel prossimo futuro d:
potersi definire «rivoluzionari» sta nel non riuscire a definirsi nei confronti del
PCI che
in negativo;
alcuni nell'area di DP pensano di poter esorcizzare questc
pericolo elaborando a tavolino (magari senza dirlo ed affermando invece di «rac-
cogliere e sistematizzare le spinte del movimento») programmi di politica econo-
mica alternativa ed inseguendopenosamente il PCI in tutte le «pieghe» della sua
«complessività». Su questa strada a mio parere non si va lontano e si sarà solo
battuti. Una definizione
in positivo
non puòassolutamente farsi senza un'adegua-
ta teoria delle classi e dei nuovi bisogni sociali emersi negli ultimi anni e tanto
menopuò farsi
saltando
una fase di radicale resistenza e di totale rifiuto al «ter-
reno»che il «revisionismo» invece propone; quello della necessità del «farsi cari-
co» dei problemi della crisi, dell'austerità e della riconversione come quello dello
scivoloso terreno dei «sacrifici per chi e per cosa». Donolo parla della necessità
di smetterla con atteggiamenti avanguardistici e della necessità di praticare una
«politica dell'esperienza»; qui ha perfettamente ragione, ma questa rimarrà una
nobile petizione di principio secoesisterà con
l'illusione
di poter trovare un terre-
no
strategico
comunecon tutto quello che la linea del PCI rappresenta. È un pec-
cato dover usare questa terminologia militarista segnata dal dominio (tattica,
strategia, ecc.) ma non riesco per il momento a trovarne un'altra. Anche il PCI
pratica certo una
sua
politica dell'«esperienza», così come l'hanno sempre prati-
cata tutte le forze politiche che hanno ambito a un'egemonia sociale, ma questa
«esperienza» è quella vecchia dell'adattamento al principio capitalistico di realtà,
checoniuga la. tradizionale desublimazione repressiva già seriamente studiata da
Marcuse con la nuova «introiezione» psicologica e morale della necessità
dell'au-
sterità,
che è solo la necessità della nuova fase storica del capitalismo di fare
enormi investimenti in capitale fisso con la correlativa esigenza di svalorizzare il
vecchiocapitale costante. Dell'austerità non si parla nel saggio di Donolo; anche
perché, certo, il PCI non l'aveva ancoramessasugli scudi. Varrà la pena di farci
qualcheconsiderazionesopra prima di chiudere.
6. Appena Berlinguer ha proposto la «austerità» come nuovoasseculturale
c'è stata subito una levata di scudi; Colletti, Bobbio, Napoleoni hanno fatto subi-
to notare che il materialismo è strettamente legato al piacere e al godimento, che
l'austerità è solo un valore negativo e non positivo, che un conto è il fare di ne-
cessità virtù e un conto è fare l'apologia della necessità, ecc. ecc. Bobbio ha fatto
notareche la tematica dell'austerità (anzi, propriamente, della «frugalità») è assai
più di Rousseauche di Marx, è legata all'ideale giacobino della comunità di pic-
coli proprietari frugali e virtuosi, che nel Settecento è strettamente connessa a
unaconcezioneeconomicache preferiva la «crescita zero» dell'economia alla cor-
70
















