
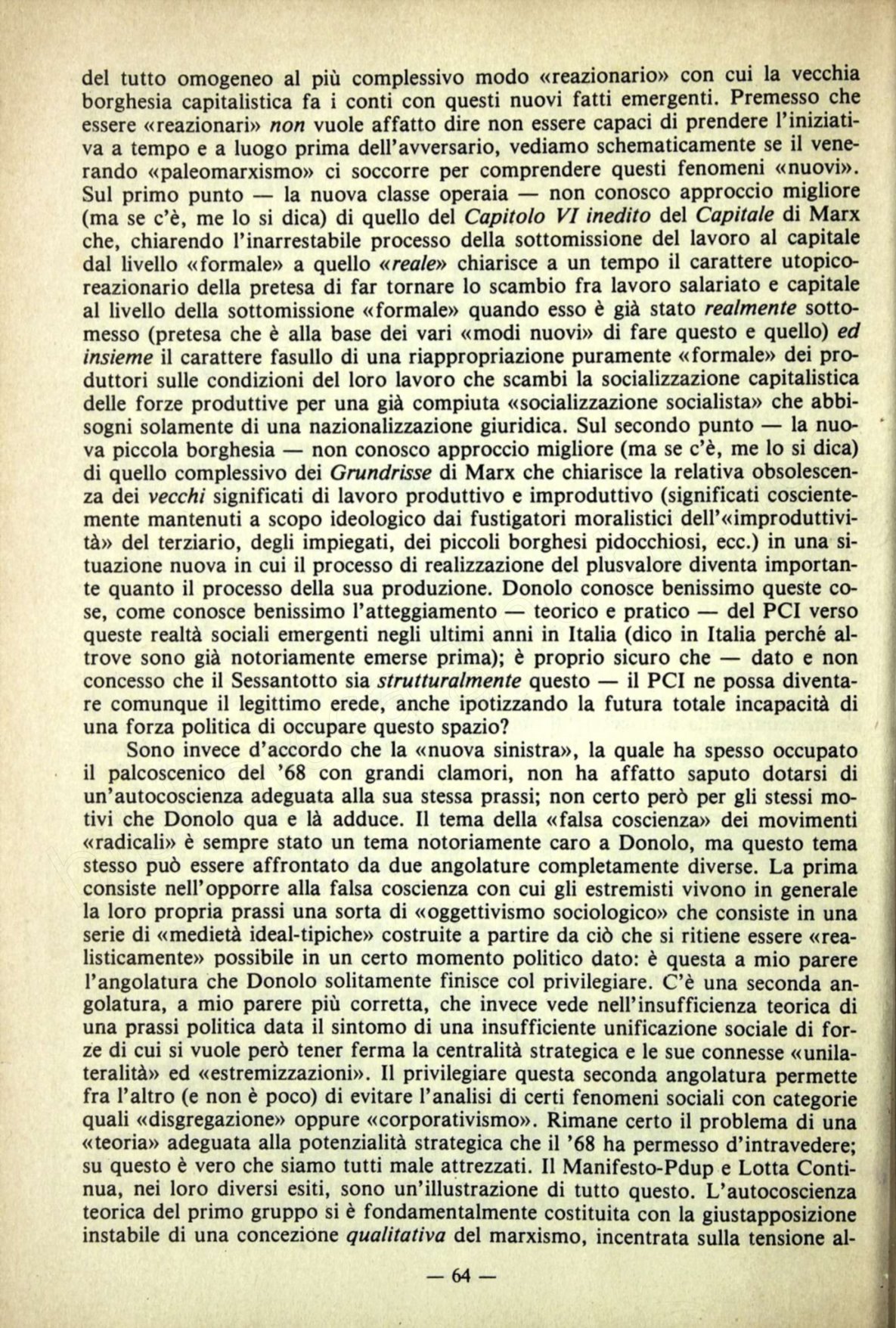
del tutto omogeneo al più complessivomodo «reazionario» con cui la vecchia
borghesia capitalistica fa i conti con questi nuovi fatti emergenti. Premesso che
essere«reazionari»
non
vuole affatto dire nonesserecapaci di prendere l'iniziati-
va a tempo e a luogo prima dell'avversario, vediamo schematicamentese il vene-
rando «paleomarxismo» ci soccorre per comprendere questi fenomeni «nuovi».
Sul primo punto — la nuova classe operaia — non conosco approccio migliore
(ma se c'è, me lo si dica) di quello del
Capitolo VI inedito
del
Capitale
di Marx
che, chiarendo l'inarrestabile processo della sottomissione del lavoro al capitale
dal livello «formale» a quello
«reale»
chiarisce a un tempo il carattere utopico-
reazionario della pretesa di far tornare lo scambio fra lavoro salariato e capitale
al livello della sottomissione «formale» quandoesso è già stato
realmente
sotto-
messo(pretesa che è alla base dei vari «modi nuovi» di fare questo e quello)
ed
insieme
il carattere fasullo di una riappropriazione puramente «formale» dei pro-
duttori sulle condizioni del loro lavoro che scambi la socializzazione capitalistica
delle forze produttive per una già compiuta «socializzazione socialista» che abbi-
sognisolamente di una nazionalizzazione giuridica. Sul secondo punto — la nuo-
vapiccola borghesia— non conoscoapprocciomigliore (ma se c'è, me lo si dica)
di quello complessivo dei
Grundrisse
di Marx che chiarisce la relativa obsolescen-
za dei
vecchi
significati di lavoro produttivo e improduttivo (significati cosciente-
mentemantenuti a scopo ideologico dai fustigatori moralistici dell'«improduttivi-
tà» del terziario, degli impiegati, dei piccoli borghesi pidocchiosi, ecc.) in una si-
tuazionenuova in cui il processo di realizzazione del plusvalore diventa importan-
tequanto il processo della sua produzione. Donolo conoscebenissimoqueste co-
se,comeconoscebenissimo l'atteggiamento — teorico e pratico — del PCI verso
queste realtà sociali emergenti negli ultimi anni in Italia (dico in Italia perché al-
trove sono già notoriamente emerse prima); è proprio sicuro che — dato e non
concessoche il Sessantotto sia
strutturalmente
questo — il PCI ne possadiventa-
recomunque il legittimo erede, anche ipotizzando la futura totale incapacità di
una forza politica di occuparequestospazio?
Sonoinvece d'accordo che la «nuova sinistra», la quale ha spessooccupato
il palcoscenico del '68 con grandi clamori, non ha affatto saputo dotarsi di
un'autocoscienzaadeguata alla suastessaprassi; non certo però per gli stessi mo-
tivi che Donolo qua e là adduce. I l tema della «falsa coscienza» dei movimenti
«radicali» è sempre stato un tema notoriamente caro a Donolo, ma questo tema
stessopuòessere affrontato da due angolature completamente diverse. La prima
consistenell'opporre alla falsa coscienza con cui gli estremisti vivono in generale
la loro propria prassi una sorta di «oggettivismosociologico» che consiste in una
serie di «medietà ideal-tipiche» costruite a partire da ciò che si ritiene essere«rea-
listicamente»possibile in un certomomento politico dato: è questa a mio parere
l'angolatura che Donolo solitamente finisce col privilegiare. C'è una seconda an-
golatura, a mio parere più corretta, che invece vede nell'insufficienza teorica di
unaprassi politica data il sintomo di una insufficiente unificazione sociale di for-
zedi cui si vuole però tener ferma la centralità strategica e le sueconnesse «unila-
teralità» ed «estremizzazioni». I l privilegiare questaseconda angolatura permette
fra l'altro (e non è poco) di evitare l'analisi di certi fenomeni sociali con categorie
quali «disgregazione» oppure «corporativismo». Rimane certo il problema di una
«teoria» adeguata alla potenzialità strategicache il '68 ha permessod'intravedere;
suquesto è vero chesiamo tutti male attrezzati. Il Manifesto-Pdup e Lotta Conti-
nua, nei loro diversi esiti, sono un'illustrazione di tutto questo. L'autocoscienza
teorica del primo gruppo si è fondamentalmente costituita con la giustapposizione
instabile di una concezione
qualitativa
del marxismo, incentrata sulla tensione al-
- 6 4
















