
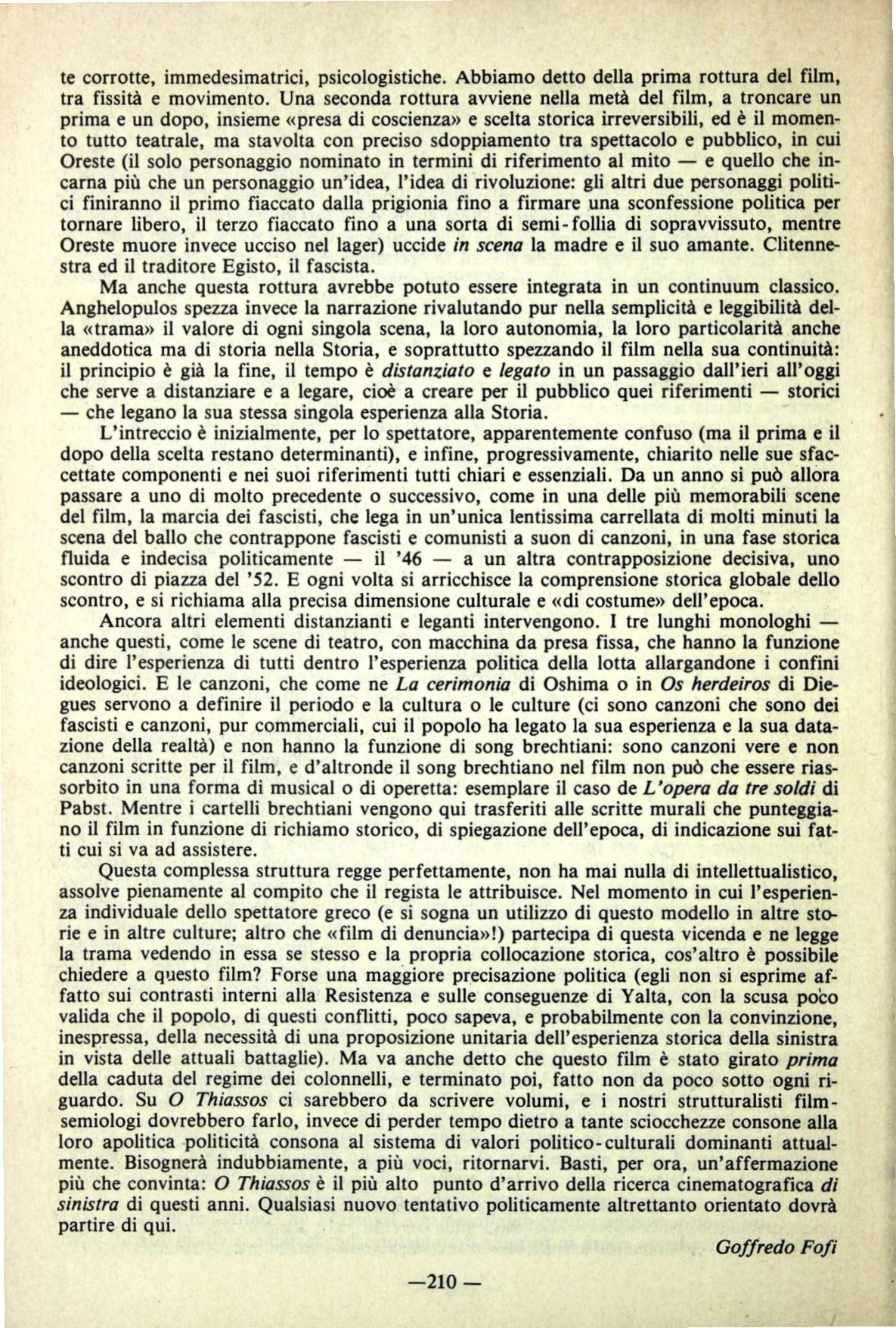
tecorrotte, immedesimatrici, psicologistiche. Abbiamo detto della prima rottura del film,
tra fissità e movimento. Una seconda rottura avviene nella metà del film, a troncare un
prima e un dopo, insieme«presa di coscienza» e scelta storica irreversibili, ed è il momen-
to tutto teatrale, ma stavolta con precisosdoppiamento tra spettacolo e pubblico, in cui
Oreste (il solopersonaggionominato in termini di riferimento al mito — e quello che in-
carna più che un personaggio un'idea, l'idea di rivoluzione: gli altri duepersonaggi politi-
ci finiranno il primo fiaccato dalla prigionia fino a firmare una sconfessione politica per
tornare libero, il terzo fiaccato fino a una sorta di semi- follia di sopravvissuto, mentre
Orestemuore inveceucciso nel lager) uccide
in scena
la madre e il suo amante. Clitenne-
straed il traditore Egisto, il fascista.
Ma anche questa rottura avrebbe potuto essere integrata in un continuumclassico.
Anghelopulosspezza invece la narrazione rivalutando pur nella semplicità e leggibilità del-
la «trama» il valore di ogni singola scena, la loro autonomia, la loro particolarità anche
aneddoticama di storia nella Storia, e soprattuttospezzando il film nella sua continuità:
il principio è già la fine, il tempo è
distanziato
e
legato
in un passaggio dall'ieri all'oggi
cheserve a distanziare e a legare, cioè a creare per il pubblico quei riferimenti — storici
—che legano la suastessasingolaesperienza alla Storia.
L'intreccio è inizialmente, per lo spettatore, apparentementeconfuso (ma il prima e il
dopodella scelta restano determinanti), e infine, progressivamente, chiarito nellesuesfac-
cettatecomponenti e nei suoi riferimenti tutti chiari e essenziali. Da un anno si può allora
passare a uno di molto precedente o successivo, come in una delle più memorabili scene
del film, la marcia dei fascisti, che lega in un'unica lentissima carrellata di molti minuti la
scenadel ballo checontrappone fascisti e comunisti a suon di canzoni, in una fase storica
fluida e indecisa politicamente — i l '46 — a un altra contrapposizione decisiva, uno
scontro di piazza del '52. E ogni volta si arricchisce la comprensionestorica globale dello
scontro, e si richiama alla precisadimensione culturale e «di costume»dell'epoca.
Ancora altri elementi distanzianti e leganti intervengono. I tre lunghi monologhi
anchequesti, come le scene di teatro, conmacchina da presa fissa, che hanno la funzione
di dire l'esperienza di tutti dentro l'esperienza politica della lotta allargandone i confini
ideologici. E le canzoni, che come ne
La cerimonia
di Oshima o in
Os herdeiros
di Die-
guesservono a definire il periodo e la cultura o le culture (ci sono canzoni che sono dei
fascisti e canzoni, pur commerciali, cui il popolo ha legato la suaesperienzae la sua data-
zione della realtà) e non hanno la funzione di song brechtiani: sono canzoni vere e non
canzoni scritte per il film, e d'altronde il songbrechtiano nel film non puòcheessere rias-
sorbito in una forma di musical o di operetta: esemplare il casode
L'opera da tre so/di
di
Pabst. Mentre i cartelli brechtiani vengono qui trasferiti alle scritte murali che punteggia-
no il film in funzione di richiamo storico, di spiegazionedell'epoca, di indicazione sui fat-
ti cui si va adassistere.
Questacomplessastruttura reggeperfettamente, non ha mai nulla di intellettualistico,
assolvepienamente al compito che il regista le attribuisce. Nel momento in cui l'esperien-
za individuale dello spettatoregreco (e si sogna un utilizzo di questomodello in altre sto-
rie e in altre culture; altro che «film di denuncia»!) partecipa di questavicenda e ne legge
la trama vedendo in essasestesso e la propria collocazione storica, cos'altro è possibile
chiedere a questo film? Forse unamaggioreprecisazione politica (egli non si esprime af-
fatto sui contrasti interni alla Resistenza e sulleconseguenze di Yalta, con la scusapota)
validache il popolo, di questi conflitti, pocosapeva, e probabilmente con la convinzione,
inespressa, della necessità di una proposizione unitaria dell'esperienza storica della sinistra
in vista delle attuali battaglie). Ma va anche detto che questo film è stato girato
prima
della caduta del regime dei colonnelli, e terminato poi, fatto non da poco sotto ogni ri-
guardo. Su O
Thiassos
ci sarebbero da scrivere volumi, e i nostri strutturalisti film -
semiologi dovrebbero farlo, invece di perder tempo dietro a tantesciocchezzeconsone alla
loro apolitica politicità consona al sistema di valori politico- culturali dominanti attual-
mente.Bisognerà indubbiamente, a più voci, ritornarvi. Basti, per ora, un'affermazione
piùche convinta: O
Thiassos
è il più alto punto d'arrivo della ricerca cinematografica
di
sinistra
di questi anni. Qualsiasi nuovo tentativo politicamente altrettanto orientato dovrà
partire di qui.
Goffredo Fofi
















