
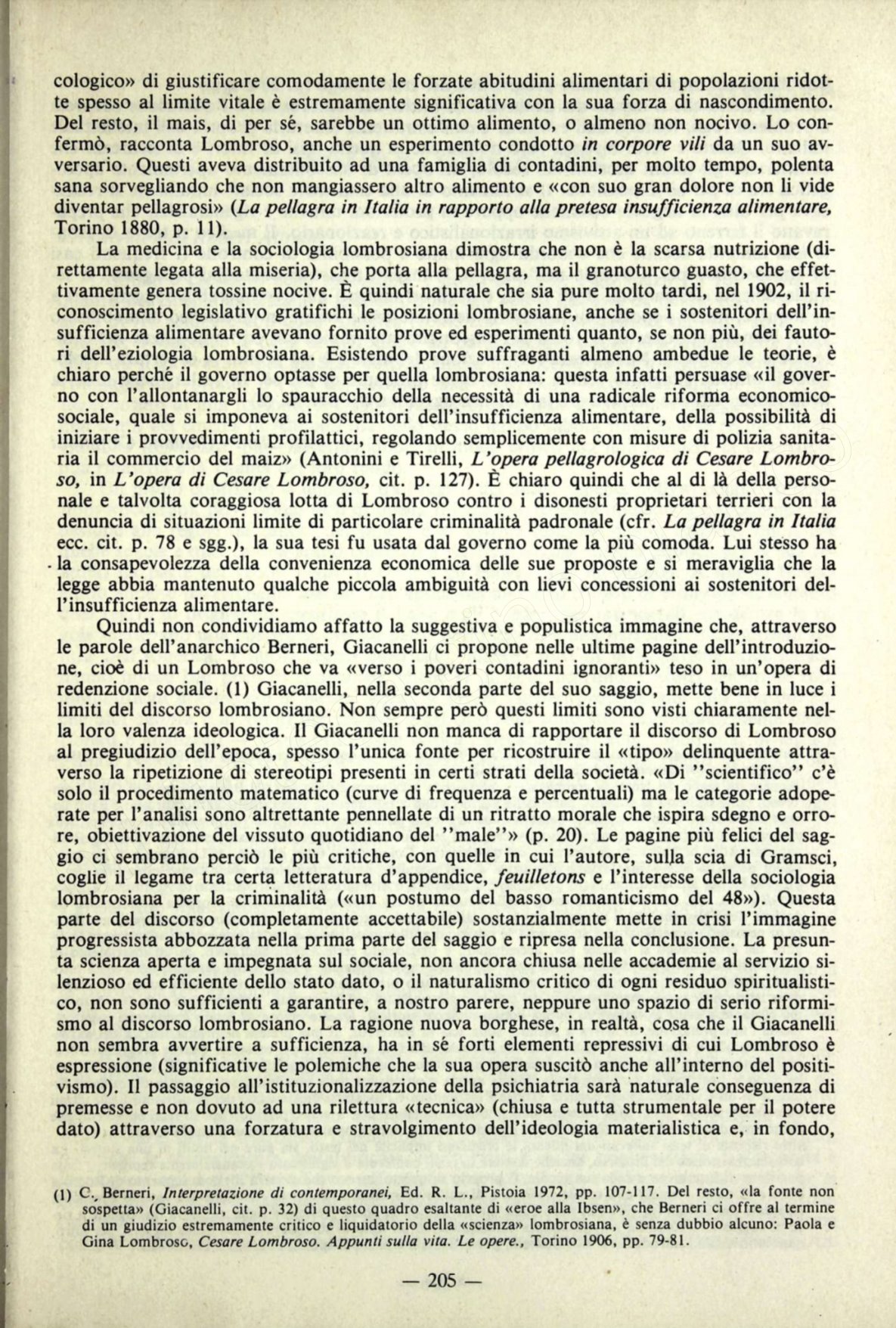
cologico» di giustificare comodamente le forzate abitudini alimentari di popolazioni ridot-
tespesso al limite vitale è estremamente significativa con la sua forza di nascondimento.
Del resto, il mais, di per sé, sarebbe un ottimo alimento, o almeno non nocivo. Lo con-
fermò, racconta Lombroso, anche un esperimento condotto
in corpore vili
da un suo av-
versario. Questi aveva distribuito ad una famiglia di contadini, per molto tempo, polenta
sanasorvegliando che nonmangiassero altro alimento e «con suo gran dolore non li vide
diventar pellagrosi» (La pellagra in Italia in rapporto alla pretesa insufficienza alimentare,
Torino 1880, p. 11).
La medicina e la sociologia lombrosiana dimostra che non è la scarsa nutrizione (di-
rettamente legata alla miseria), che porta alla pellagra, ma il granoturco guasto, che effet-
tivamente genera tossine nocive. E quindi naturale che sia pure molto tardi, nel 1902, il ri-
conoscimento legislativo gratifichi le posizioni lombrosiane, anche se i sostenitori dell'in-
sufficienza alimentare avevano fornito prove ed esperimenti quanto, se non più, dei fauto-
ri dell'eziologia lombrosiana. Esistendo prove suffraganti almeno ambedue le teorie, è
chiaro perché il governo optasse per quella lombrosiana: questa infatti persuase «il gover-
no con l'allontanargli lo spauracchio della necessità di una radicale riforma economico-
sociale, quale si imponeva ai sostenitori dell'insufficienza alimentare, della possibilità di
iniziare i provvedimenti profilattici, regolando semplicemente conmisure di polizia sanita-
ria il commercio del maiz» (Antonini e Tirelli,
L'opera pellagrologica di Cesare Lombro-
so, in L'opera di Cesare Lombroso,
cit. p. 127). È chiaro quindi che al di là della perso-
nale e talvolta coraggiosa lotta di Lombroso contro i disonesti proprietari terrieri con la
denuncia di situazioni limite di particolare criminalità padronale (cfr.
La pellagra in Italia
ecc.
cit. p. 78 e sgg.), la sua tesi fu usata dal governo come la più comoda. Lui stesso ha
-la consapevolezza della convenienza economica delle sue proposte e si meraviglia che la
legge abbia mantenuto qualche piccola ambiguità con lievi concessioni ai sostenitori del-
l'insufficienza alimentare.
Quindi non condividiamo affatto la suggestiva e populistica immagine che, attraverso
le parole dell'anarchico Berneri, Giacanelli ci propone nelle ultime pagine dell'introduzio-
ne, cioè di un Lombroso che va «verso i poveri contadini ignoranti» teso in un'opera di
redenzione sociale. (1) Giacanelli, nella seconda parte del suo saggio, mette bene in luce i
limiti del discorso lombrosiano. Non sempre però questi limiti sono visti chiaramente nel-
la loro valenza ideologica. I l Giacanelli non manca di rapportare il discorso di Lombroso
al pregiudizio dell'epoca, spesso l'unica fonte per ricostruire il «tipo» delinquente attra-
verso la ripetizione di stereotipi presenti in certi strati della società. «Di "scientifico" c'è
solo il procedimentomatematico (curve di frequenza e percentuali) ma le categorie adope-
rate per l'analisi sono altrettante pennellate di un ritratto morale che ispira sdegno e orro-
re, obiettivazione del vissuto quotidiano del "male"» (p. 20). Le pagine più felici del sag-
gio ci sembrano perciò le più critiche, con quelle in cui l'autore, sulla scia di Gramsci,
coglie il legame tra certa letteratura d'appendice,
feuilletons
e l'interesse della sociologia
lombrosiana per la criminalità («un postumo del basso romanticismo del 48»). Questa
parte del discorso (completamente accettabile) sostanzialmente mette in crisi l'immagine
progressista abbozzata nella prima parte del saggio e ripresa nella conclusione. La presun-
ta scienza aperta e impegnata sul sociale, non ancora chiusa nelle accademie al servizio si-
lenzioso ed efficiente dello stato dato, o il naturalismo critico di ogni residuo spiritualisti-
co, non sono sufficienti a garantire, a nostro parere, neppure uno spazio di serio riformi-
smo al discorso lombrosiano. La ragione nuova borghese, in realtà, cosa che il Giacanelli
non sembra avvertire a sufficienza, ha in sé forti elementi repressivi di cui Lombroso è
espressione (significative le polemiche che la sua opera suscitò anche all'interno del positi-
vismo). I l passaggio all'istituzionalizzazione della psichiatria sarà naturale conseguenza di
premesse e non dovuto ad una rilettura «tecnica» (chiusa e tutta strumentale per il potere
dato) attraverso una forzatura e stravolgimento dell'ideologia materialistica e, in fondo,
(i) C. Berneri,
Interpretazione di contemporanei,
Ed. R. L. , Pistoia 1972, pp. 107-117. Del resto, «la fonte non
sospetta» (Giacanelli, cit. p. 32) di questo quadro esaltante di «eroe alla Ibsen», che Berneri ci offre al termine
di un giudizio estremamente critico e liquidatorio della «scienza» lombrosiana, è senza dubbio alcuno: Paola e
Gina Lombroso, Cesare Lombroso. Appunti sulla vita. Le opere., Torino 1906, pp. 79-81.
—205 —
















