
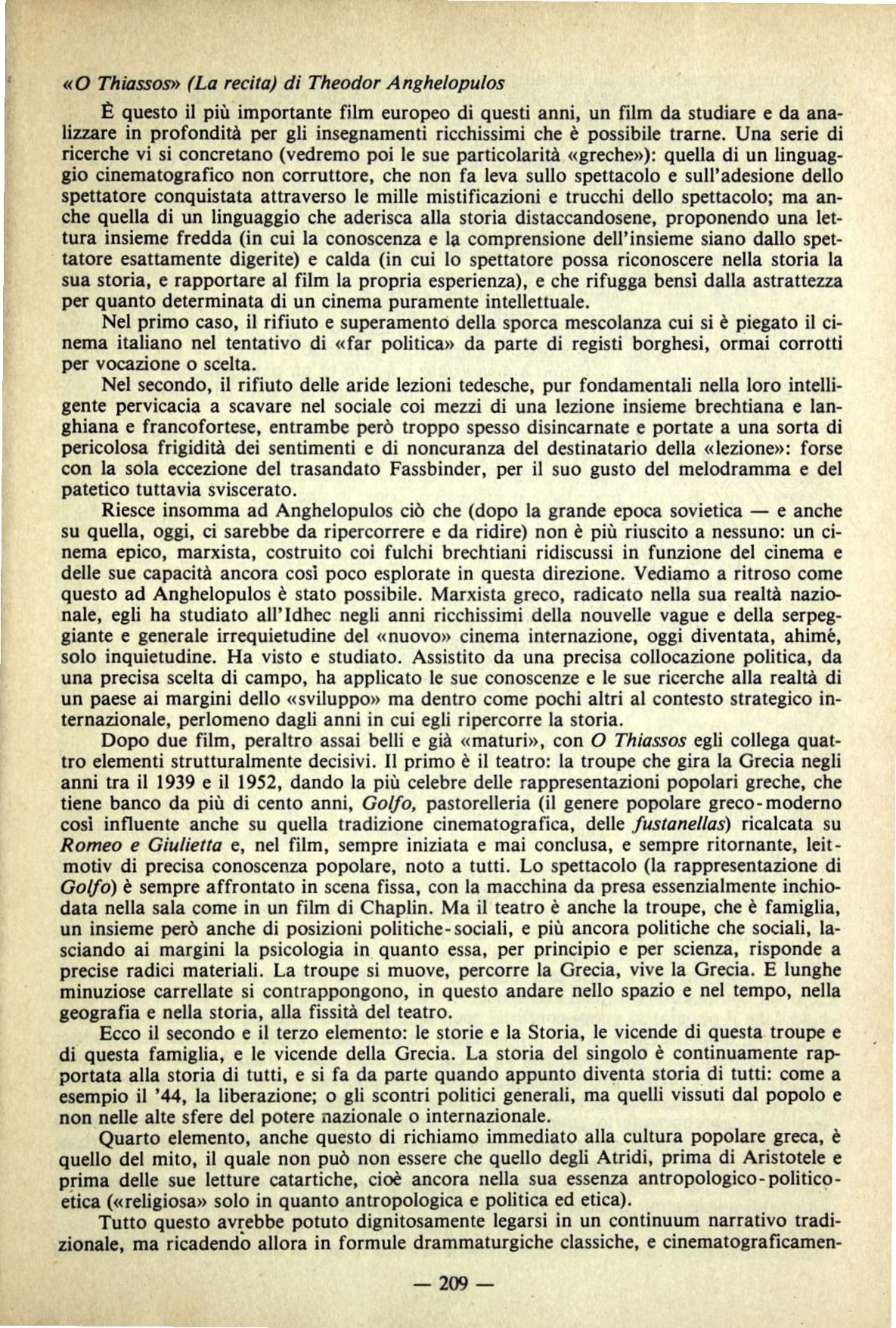
«O Thiassos» (La recita) di TheodorAnghelopulos
Equesto il più importante film europeo di questi anni, un film da studiare e da ana-
lizzare in profondità per gli insegnamenti ricchissimi che è possibile trarne. Una serie di
ricerche vi si concretano (vedremo poi le sue particolarità «greche»): quella di un linguag-
giocinematografico non corruttore, che non fa leva sullo spettacolo e sull'adesione dello
spettatoreconquistata attraverso le mille mistificazioni e trucchi dello spettacolo; ma an-
chequella di un linguaggio che aderisca alla storia distaccandosene, proponendo una let-
tura insieme fredda (in cui la conoscenza e la comprensionedell'insieme siano dallo spet-
tatore esattamente digerite) e calda (in cui lo spettatorepossa riconoscere nella storia la
suastoria, e rapportare al film la propria esperienza), e che rifugga bensì dalla astrattezza
per quanto determinata di un cinemapuramente intellettuale.
Nel primo caso, il rifiuto e superamentodella sporcamescolanza cui si è piegato il ci-
nema italiano nel tentativo di «far politica» da parte di registi borghesi, ormai corrotti
per vocazione o scelta.
Nel secondo, il rifiuto delle aride lezioni tedesche, pur fondamentali nella loro intelli-
gentepervicacia a scavare nel sociale coi mezzi di una lezione insieme brechtiana e lan-
ghiana e francofortese, entrambe però troppospessodisincarnate e portate a una sorta di
pericolosa frigidità dei sentimenti e di noncuranza del destinatario della «lezione»: forse
con la sola eccezione del trasandato Fassbinder, per il suo gusto del melodramma e del
patetico tuttavia sviscerato.
Riesceinsomma adAnghelopulos ciò che (dopo la grandeepocasovietica — e anche
suquella, oggi, ci sarebbe da ripercorrere e da ridire) non è più riuscito a nessuno: un ci-
nemaepico, marxista, costruito coi fulchi brechtiani ridiscussi in funzione del cinema e
dellesuecapacità ancora così poco esplorate in questa direzione. Vediamo a ritroso come
questo adAnghelopulos è stato possibile. Marxista greco, radicato nella sua realtà nazio-
nale, egli ha studiato all'Idhec negli anni ricchissimi della nouvelle vague e della serpeg-
giante e generale irrequietudine del «nuovo» cinema internazione, oggi diventata, ahimè,
solo inquietudine. Ha visto e studiato. Assistito da una precisa collocazione politica, da
unaprecisa scelta di campo, ha applicato le sueconoscenze e le sue ricerche alla realtà di
unpaese ai margini dello «sviluppo» ma dentrocomepochi altri al contestostrategico in-
ternazionale, perlomeno dagli anni in cui egli ripercorre la storia.
Dopo due film, peraltro assai belli e già «maturi», con O
Thiassos
egli collega quat-
tro elementi strutturalmente decisivi. Il primo è il teatro: la troupe che gira la Grecia negli
anni tra il 1939 e il 1952, dando la più celebre delle rappresentazioni popolari greche, che
tienebanco da più di cento anni,
Golfo,
pastorelleria (il genere popolare greco-moderno
così influente anche su quella tradizione cinematografica, delle
fustanellas) ricalcata
su
Romeo
e
Giulietta
e, nel film, sempre iniziata e mai conclusa, e sempre ritornante, leit-
motiv di precisaconoscenzapopolare, noto a tutti. Lo spettacolo (la rappresentazione di
Golfo)
è sempre affrontato in scena fissa, con la macchina da presaessenzialmente inchio-
data nella sala come in un film di Chaplin. Ma il teatro è anche la troupe, che è famiglia,
uninsieme però anche di posizioni politiche- sociali, e più ancora politiche che sociali, la-
sciando ai margini la psicologia in quanto essa, per principio e per scienza, risponde a
precise radici materiali. La troupe si muove, percorre la Grecia, vive la Grecia. E lunghe
minuziose carrellate si contrappongono, in questo andare nello spazio e nel tempo, nella
geografiae nella storia, alla fissità del teatro.
Ecco il secondo e il terzo elemento: le storie e la Storia, le vicende di questa troupe e
di questa famiglia, e le vicende della Grecia. La storia del singolo è continuamente rap-
portata alla storia di tutti, e si fa da parte quando appunto diventa storia di tutti: come a
esempio il '44, la liberazione; o gli scontri politici generali, ma quelli vissuti dal popolo e
nonnelle alte sfere del potere nazionale o internazionale.
Quarto elemento, anche questo di richiamo immediato alla cultura popolare greca, è
quello del mito, il quale non può nonessereche quello degli Atridi, prima di Aristotele e
prima delle sue letture catartiche, cioè ancora nella sua essenza antropologico- politico-
etica («religiosa» solo in quanto antropologica e politica ed etica).
Tutto questoavrebbe potuto dignitosamente legarsi in un continuumnarrativo tradi-
zionale, ma ricadendo allora in formule drammaturgicheclassiche, e cinematograficamen-
209—
















