
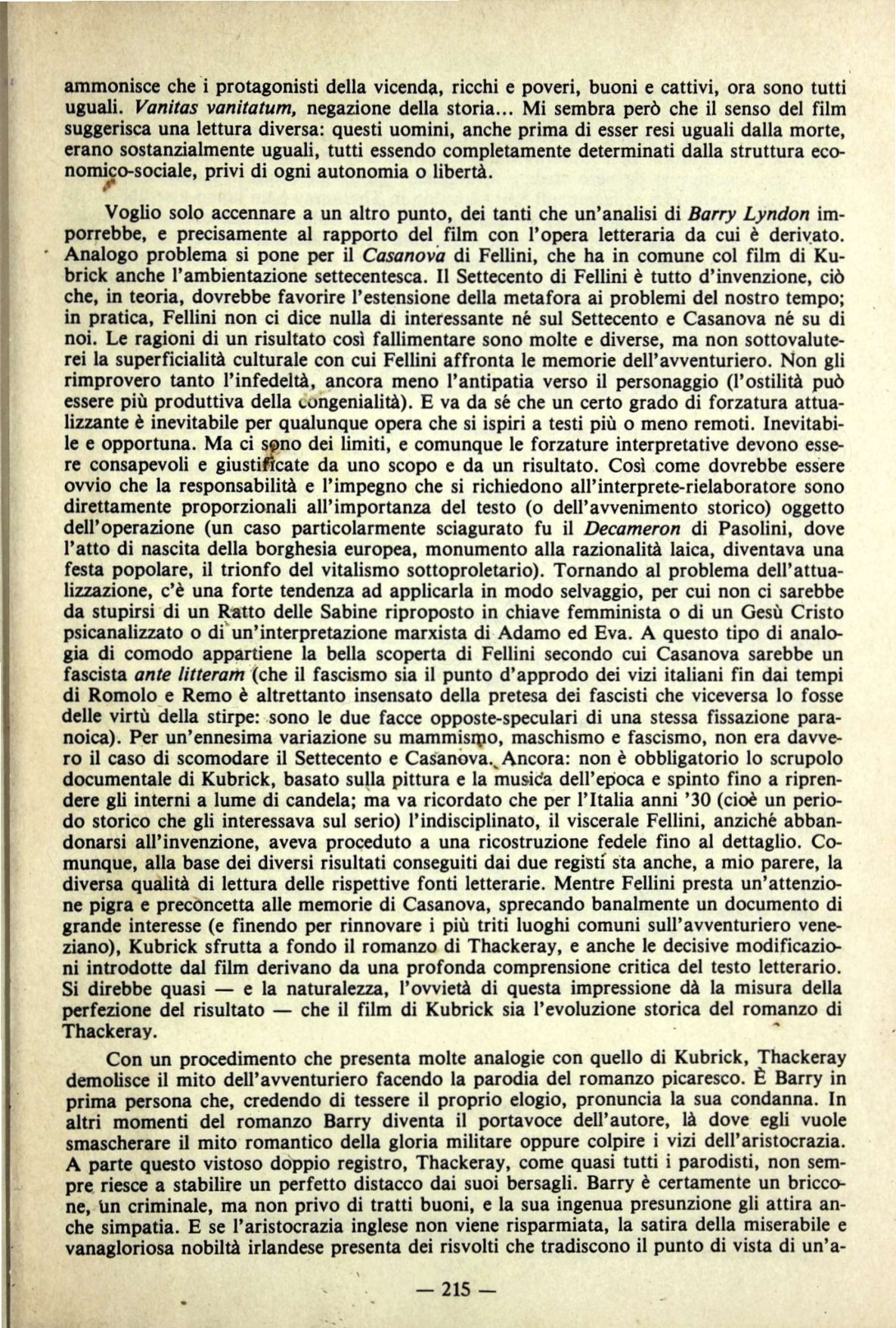
ammonisce che i protagonisti della vicenda, ricchi e poveri, buoni e cattivi, ora sono tutti
uguali.
Vanitas vanitatum,
negazione della storia... Mi sembra però che il senso del film
suggerisca una lettura diversa: questi uomini, anche prima di esser resi uguali dalla morte,
erano sostanzialmente uguali, tutti essendocompletamente determinati dalla struttura eco-
nomico-sociale, privi di ogni autonomia o libertà.
Voglio solo accennare a un altro punto, dei tanti che un'analisi di
Barry Lyndon
im-
porrebbe, e precisamente al rapporto del film con l'opera letteraria da cui è derivato.
Analogo problema si pone per il
Casanova
di Fellini, che ha in comune col film di Ku-
brick anche l'ambientazione settecentesca. I l Settecento di Fellini è tutto d'invenzione, ciò
che, in teoria, dovrebbe favorire l'estensione della metafora ai problemi del nostro tempo;
in pratica, Fellini non ci dice nulla di interessante né sul Settecento e Casanova né su di
noi. Le ragioni di un risultato così fallimentare sono molte e diverse, ma non sottovalute-
rei la superficialità culturale con cui Fellini affronta le memorie dell'avventuriero. Non gli
rimprovero tanto l'infedeltà, ancora meno l'antipatia verso il personaggio (l'ostilità può
esserepiù produttiva della congenialità). E va da sé che un certo grado di forzatura attua-
lizzante è inevitabile per qualunque opera che si ispiri a testi più o meno remoti. Inevitabi-
le e opportuna. Ma ci 59no dei limiti, e comunque le forzature interpretative devonoesse-
re consapevoli e giustificate da uno scopo e da un risultato. Così come dovrebbe essere
ovvio che la responsabilità e l'impegno che si richiedono all'interprete-rielaboratore sono
direttamente proporzionali all'importanza del testo (o dell'avvenimento storico) oggetto
dell'operazione (un caso particolarmente sciagurato fu i l
Decameron
di Pasolini, dove
l'atto di nascita della borghesia europea, monumento alla razionalità laica, diventava una
festa popolare, il trionfo del vitalismo sottoproletario). Tornando al problema dell'attua-
lizza.zione, c'è una forte tendenza ad applicarla in modo selvaggio, per cui non ci sarebbe
da stupirsi di un Ratto delle Sabine riproposto in chiave femminista o di un Gesù Cristo
psicanalizzato o di un'interpretazione marxista di Adamo ed Eva. A questo tipo di analo-
gia di comodo appartiene la bella scoperta di Fellini secondo cui Casanova sarebbe un
fascista
ante litteram
(che il fascismo sia il punto d'approdo dei vizi italiani fin dai tempi
di Romolo e Remo è altrettanto insensato della pretesa dei fascisti che viceversa lo fosse
delle virtù della stirpe: sono le due facce opposte-speculari di una stessa fissazione para-
noica). Per un'ennesima variazione sumammismo, maschismo e fascismo, non era davve-
ro il caso di scomodare il Settecento e Casanova., Ancora: non è obbligatorio lo scrupolo
documentale di Kubrick, basato sulla pittura e la musida dell'epoca e spinto fino a ripren-
dere gli interni a lume di candela; ma va ricordato che per l'Italia anni '30 (cioè un perio-
do storico che gli interessava sul serio) l'indisciplinato, il viscerale Fellini, anziché abban-
donarsi all'invenzione, aveva proceduto a una ricostruzione fedele fino al dettaglio. Co-
munque, alla base dei diversi risultati conseguiti dai due registi sta anche, a mio parere, la
diversa qualità di lettura delle rispettive fonti letterarie. Mentre Fellini presta un'attenzio-
nepigra e preconcetta alle memorie di Casanova, sprecando banalmente un documento di
grande interesse (e finendo per rinnovare i più triti luoghi comuni sull'avventuriero vene-
ziano), Kubrick sfrutta a fondo il romanzo di Thackeray, e anche le decisive modificazio-
ni introdotte dal film derivano da una profonda comprensione critica del testo letterario.
Si direbbe quasi — e la naturalezza, l'ovvietà di questa impressione dà la misura della
perfezione del risultato — che il film di Kubrick sia l'evoluzione storica del romanzo di
Thackeray.
Con un procedimento che presenta molte analogie con quello di Kubrick, Thackeray
demolisce il mito dell'avventuriero facendo la parodia del romanzo picaresco. E Barry in
prima persona che, credendo di tessere il proprio elogio, pronuncia la sua condanna. In
altri momenti del romanzo Barry diventa i l portavoce dell'autore, là dove egli vuole
smascherare il mito romantico della gloria militare oppure colpire i vizi dell'aristocrazia.
A parte questo vistoso doppio registro, Thackeray, come quasi tutti i parodisti, non sem-
pre riesce a stabilire un perfetto distacco dai suoi bersagli. Barry è certamente un bricco-
ne, un criminale, ma non privo di tratti buoni, e la sua ingenua presunzione gli attira an-
chesimpatia. E se l'aristocrazia inglese non viene risparmiata, la satira della miserabile e
vanagloriosa nobiltà irlandese presenta dei risvolti che tradiscono il punto di vista di un'a-
215
















