
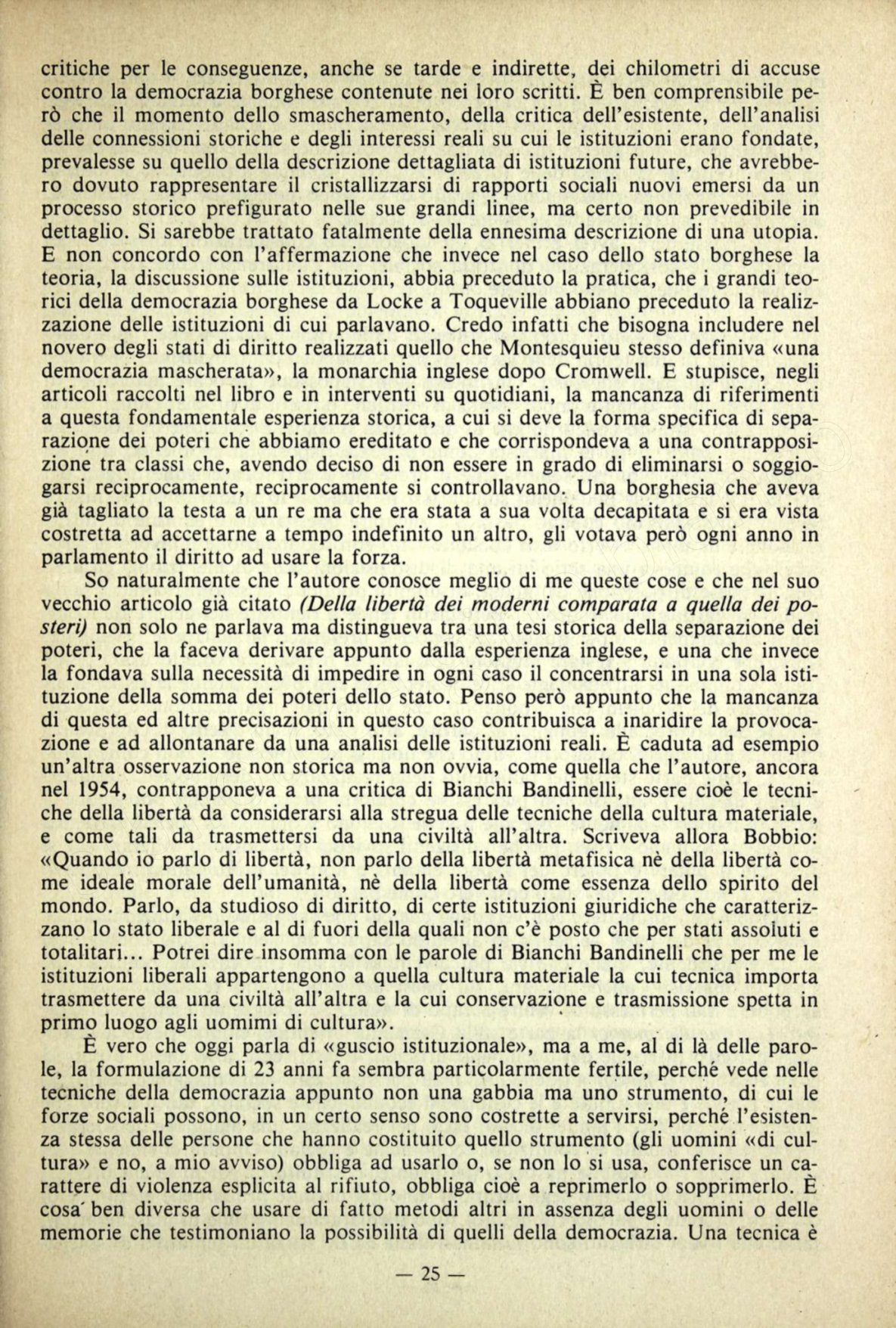
critiche per le conseguenze, anche se tarde e indirette, dei chilometri di accuse
contro la democrazia borghese contenute nei loro scritti. È ben comprensibile pe-
rò che il momento dello smascheramento, della critica dell'esistente, dell'analisi
delle connessioni storiche e degli interessi reali su cui le istituzioni erano fondate,
prevalessesu quello della descrizione dettagliata di istituzioni future, che avrebbe-
ro dovuto rappresentare il cristallizzarsi di rapporti sociali nuovi emersi da un
processo storico prefigurato nelle sue grandi linee, ma certo non prevedibile in
dettaglio. Si sarebbe trattato fatalmente della ennesima descrizione di una utopia.
E non concordo con l'affermazione che invece nel caso dello stato borghese la
teoria, la discussione sulle istituzioni, abbia preceduto la pratica, che i grandi teo-
rici della democrazia borghese da Locke a Toqueville abbiano preceduto la realiz-
zazione delle istituzioni di cui parlavano. Credo infatti che bisogna includere nel
novero degli stati di diritto realizzati quello che Montesquieu stesso definiva «una
democraziamascherata», la monarchia inglese dopo Cromwell. E stupisce, negli
articoli raccolti nel libro e in interventi su quotidiani, la mancanza di riferimenti
aquesta fondamentale esperienza storica, a cui si deve la forma specifica di sepa-
razione dei poteri ché abbiamo ereditato e che corrispondeva a una contrapposi-
zione tra classi che, avendo deciso di non essere in grado di eliminarsi o soggio-
garsi reciprocamente, reciprocamente si controllavano. Una borghesia che aveva
già tagliato la testa a un re ma che era stata a sua volta decapitata e si era vista
costretta ad accettarne a tempo indefinito un altro, gli votava però ogni anno in
parlamento il diritto ad usare la forza.
Sonaturalmente che l'autore conoscemeglio di me queste cose e che nel suo
vecchio articolo già citato (Della libertà dei moderni comparata a quella dei po-
steri)
non solo ne parlava ma distingueva tra una tesi storica della separazione dei
poteri, che la faceva derivare appunto dalla esperienza inglese, e una che invece
la fondava sulla necessità di impedire in ogni caso il concentrarsi in una sola isti-
tuzione della somma dei poteri dello stato. Penso però appunto che la mancanza
di questa ed altre precisazioni in questo caso contribuisca a inaridire la provoca-
zione e ad allontanare da una analisi delle istituzioni reali. È caduta ad esempio
un'altra osservazione non storica ma non ovvia, come quella che l'autore, ancora
nel 1954, contrapponeva a una critica di Bianchi Bandinelli, essere cioè le tecni-
che della libertà da considerarsi alla stregua delle tecniche della cultura materiale,
ecome tal i da trasmettersi da una civiltà all'altra. Scriveva allora Bobbio:
«Quando io parlo di libertà, non parlo della libertà metafisica nè della libertà co-
me ideale morale dell'umanità, nè della libertà come essenza dello spirito del
mondo. Parlo, da studioso di diritto, di certe istituzioni giuridiche che caratteriz-
zano lo stato liberale e al di fuori della quali non c'è posto che per stati assoluti e
totalitari... Potrei dire insomma con le parole di Bianchi Bandinelli che per me le
istituzioni liberali appartengono a quella cultura materiale la cui tecnica importa
trasmettere da una civiltà all'altra e la cui conservazione e trasmissione spetta in
primo luogo agli uomimi di cultura».
È vero che oggi parla di «guscio istituzionale», ma a me, al di là delle paro-
le, la formulazione di 23 anni fa sembra particolarmente fertile, perché vede nelle
tecniche della democrazia appunto non una gabbia ma uno strumento, di cui le
forze sociali possono, in un certo senso sono costrette a servirsi, perché l'esisten-
zastessa delle persone che hanno costituito quello strumento (gli uomini «di cul-
tura» e no, a mio avviso) obbliga ad usarlo o, se non lo u s a , conferisce un ca-
rattere di violenza esplicita al rifiuto, obbliga cioè a reprimerlo o sopprimerlo. È
cosa' ben diversa che usare di fatto metodi altri in assenza degli uomini o delle
memorie che testimoniano la possibilità di quelli della democrazia. Una tecnica è
25
















