
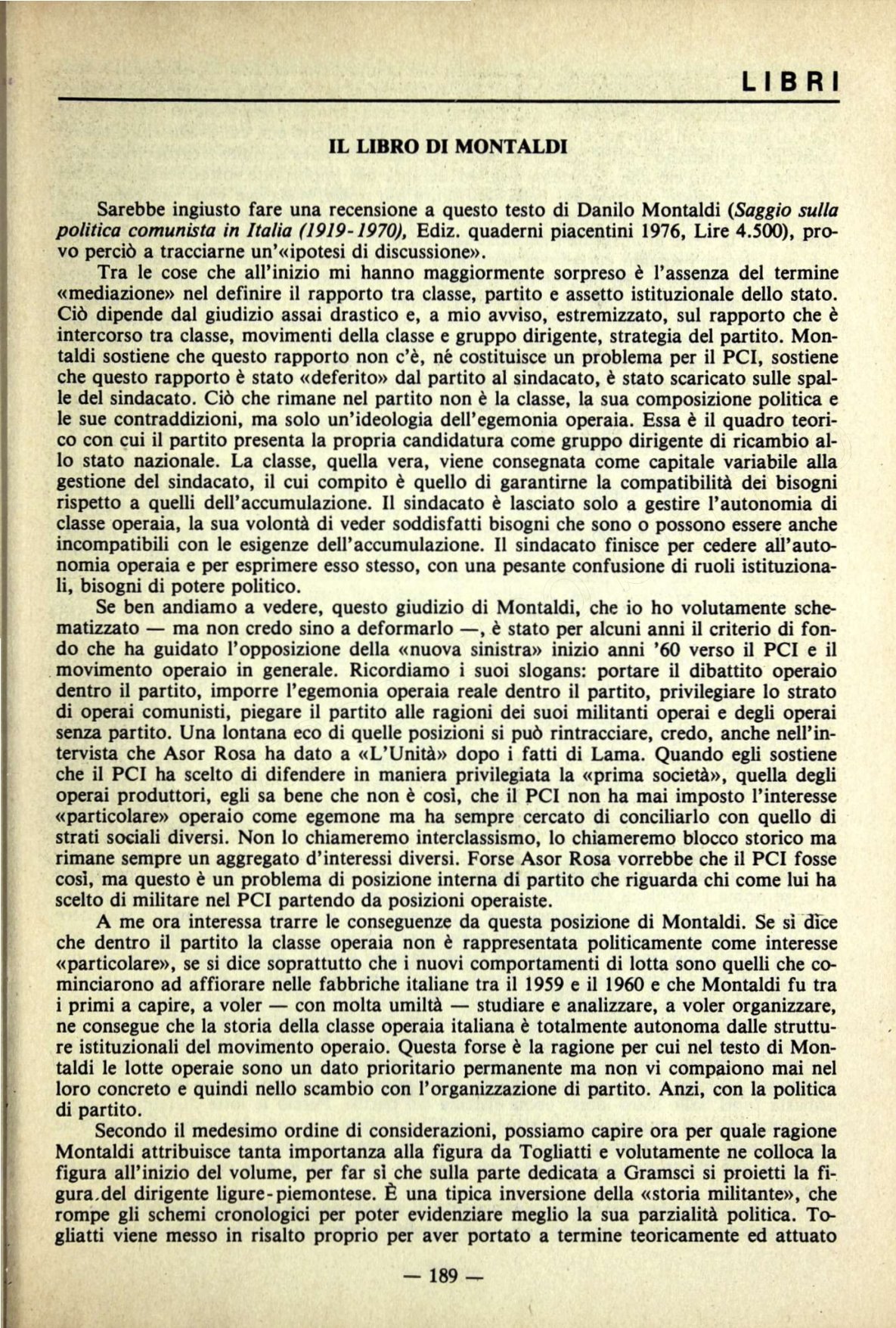
L I BR I
IL LIBRO DI MONTALDI
Sarebbe ingiusto fare una recensione a questo testo di Danilo Montaldi
(Saggio sulla
politica comunista in Italia (1919-1970),
Ediz. quaderni piacentini 1976, Lire 4.500), pro-
voperciò a tracciarne un'«ipotesi di discussione».
Tra le cose che all'inizio mi hanno maggiormente sorpreso è l'assenza del termine
«mediazione» nel definire il rapporto tra classe, partito e assetto istituzionale dello stato.
Ciò dipende dal giudizio assai drastico e, a mio avviso, estremizzato, sul rapporto che è
intercorso tra classe, movimenti della classe e gruppo dirigente, strategia del partito. Mon-
taldi sostiene che questo rapporto non c'è, né costituisce un problema per il PCI, sostiene
chequesto rapporto è stato «deferito» dal partito al sindacato, è stato scaricato sulle spal-
le del sindacato. Ciò che rimane nel partito non è la classe, la sua composizione politica e
lesue contraddizioni, ma solo un'ideologia dell'egemonia operaia. Essa è il quadro teori-
cocon cui il partito presenta la propria candidatura come gruppo dirigente di ricambio al-
lo stato nazionale. La classe, quella vera, viene consegnata come capitale variabile alla
gestione del sindacato, i l cui compito è quello di garantirne la compatibilità dei bisogni
rispetto a quelli dell'accumulazione. I l sindacato è lasciato solo a gestire l'autonomia di
classeoperaia, la sua volontà di veder soddisfatti bisogni che sono o possonoessereanche
incompatibili con le esigenze dell'accumulazione. I l sindacato finisce per cedere all'auto-
nomia operaia e per esprimereessostesso, con una pesante confusione di ruoli istituziona-
li, bisogni di potere politico.
Seben andiamo a vedere, questo giudizio di Montaldi, che io ho volutamente sche-
matizzato — ma non credo sino a deformarlo —, è stato per alcuni anni il criterio di fon-
do che ha guidato l'opposizione della «nuova sinistra» inizio anni '60 verso il PCI e il
movimento operaio in generale. Ricordiamo i suoi slogans: portare il dibattito operaio
dentro il partito, imporre l'egemonia operaia reale dentro il partito, privilegiare lo strato
di operai comunisti, piegare il partito alle ragioni dei suoi militanti operai e degli operai
senza partito. Una lontana eco di quelle posizioni si può rintracciare, credo, anche nell'in-
tervista che Asor Rosa ha dato a «L'Unità» dopo i fatti di Lama. Quando egli sostiene
che il PCI ha scelto di difendere in maniera privilegiata la «prima società», quella degli
operai produttori, egli sa bene che non è così, che il PCI non ha mai imposto l'interesse
«particolare» operaio come egemone ma ha sempre cercato di conciliarlo con quello di
strati sociali diversi. Non lo chiameremo interclassismo, lo chiameremo blocco storico ma
rimane sempre un aggregato d'interessi diversi. Forse Asor Rosa vorrebbe che il PCI fosse
così, ma questo è un problema di posizione interna di partito che riguarda chi come lui ha
scelto di militare nel PCI partendo da posizioni operaiste.
Ame ora interessa trarre le conseguenze da questa posizione di Montaldi. Se si dice
chedentro il partito la classe operaia non è rappresentata politicamente come interesse
«particolare», se si dice soprattutto che i nuovi comportamenti di lotta sono quelli che co-
minciarono ad affiorare nelle fabbriche italiane tra il 1959 e il 1960 e che Montaldi fu tra
i primi a capire, a voler — con molta umiltà — studiare e analizzare, a voler organizzare,
neconsegue che la storia della classe operaia italiana è totalmente autonoma dalle struttu-
re istituzionali del movimento operaio. Questa forse è la ragione per cui nel testo di Mon-
taldi le lotte operaie sono un dato prioritario permanente ma non vi compaiono mai nel
loro concreto e quindi nello scambio con l'organizzazione di partito. Anzi, con la politica
di partito.
Secondo il medesimo ordine di considerazioni, possiamo capire ora per quale ragione
Montaldi attribuisce tanta importanza alla figura da Togliatti e volutamente ne colloca la
figura all'inizio del volume, per far si che sulla parte dedicata a Gramsci si proietti la fi-
gura.del dirigente ligure-piemontese. È una tipica inversione della «storia militante», che
rompe gli schemi cronologici per poter evidenziare meglio la sua parzialità politica. To-
gliatti viene messo in risalto proprio per aver portato a termine teoricamente ed attuato
189
















