
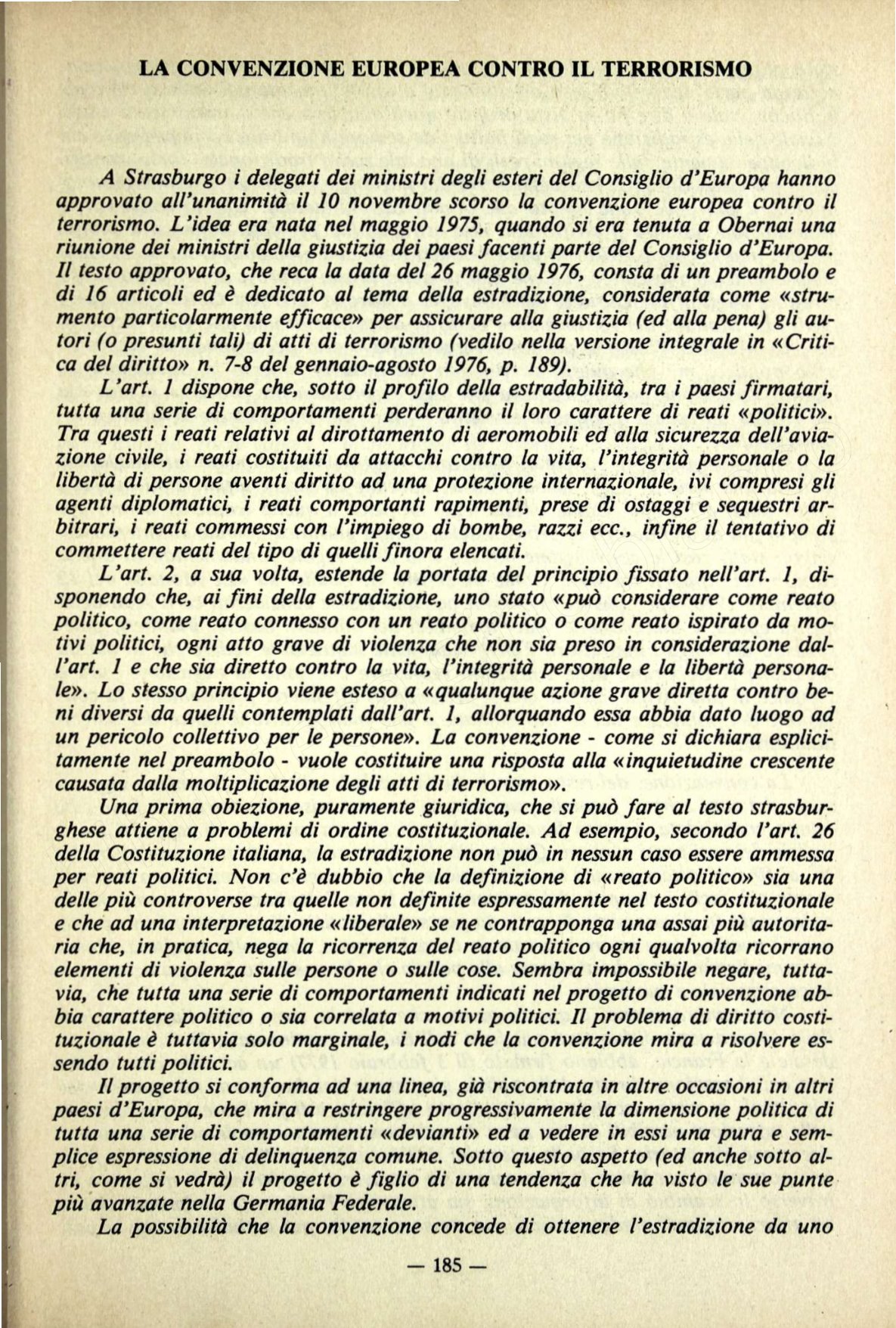
LA CONVENZIONE EUROPEA CONTRO IL TERRORISMO
A Strasburgo i delegati dei ministri degli esteri del Consiglio d'Europa hanno
approvato all'unanimità i l 10 novembre scorso la convenzione europea contro i l
terrorismo. L' idea era nata nel maggio 1975, quando si era tenuta a Obernai una
riunione dei ministri della giustizia dei paesi facenti parte del Consiglio d'Europa.
I l testo approvato, che reca la data del 26 maggio 1976, consta di un preambolo e
di 16 articoli ed è dedicato al tema della estradizione, considerata come «stru-
mento particolarmente efficace» per assicurare alla giustizia (ed alla pena) gl i au-
tori (o presunti tali) di atti di terrorismo (vedilo nella versione integrale in «Criti-
ca del diritto» n. 7-8 del gennaio-agosto 1976, p. 189).
L'art. 1 dispone che, sotto i l profilo della estradabilità, t ra i paesi firmatari,
tutta una serie di comportamenti perderanno i l loro carattere di reati «politici».
Tra questi i reati relativi al dirottamento di aeromobili ed alla sicurezza dell'avia-
zione civile, i reati costituiti da attacchi contro la vita, l'integrità personale o la
libertà di persone aventi diritto ad una protezione internazionale, i v i compresi gli
agenti diplomatici, i reati comportanti rapimenti, prese di ostaggi e sequestri ar-
bitrari, i reati commessi con l'impiego di bombe, razzi ecc., infine i l tentativo di
commettere reati del tipo di quelli finora elencati.
L'art. 2, a sua volta, estende la portata del principio fissato nell'art. 1, di -
sponendo che, a i f ini della estradizione, uno stato «può considerare come reato
politico, come reato connesso con un reato politico o come reato ispirato da mo-
tivi politici, ogni atto grave di violenza che non sia preso in considerazione dal-
l'art. 1 e che sia diretto contro la vita, l'integrità personale e la libertà persona-
le». Lo stesso principio viene esteso a «qualunque azione grave diretta contro be-
ni diversi da quelli contemplati dall'art. 1, allorquando essa abbia dato luogo ad
un pericolo collettivo per le persone». La convenzione - come si dichiara esplici-
tamente nel preambolo - vuole costituire una risposta alla «inquietudine crescente
causata dalla moltiplicazione degli atti di terrorismo».
Una prima obiezione, puramente giuridica, che si può fare al testo strasbur-
ghese attiene a problemi di ordine costituzionale. A d esempio, secondo l'art. 26
della Costituzione italiana, la estradizione non può in nessun caso essere ammessa
per reati politici. Non c'è dubbio che la definizione di «reato politico» sia una
delle più controverse tra quelle non definite espressamente nel testo costituzionale
eche ad una interpretazione «liberale» se ne contrapponga una assai più autorita-
ria che, i n pratica, nega la ricorrenza del reato politico ogni qualvolta ricorrano
elementi di violenza sulle persone o sulle cose. Sembra impossibile negare, tutta-
via, che tutta una serie di comportamenti indicati nel progetto di convenzione ab-
bia carattere politico o sia correlata a motivi politici. I l problema di diritto costi-
tuzionale è tuttavia solo marginale, i nodi che la convenzione mira a risolvere es-
sendo tutti politici.
I l progetto si conforma ad una linea, già riscontrata in altre occasioni in altri
paesi d'Europa, che mira a restringere progressivamente la dimensione politica di
tutta una serie di comportamenti «devianti» ed a vedere in essi una pura e sem-
plice espressione di delinquenza comune. Sotto questo aspetto (ed anche sotto al-
tri, come si vedrà) i l progetto è figlio di una tendenza che ha visto le sue punte
più avanzate nella Germania Federale.
La possibilità che la convenzione concede di ottenere l'estradizione da uno
185
















