
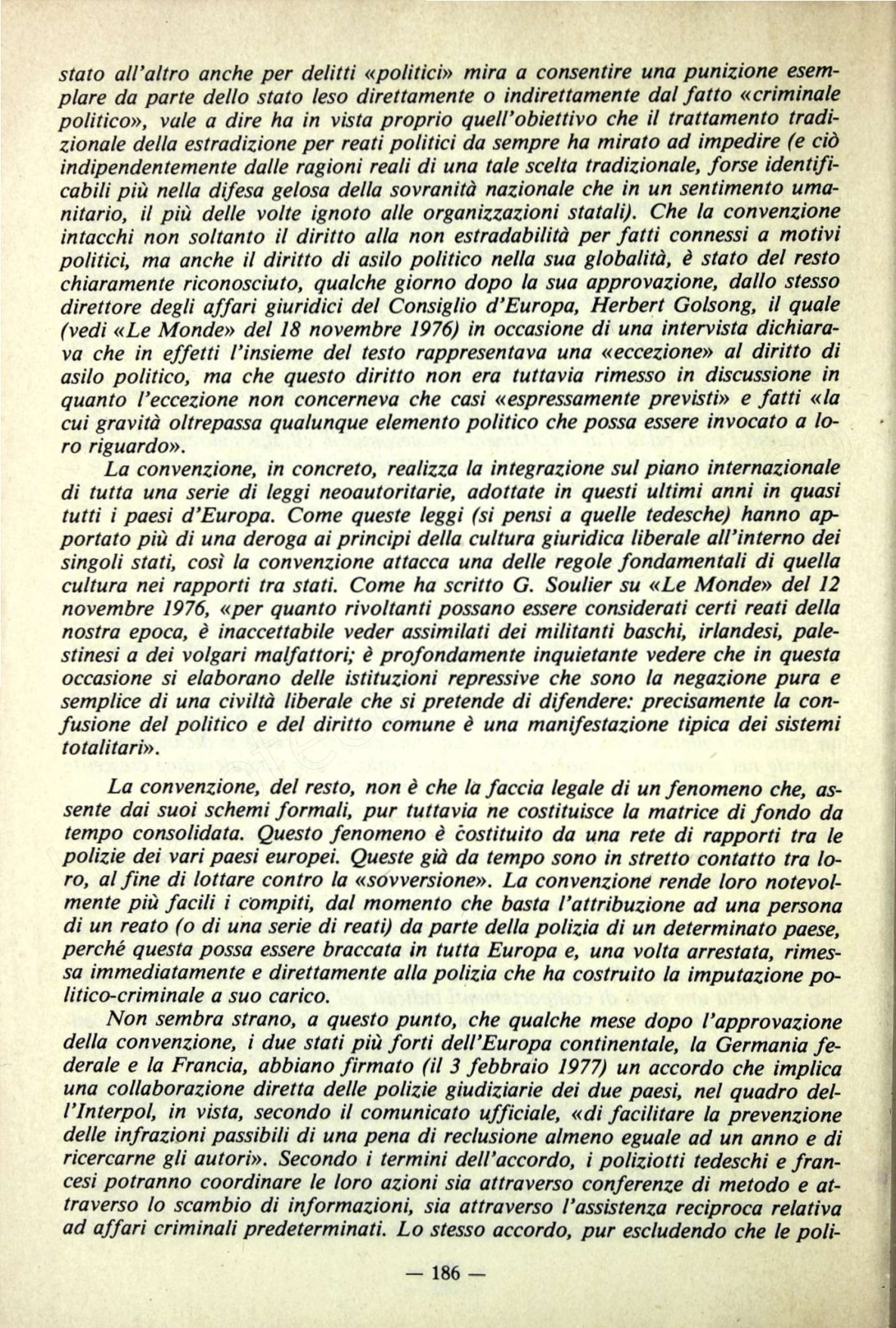
stato all'altro anche per delitti «politici» mira a consentire una punizione esem-
plare da parte dello stato leso direttamente o indirettamente dal fatto «criminale
politico», vale a dire ha in vista proprio quell'obiettivo che il trattamento tradi-
zionale della estradizione per reati politici da sempre ha mirato ad impedire (e ciò
indipendentemente dalle ragioni reali di una tale scelta tradizionale, forse identifi-
cabili più nella difesa gelosa della sovranità nazionale che in un sentimento uma-
nitario, i l più delle volte ignoto alle organizzazioni statali). Che la convenzione
intacchi non soltanto i l diritto alla non estradabilità per fatti connessi a motivi
politici, ma anche il diritto di asilo politico nella sua globalità, è stato del resto
chiaramente riconosciuto, qualche giorno dopo la sua approvazione, dallo stesso
direttore degli affari giuridici del Consiglio d'Europa, Herbert Golsong, i l quale
(vedi «Le Monde» del 18 novembre 1976) in occasione di una intervista dichiara-
va che in effetti l'insieme del testo rappresentava una «eccezione» al diritto di
asilo politico, ma che questo diritto non era tuttavia rimesso in discussione in
quanto l'eccezione non concerneva che casi «espressamente previsti» e fatti «la
cui gravità oltrepassa qualunque elemento politico che possaessere invocato a lo-
ro riguardo».
La convenzione, in concreto, realizza la integrazione sul piano internazionale
di tutta una serie di leggi neoautoritarie, adottate in questi ultimi anni in quasi
tutti i paesi d'Europa. Come queste leggi (si pensi a quelle tedesche) hanno ap-
portato più di una deroga ai principi della cultura giuridica liberale all'interno dei
singoli stati, così la convenzione attacca una delle regole fondamentali di quella
cultura nei rapporti tra stati. Come ha scritto G. Soulier su «Le Monde» del 12
novembre 1976, «per quanto rivoltanti possanoessere considerati certi reati della
nostra epoca, è inaccettabile veder assimilati dei militanti baschi, irlandesi, pale-
stinesi a dei volgari malfattori; è profondamente inquietante vedere che in questa
occasione si elaborano delle istituzioni repressive che sono la negazione pura e
semplice di una civiltà liberale che si pretende di difendere: precisamente la con-
fusione del politico e del diritto comune è una manifestazione tipica dei sistemi
totalitari».
La convenzione, del resto, non è che la faccia legale di un fenomeno che, as-
sente dai suoi schemi formali, pur tuttavia ne costituisce la matrice di fondo da
tempo consolidata. Questo fenomeno è ivstituito da una rete di rapporti tra le
polizie dei vari paesi europei. Queste già da tempo sono in stretto contatto tra l a
ro, al fine di lottare contro la «sovversione». La convenzione rende loro notevol-
mente più facili i compiti, dal momento che basta l'attribuzione ad una persona
di un reato (o di una serie di reati) da parte della polizia di un determinato paese,
perché questa possaessere braccata in tutta Europa e, una volta arrestata, rimes-
sa immediatamente e direttamente alla polizia che ha costruito la imputazione po-
litico-criminale a suo carico.
Non sembra strano, a questo punto, che qualche mese dopo l'approvazione
della convenzione, i due stati più forti dell'Europa continentale, la Germania fe-
derale e la Francia, abbiano firmato (il 3 febbraio 1977) un accordo che implica
una collaborazione diretta delle polizie giudiziarie dei due paesi, nel quadro del-
l'Interpol, in vista, secondo il comunicato ufficiale, «di facilitare la prevenzione
delle infrazioni passibili di una pena di reclusione almeno eguale ad un anno e di
ricercarne gli autori». Secondo i termini dell'accordo, i poliziotti tedeschi e fran-
cesi potranno coordinare le loro azioni sia attraverso conferenze di metodo e at-
traverso lo scambio di informazioni, sia attraverso l'assistenza reciproca relativa
ad affari criminali predeterminati. Lo stesso accordo, pur escludendo che le poli-
- 186—
















