
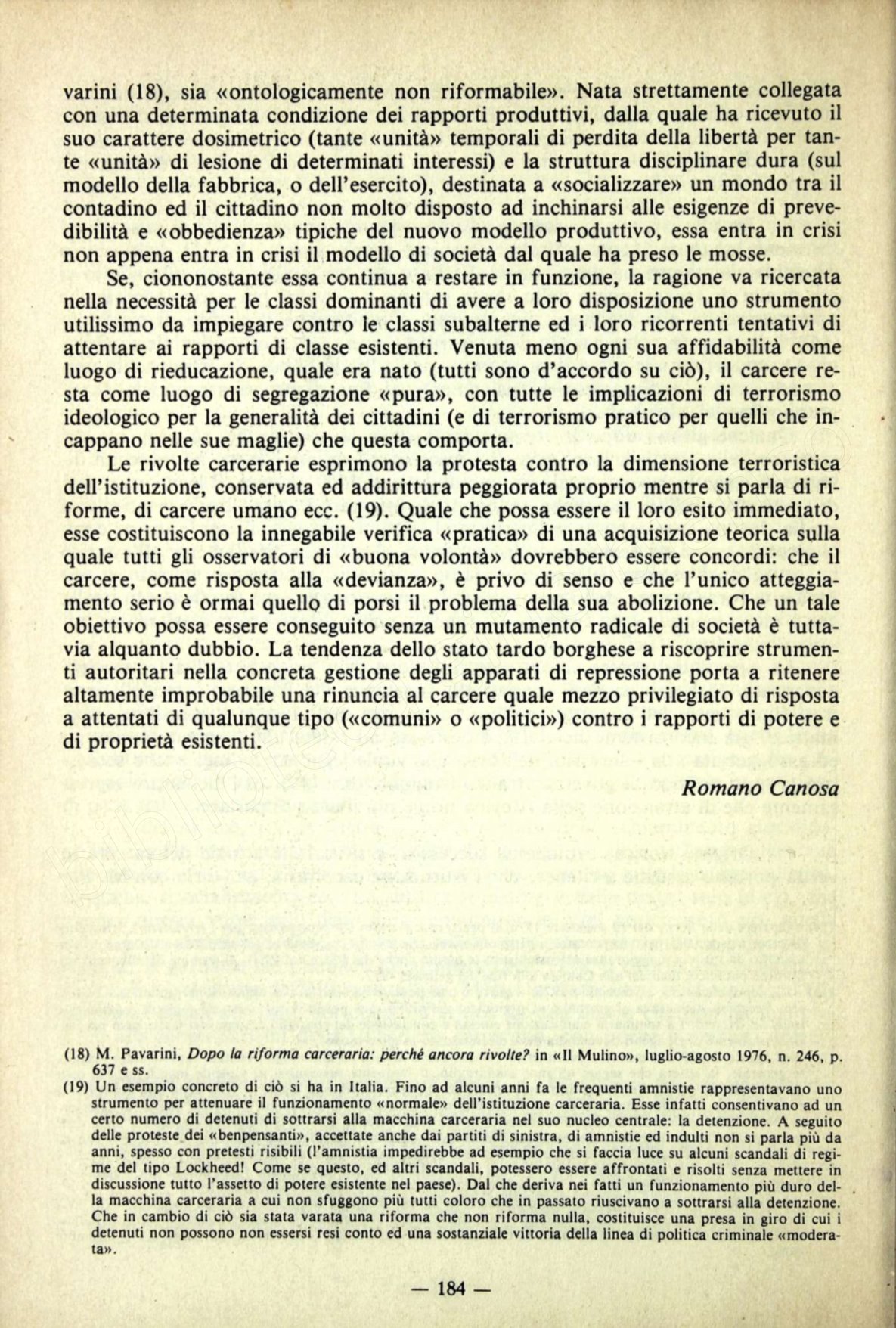
varini (18), sia «ontologicamente non riformabile». Nata strettamente collegata
conuna determinata condizione dei rapporti produttivi, dalla quale ha ricevuto il
suocarattere dosimetrico (tante «unità» temporali di perdita della libertà per tan-
te «unità» di lesione di determinati interessi) e la struttura disciplinare dura (sul
modello della fabbrica, o dell'esercito), destinata a «socializzare» un mondo tra il
contadino ed il cittadino non molto disposto ad inchinarsi alle esigenze di preve-
dibilità e «obbedienza» tipiche del nuovo modello produttivo, essa entra in crisi
nonappena entra in crisi il modello di società dal quale ha preso lemosse.
Se,ciononostanteessacontinua a restare in funzione, la ragione va ricercata
nellanecessità per le classi dominanti di avere a loro disposizione uno strumento
utilissimo da impiegare contro le classi subalterne ed i loro ricorrenti tentativi di
attentare ai rapporti di classe esistenti. Venuta meno ogni sua affidabilità come
luogo di rieducazione, quale era nato (tutti sono d'accordo su ciò), il carcere re-
stacome luogo di segregazione «pura», con tutte le implicazioni di terrorismo
ideologico per la generalità dei cittadini (e di terrorismo pratico per quelli che in-
cappanonellesuemaglie) chequesta comporta.
Le rivolte carcerarie esprimono la protesta contro la dimensione terroristica
dell'istituzione, conservata ed addirittura peggiorata propriomentre si parla di ri-
forme, di carcere umanoecc. (19). Quale chepossaessere il loro esito immediato,
essecostituiscono la innegabile verifica «pratica» di una acquisizione teorica sulla
quale tutti gli osservatori di «buona volontà» dovrebberoessereconcordi: che il
carcere, come risposta alla «devianza», è privo di senso e che l'unico atteggia-
mentoserio è ormai quello di porsi il problema della sua abolizione. Che un tale
obiettivopossaessereconseguitosenza un mutamento radicale di società è tutta-
via alquanto dubbio. La tendenza dello stato tardo borghese a riscoprire strumen-
ti autoritari nella concreta gestione degli apparati di repressione porta a ritenere
altamente improbabile una rinuncia al carcere qualemezzo privilegiato di risposta
aattentati di qualunque tipo («comuni» o «politici») contro i rapporti di potere e
di proprietà esistenti.
RomanoCanosa
(18) M. Pavarini,
Dopo la riforma carceraria: perché ancora rivolte? in
«II Mulino», luglio-agosto 1976, n. 246, p.
637 e ss.
(19) Un esempio concreto di ciò si ha in Italia. Fino ad alcuni anni fa le frequenti amnistie rappresentavano uno
strumento per attenuare il funzionamento «normale» dell'istituzione carceraria. Esse infatti consentivano ad un
certo numero di detenuti di sottrarsi alla macchina carceraria nel suo nucleo centrale: la detenzione. A seguito
delle proteste dei «benpensanti», accettate anche dai partiti di sinistra, di amnistie ed indulti non si parla più da
anni, spessocon pretesti risibili (l'amnistia impedirebbe ad esempio che si faccia luce su alcuni scandali di regi-
medel tipo Lockheedi Come se questo, ed altri scandali, potesseroessere affrontati e risolti senza mettere in
discussione tutto l'assetto di potere esistente nel paese). Dal che deriva nei fatti un funzionamento più duro del-
lamacchina carceraria a cui non sfuggono più tutti coloro che in passato riuscivano a sottrarsi alla detenzione.
Che in cambio di ciò sia stata varata una riforma che non riforma nulla, costituisce una presa in giro di cui i
detenuti non possono non essersi resi conto ed una sostanziale vittoria della linea di politica criminale «modera-
ta».
—184
















