
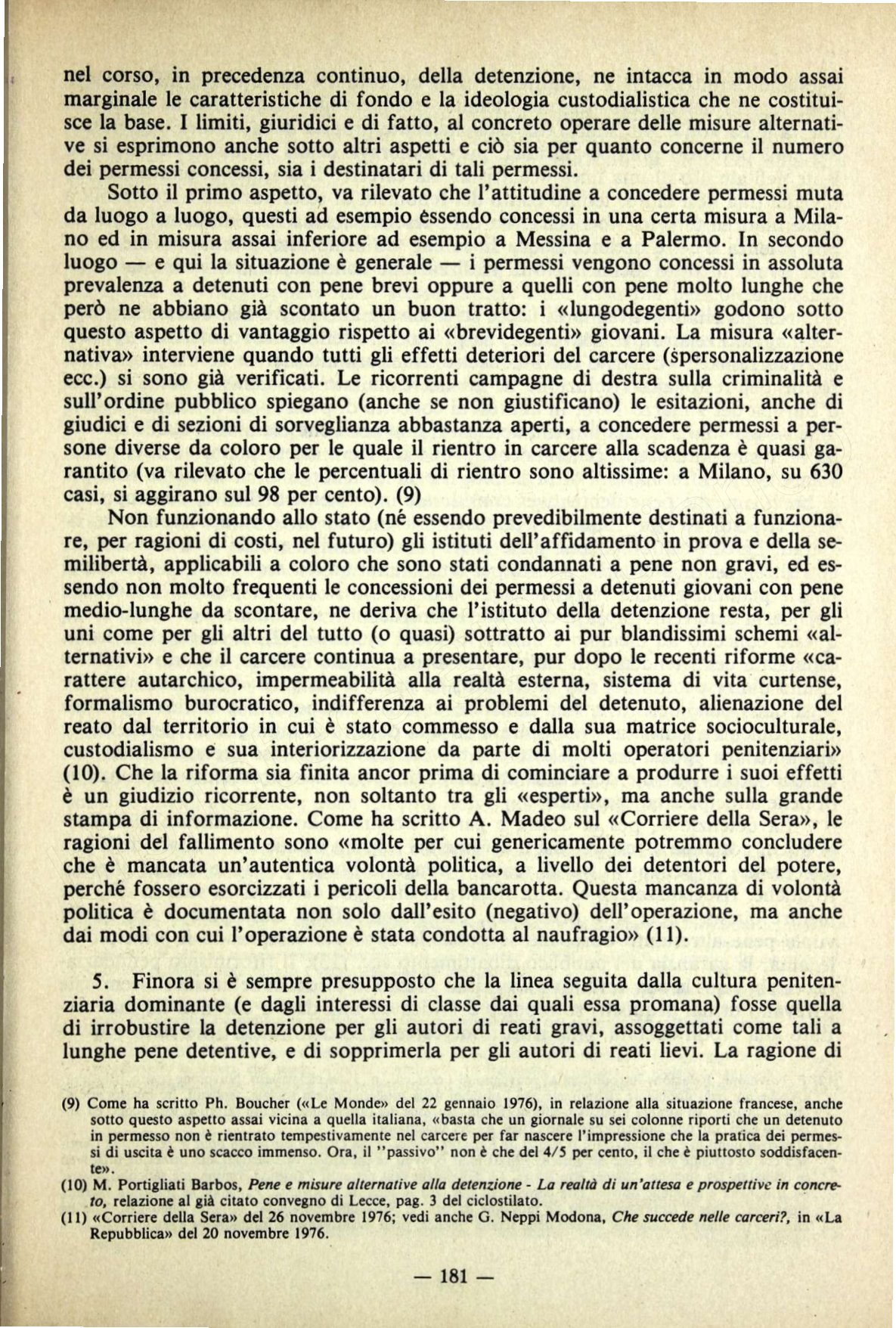
nel corso, in precedenza continuo, della detenzione, ne intacca in modo assai
marginale le caratteristiche di fondo e la ideologia custodialistica che ne costitui-
sce la base. I limiti, giuridici e di fatto, al concreto operare delle misure alternati-
ve si esprimono anche sotto altri aspetti e ciò sia per quanto concerne il numero
dei permessi concessi, sia i destinatari di tali permessi.
Sotto il primo aspetto, va rilevato che l'attitudine a concedere permessi muta
da luogo a luogo, questi ad esempioessendoconcessi in una certa misura a Mila-
no ed in misura assai inferiore ad esempio a Messina e a Palermo. In secondo
luogo — e qui la situazione è generale — i permessi vengono concessi in assoluta
prevalenza a detenuti con pene brevi oppure a quelli con pene molto lunghe che
però ne abbiano già scontato un buon tratto: i «lungodegenti» godono sotto
questo aspetto di vantaggio rispetto ai «brevidegenti» giovani. La misura «alter-
nativa» interviene quando tutti gli effetti deteriori del carcere (spersonalizzazione
ecc.) si sono già verificati. Le ricorrenti campagne di destra sulla criminalità e
sull'ordine pubblico spiegano (anche se non giustificano) le esitazioni, anche di
giudici e di sezioni di sorveglianza abbastanza aperti, a concedere permessi a per-
sonediverse da coloro per le quale il rientro in carcere alla scadenza è quasi ga-
rantito (va rilevato che le percentuali di rientro sono altissime: a Milano, su 630
casi, si aggirano sul 98 per cento). (9)
Non funzionando allo stato (né essendoprevedibilmente destinati a funziona-
re, per ragioni di costi, nel futuro) gli istituti dell'affidamento in prova e della se-
milibertà, applicabili a coloro che sono stati condannati a pene non gravi, ed es-
sendo non molto frequenti le concessioni dei permessi a detenuti giovani con pene
medio-lunghe da scontare, ne deriva che l'istituto della detenzione resta, per gli
uni come per gli altri del tutto (o quasi) sottratto ai pur blandissimi schemi «al-
ternativi» e che il carcere continua a presentare, pur dopo le recenti riforme «ca-
rattere autarchico, impermeabilità alla realtà esterna, sistema di vita curtense,
formalismo burocratico, indifferenza ai problemi del detenuto, alienazione del
reato dal territorio in cui è stato commesso e dalla sua matrice socioculturale,
custodialismo e sua interiorizzazione da parte di molti operatori penitenziari»
(10). Che la riforma sia finita ancor prima di cominciare a produrre i suoi effetti
è un giudizio ricorrente, non soltanto tra gli «esperti», ma anche sulla grande
stampa di informazione. Come ha scritto A. Madeo sul «Corriere della Sera», le
ragioni del fallimento sono «molte per cui genericamente potremmo concludere
che è mancata un'autentica volontà politica, a livello dei detentori del potere,
perché fossero esorcizzati i pericoli della bancarotta. Questa mancanza di volontà
politica è documentata non solo dall'esito (negativo) dell'operazione, ma anche
dai modi con cui l'operazione è stata condotta al naufragio» (11).
5. Finora si è sempre presupposto che la linea seguita dalla cultura peniten-
ziaria dominante (e dagli interessi di classe dai quali essa promana) fosse quella
di irrobustire la detenzione per gli autori di reati gravi, assoggettati come tali a
lunghe pene detentive, e di sopprimerla per gli autori di reati lievi. La ragione di
(9) Come ha scritto Ph. Boucher («Le Monde» del 22 gennaio 1976), i n relazione alla situazione francese, anche
sotto questo aspetto assai vicina a quella italiana, «basta che un giornale su sei colonne riporti che un detenuto
in permesso non è rientrato tempestivamente nel carcere per far nascere l'impressione che la pratica dei permes-
si di uscita è uno scacco immenso. Ora, i l "passivo" non è che del 4/5 per cento, i l che è piuttosto soddisfacen-
te».
(10) M. Portigliati Barbos, Pene e misure alternative alla detenzione - La realtà di un'attesa e prospettive in concre-
to,
relazione al già citato convegno di Lecce, pag. 3 del ciclostilato.
(11) «Corriere della Sera» del 26 novembre 1976; vedi anche G. Neppi Modona,
Che succede nelle carceri?, in
«La
Repubblica» del 20 novembre 1976.
181
















