
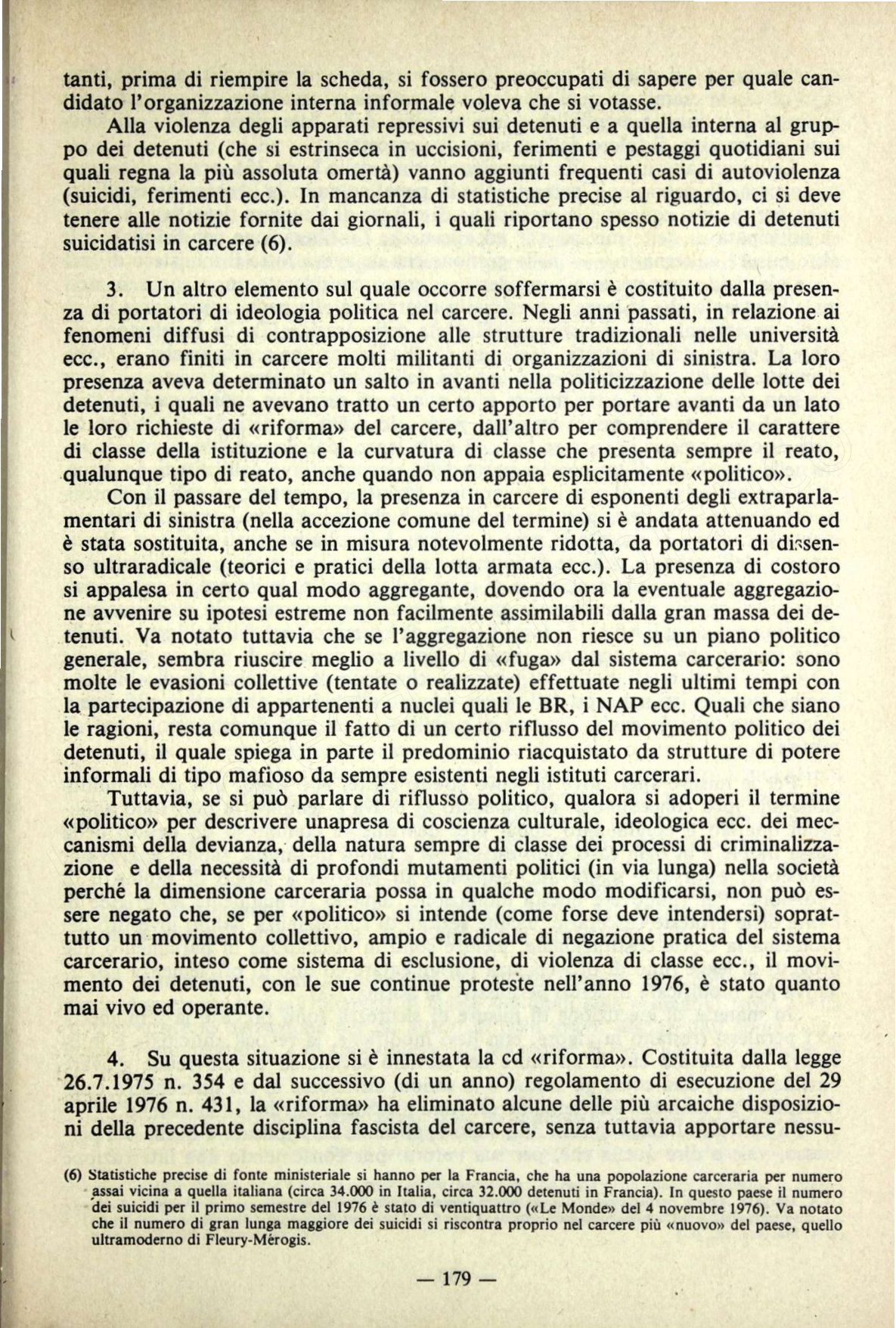
tanti, prima di riempire la scheda, si fosseropreoccupati di sapere per quale can-
didato l'organizzazione interna informale voleva che si votasse.
Alla violenza degli apparati repressivi sui detenuti e a quella interna al grup-
po dei detenuti (che si estrinseca in uccisioni, ferimenti e pestaggi quotidiani sui
quali regna la più assoluta omertà) vanno aggiunti frequenti casi di autoviolenza
(suicidi, ferimenti ecc.). In mancanza di statistiche precise al riguardo, ci si deve
tenere alle notizie fornite dai giornali, i quali riportanospessonotizie di detenuti
suicidatisi in carcere (6).
3. U n altro elemento sul quale occorre soffermarsi è costituito dalla presen-
za di portatori di ideologia politica nel carcere. Negli anni passati, in relazione ai
fenomeni diffusi di contrapposizione alle strutture tradizionali nelle università
ecc., erano finiti in carcere molti militanti di organizzazioni di sinistra. La loro
presenzaaveva determinato un salto in avanti nella politicizzazione delle lotte dei
detenuti, i quali ne avevano tratto un certo apporto per portare avanti da un lato
le loro richieste di «riforma» del carcere, dall'altro per comprendere il carattere
di classe della istituzione e la curvatura di classe che presenta sempre il reato,
qualunque tipo di reato, anche quando non appaia esplicitamente «politico».
Con il passare del tempo, la presenza in carcere di esponenti degli extraparla-
mentari di sinistra (nella accezionecomune del termine) si è andata attenuando ed
èstata sostituita, anchese in misura notevolmente ridotta, da portatori di di3sen-
soultraradicale (teorici e pratici della lotta armata ecc.). La presenza di costoro
siappalesa in certo qual modo aggregante, dovendo ora la eventuale aggregazio-
neavvenire su ipotesi estreme non facilmente assimilabili dalla granmassadei de-
tenuti. Va notato tuttavia che se l'aggregazione non riesce su un piano politico
generale, sembra riuscire meglio a livello di «fuga» dal sistema carcerario: sono
molte le evasioni collettive (tentate o realizzate) effettuate negli ultimi tempi con
la partecipazione di appartenenti a nuclei quali le BR, i NAP ecc. Quali che siano
le ragioni, resta comunque il fatto di un certo riflusso del movimento politico dei
detenuti, il quale spiega in parte il predominio riacquistato da strutture di potere
informali di tipo mafioso da sempreesistenti negli istituti carcerari.
Tuttavia, se si può parlare di riflusso politico, qualora si adoperi il termine
«politico» per descrivereunapresa di coscienza culturale, ideologica ecc. dei mec-
canismi della devianza, della natura sempre di classe dei processi di criminalizza-
zione e della necessità di profondi mutamenti politici (in via lunga) nella società
perché la dimensione carceraria possa in qualchemodomodificarsi, non può es-
serenegato che, se per «politico» si intende (come forse deve intendersi) soprat-
tutto un movimento collettivo, ampio e radicale di negazione pratica del sistema
carcerario, inteso come sistema di esclusione, di violenza di classe ecc., il movi-
mento dei detenuti, con le sue continue proteste nell'anno 1976, è stato quanto
mai vivo ed operante.
4. S u questa situazione si è innestata la cd «riforma». Costituita dalla legge
26.7.1975 n. 354 e dal successivo (di un anno) regolamento di esecuzione del 29
aprile 1976 n. 431, la «riforma» ha eliminato alcune delle più arcaiche disposizio-
ni della precedente disciplina fascista del carcere, senza tuttavia apportare nessu-
(6) Statistiche precise di fonte ministeriale si hanno per la Francia, che ha una popolazione carceraria per numero
assai vicina a quella italiana (circa 34.000 in Italia, circa 32.000 detenuti in Francia). In questopaese il numero
dei suicidi per il primo semestre del 1976 è stato di ventiquattro («Le Monde» del 4 novembre 1976). Va notato
che il numero di gran lunga maggiore dei suicidi si riscontra proprio nel carcere più «nuovo» del paese, quello
ultramoderno di Fleury-Mérogis.
1 7 9 -
















