
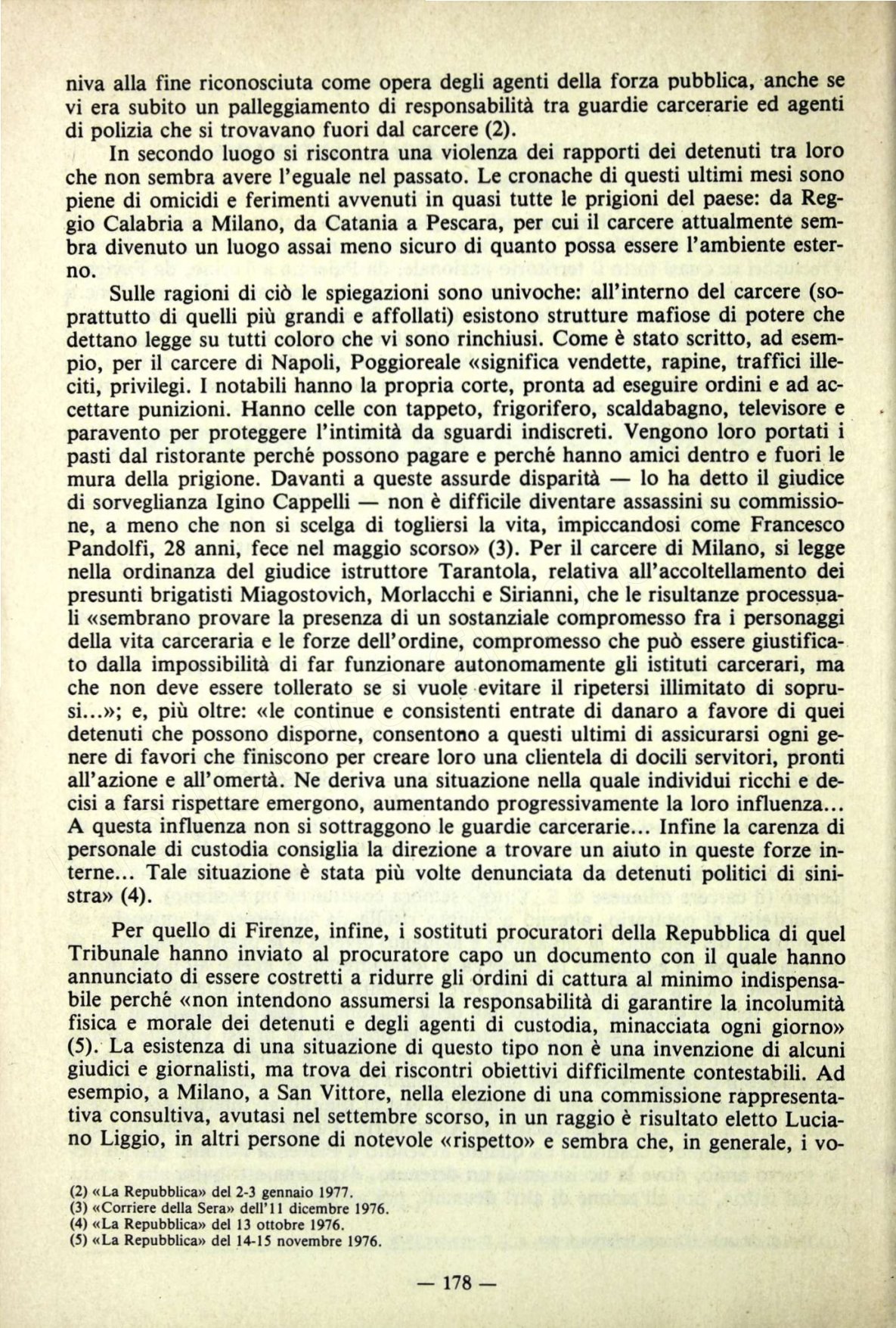
niva alla fine riconosciuta come opera degli agenti della forza pubblica, anche se
vi era subito un palleggiamento di responsabilità tra guardie carcerarie ed agenti
di polizia che si trovavano fuori dal carcere (2).
In secondo luogo si riscontra una violenza dei rapporti dei detenuti tra loro
chenon sembra avere l'eguale nel passato. Le cronache di questi ultimi mesi sono
piene di omicidi e ferimenti avvenuti in quasi tutte le prigioni del paese: da Reg-
gioCalabria a Milano, da Catania a Pescara, per cui il carcere attualmente sem-
bra divenuto un luogo assai meno sicuro di quantopossaessere l'ambiente ester-
no.
Sulle ragioni di ciò le spiegazioni sono univoche: all'interno del carcere (so-
prattutto di quelli più grandi e affollati) esistono strutture mafiose di potere che
dettano leggesu tutti coloro che vi sono rinchiusi. Come è stato scritto, ad esem-
pio, per il carcere di Napoli, Poggioreale «significa vendette, rapine, traffici ille-
citi, privilegi. I notabili hanno la propria corte, pronta ad eseguire ordini e ad ac-
cettare punizioni. Hanno celle con tappeto, frigorifero, scaldabagno, televisore e
paravento per proteggere l'intimità da sguardi indiscreti. Vengono loro portati i
pasti dal ristorante perchépossonopagare e perché hanno amici dentro e fuori le
mura della prigione. Davanti a questeassurde disparità — lo ha detto il giudice
di sorveglianza Igino Cappelli — non è difficile diventareassassini sucommissio-
ne, a meno che non si scelga di togliersi la vita, impiccandosi come Francesco
Pandolfi, 28 anni, fece nel maggioscorso» (3). Per il carcere di Milano, si legge
nella ordinanza del giudice istruttore Tarantola, relativa all'accoltellamento dei
presunti brigatisti Miagostovich, Morlacchi e Sirianni, che le risultanzeprocessua-
li «sembrano provare la presenza di un sostanzialecompromesso fra i personaggi
della vita carceraria e le forze dell'ordine, compromessoche puòesseregiustifica-
to dalla impossibilità di far funzionare autonomamente gli istituti carcerari, ma
che non deve essere tollerato se si vuole evitare il ripetersi illimitato di sopru-
si...»; e, più oltre: «le continue e consistenti entrate di danaro a favore di quei
detenuti chepossonodisporne, consentono a questi ultimi di assicurarsi ogni ge-
nere di favori che finiscono per creare loro una clientela di docili servitori, pronti
all'azione e all'omertà. Ne deriva una situazione nella quale individui ricchi e de-
cisi a farsi rispettare emergono, aumentandoprogressivamente la loro influenza...
A questa influenza non si sottraggono le guardie carcerarie... Infine la carenza di
personale di custodia consiglia la direzione a trovare un aiuto in queste forze in-
terne... Tale situazione è stata più volte denunciata da detenuti politici di sini-
stra» (4).
Per quello di Firenze, infine, i sostituti procuratori della Repubblica di quel
Tribunale hanno inviato al procuratore capo un documento con il quale hanno
annunciato di esserecostretti a ridurre gli ordini di cattura al minimo indispensa-
bile perché «non intendonoassumersi la responsabilità di garantire la incolumità
fisica e morale dei detenuti e degli agenti di custodia, minacciata ogni giorno»
(5). La esistenza di una situazione di questo tipo non è una invenzione di alcuni
giudici e giornalisti, ma trova dei riscontri obiettivi difficilmente contestabili. Ad
esempio, a Milano, a San Vittore, nella elezione di una commissione rappresenta-
tiva consultiva, avutasi nel settembrescorso, in un raggio è risultato eletto Lucia-
noLiggio, in altri persone di notevole «rispetto» e sembra che, in generale, i vo-
(2) «La Repubblica» del 2-3 gennaio 1977.
(3) «Corriere della Sera» dell'i 1dicembre 1976.
(4) «La Repubblica» del 13 ottobre 1976.
(5) «La Repubblica» del 14-15 novembre 1976.
















