
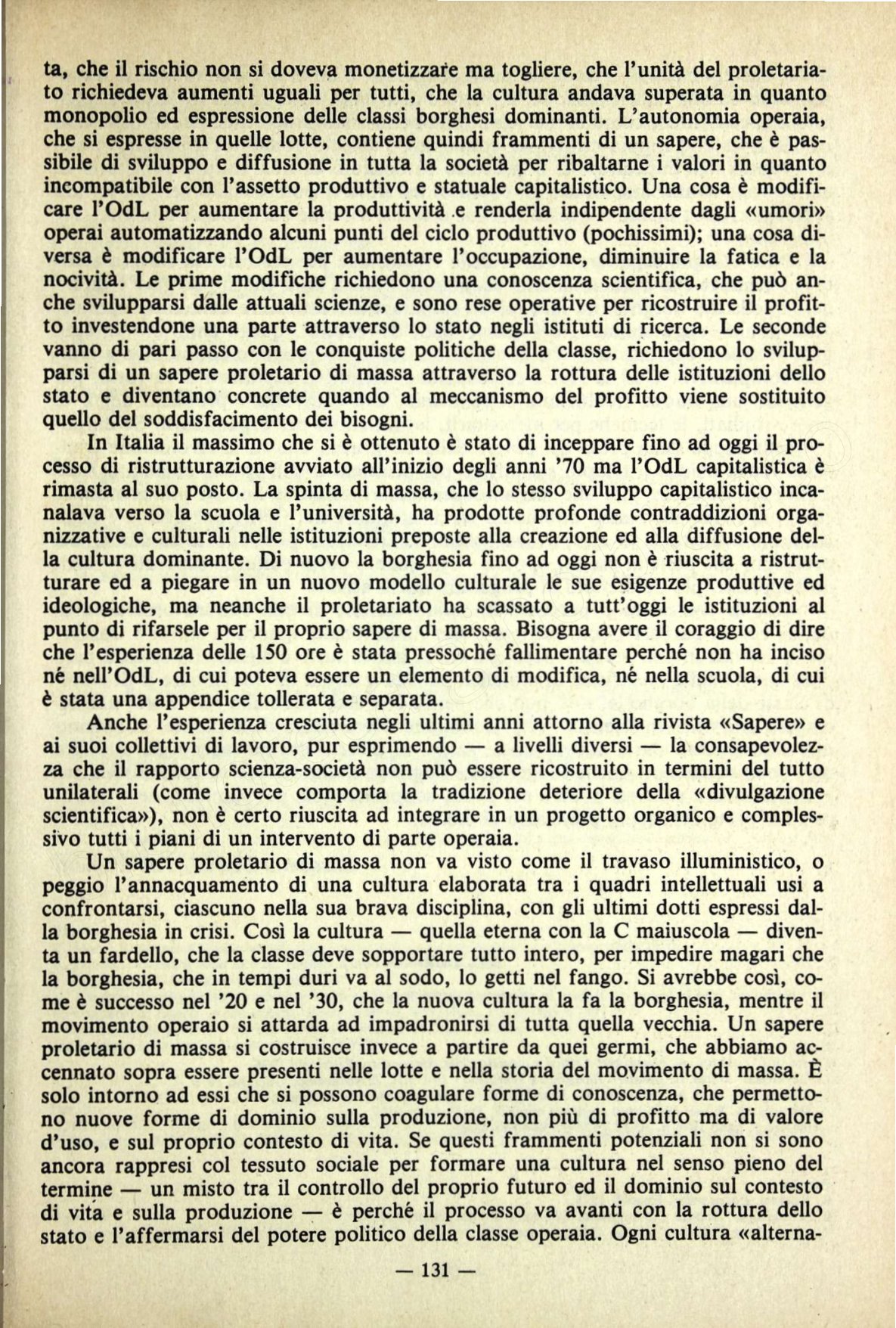
ta, che il rischio non si dovevamonetizzate ma togliere, che l'unità del proletaria-
to richiedeva aumenti uguali per tutti, che la cultura andava superata in quanto
monopolio ed espressione delle classi borghesi dominanti. L'autonomia operaia,
chesi espresse in quelle lotte, contiene quindi frammenti di un sapere, che è pas-
sibile di sviluppo e diffusione in tutta la società per ribaltarne i valori in quanto
incompatibile con l'assetto produttivo e statuale capitalistico. Una cosa è modifi-
care l'OdL per aumentare la produttività .e renderla indipendente dagli «umori»
operai automatizzando alcuni punti del ciclo produttivo (pochissimi); una cosa di-
versa è modificare l'OdL per aumentare l'occupazione, diminuire la fatica e la
nocività. Le prime modifiche richiedono una conoscenza scientifica, che può an-
chesvilupparsi dalle attuali scienze, e sono rese operative per ricostruire il profit-
to investendone una parte attraverso lo stato negli istituti di ricerca. Le seconde
vanno di pari passo con le conquiste politiche della classe, richiedono lo svilup-
parsi di un sapere proletario di massa attraverso la rottura delle istituzioni dello
stato e diventano concrete quando al meccanismo del profitto viene sostituito
quello del soddisfacimento dei bisogni.
In Italia il massimoche si è ottenuto è stato di inceppare fino ad oggi il pro-
cesso di ristrutturazione avviato all'inizio degli anni '70 ma l'OdL capitalistica è
rimasta al suo posto. La spinta di massa, che lo stessosviluppo capitalistico inca-
nalava verso la scuola e l'università, ha prodotte profonde contraddizioni orga-
nizzative e culturali nelle istituzioni preposte alla creazione ed alla diffusione del-
la cultura dominante. Di nuovo la borghesia fino ad oggi non è riuscita a ristrut-
turare ed a piegare in un nuovo modello culturale le sue esigenze produttive ed
ideologiche, ma neanche il proletariato ha scassato a tutt'oggi le istituzioni al
punto di rifarsele per il proprio sapere di massa. Bisogna avere il coraggio di dire
che l'esperienza delle 150 ore è stata pressoché fallimentare perché non ha inciso
né nell'OdL, di cui potevaessere un elemento di modifica, né nella scuola, di cui
èstata una appendice tollerata e separata.
Anche l'esperienza cresciuta negli ultimi anni attorno alla rivista «Sapere» e
ai suoi collettivi di lavoro, pur esprimendo — a livelli diversi — la consapevolez-
za che il rapporto scienza-società non può essere ricostruito in termini del tutto
unilaterali (come invece comporta la tradizione deteriore della «divulgazione
scientifica»), non è certo riuscita ad integrare in un progetto organico e comples-
sivo tutti i piani di un intervento di parte operaia.
Un sapere proletario di massa non va visto come il travaso illuministico, o
peggio l'annacquamento di una cultura elaborata tra i quadri intellettuali usi a
confrontarsi, ciascuno nella sua brava disciplina, con gli ultimi dotti espressi dal-
la borghesia in crisi. Così la cultura — quella eterna con la C maiuscola— diven-
ta un fardello, che la classedeve sopportare tutto intero, per impediremagari che
la borghesia, che in tempi duri va al sodo, lo getti nel fango. Si avrebbe così, co-
meèsuccessonel '20 e nel '30, che la nuova cultura la fa la borghesia, mentre il
movimento operaio si attarda ad impadronirsi di tutta quella vecchia. Un sapere
proletario di massa si costruisce invece a partire da quei germi, che abbiamo ac-
cennato sopraesserepresenti nelle lotte e nella storia del movimento di massa. È
solo intorno ad essi che si possonocoagulare forme di conoscenza, che permetto-
no nuove forme di dominio sulla produzione, non più di profitto ma di valore
d'uso, e sul proprio contesto di vita. Se questi frammenti potenziali non si sono
ancora rappresi col tessuto sociale per formare una cultura nel senso pieno del
termine — un misto tra il controllo del proprio futuro ed il dominio sul contesto
di vita e sulla produzione — è perché il processo va avanti con la rottura dello
stato e l'affermarsi del potere politico della classeoperaia. Ogni cultura «alterna-
131
















