
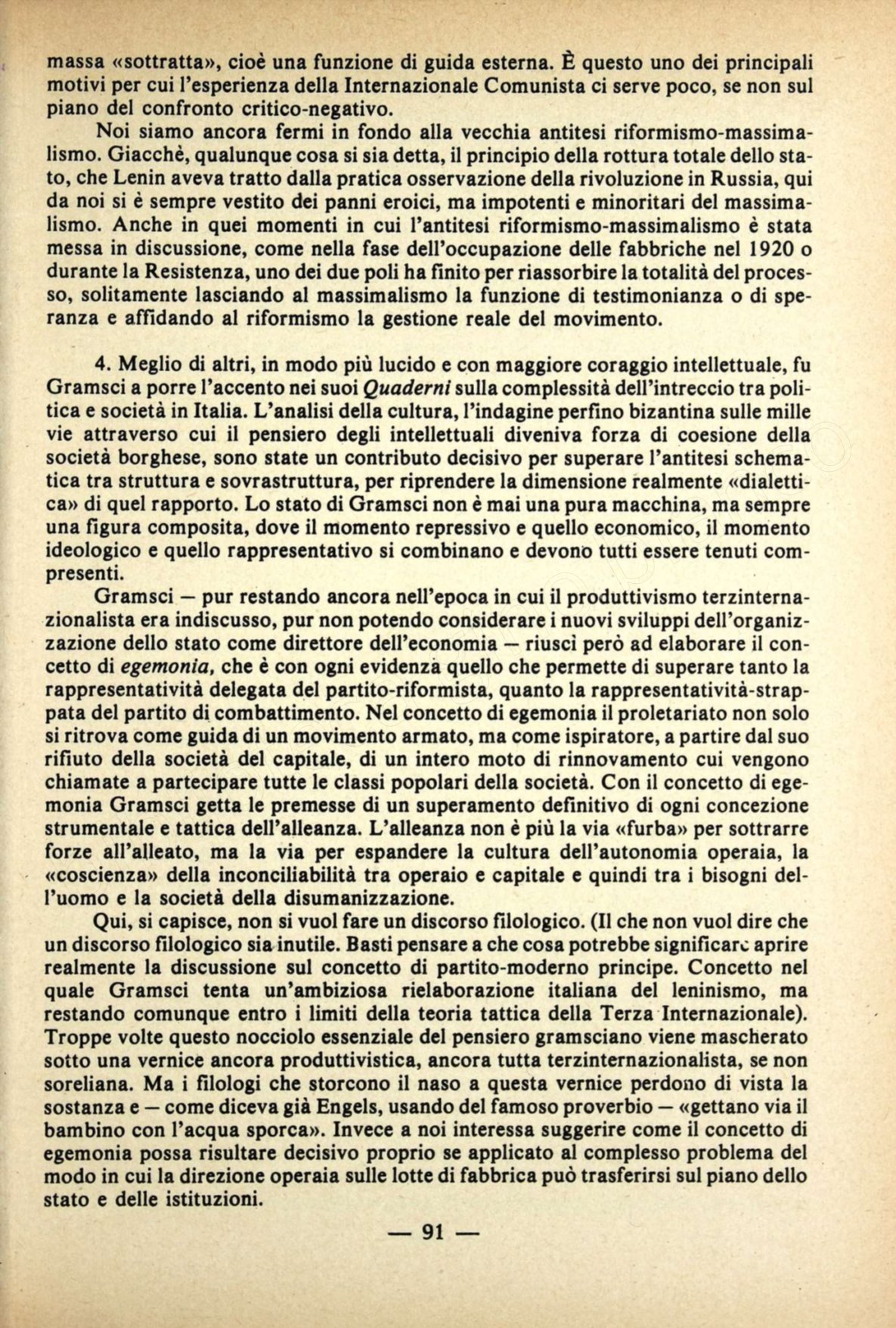
massa «sottratta», cioè una funzione di guida esterna. É questo uno dei principali
motivi per cui l'esperienza della Internazionale Comunista ci serve poco, senon sul
piano del confronto critico-negativo.
Noi siamo ancora fermi in fondo alla vecchia antitesi riformismo-massima-
lismo. Giacchè, qualunque cosasi sia detta, il principio della rottura totale dello sta-
to, che Lenin aveva tratto dalla pratica osservazione della rivoluzione in Russia, qui
da noi si è sempre vestito dei panni eroici, ma impotenti e minoritari del massima-
lismo. Anche in quei momenti in cui l'antitesi riformismo-massimalismo è stata
messa in discussione, come nella fase dell'occupazione delle fabbriche nel 1920 o
durante la Resistenza, unodei due poli ha finito per riassorbire la totalità del proces-
so, solitamente lasciando al massimalismo la funzione di testimonianza o di spe-
ranza e affidando al riformismo la gestione reale del movimento.
4. Meglio di altri, in modo più lucido e conmaggiore coraggio intellettuale, fu
Gramsci a porre l'accento nei suoi
Quaderni
sulla complessità dell'intreccio tra poli-
tica esocietà in Italia. L'analisi della cultura, l'indagine perfino bizantina sullemille
vie attraverso cui il pensiero degli intellettuali diveniva forza di coesione della
societàborghese, sono state un contributo decisivo per superare l'antitesi schema-
tica tra struttura e sovrastruttura, per riprendere la dimensione realmente «dialetti-
ca» di quel rapporto. Lo stato di Gramsci nonèmai una puramacchina, masempre
una figura composita, dove il momento repressivo e quello economico, il momento
ideologico e quello rappresentativo si combinano e devono tutti essere tenuti com-
presenti.
Gramsci—pur restando ancora nell'epoca in cui il produttivismo terzinterna-
zionalista era indiscusso, pur nonpotendo considerare i nuovi sviluppi dell'organiz-
zazione dello stato come direttore dell'economia—riuscì però ad elaborare il con-
cetto di
egemonia,
che è con ogni evidenzit quello che permette di superare tanto la
rappresentatività delegata del partito-riformista, quanto la rappresentatività-strap-
pata del partito di combattimento. Nel concetto di egemonia il proletariato nonsolo
si ritrova comeguida di unmovimento armato, macome ispiratore, a partire dal suo
rifiuto della società del capitale, di un intero moto di rinnovamento cui vengono
chiamate a partecipare tutte le classi popolari della società. Con il concetto di ege-
monia Gramsci getta le premesse di un superamento definitivo di ogni concezione
strumentale e tattica dell'alleanza. L'alleanza nonè più la via «furba» per sottrarre
forze all'alleato, ma la via per espandere la cultura dell'autonomia operaia, la
«coscienza» della inconciliabilità tra operaio e capitale e quindi tra i bisogni del-
l'uomo e la società della disumanizzazione.
Qui, si capisce, non si vuol fare undiscorso filologico. (Il chenon vuol dire che
undiscorso filologico sia inutile. Basti pensareachecosapotrebbe significare aprire
realmente la discussione sul concetto di partito-moderno principe. Concetto nel
quale Gramsci tenta un'ambiziosa rielaborazione italiana del leninismo, ma
restando comunque entro i limiti della teoria tattica della Terza Internazionale).
Troppe volte questo nocciolo essenziale del pensiero gramsciano vienemascherato
sotto una vernice ancora produttivistica, ancora tutta terzinternazionalista, senon
soreliana. Ma i filologi che storcono il naso a questa vernice perdono di vista la
sostanzae—come diceva già Engels, usandodel famoso proverbio—«gettano via il
bambino con l'acqua sporca». Invece a noi interessa suggerire come il concetto di
egemoniapossa risultare decisivo proprio se applicato al complesso problema del
modo in cui la direzione operaia sulle lotte di fabbrica può trasferirsi sul piano dello
stato e delle istituzioni.
91
















